 Pubblichiamo un saggio “a puntate” di Giovanni Mazzetti, per approfondire la questione della riduzione dell’orario e delle redistribuzione del lavoro, passaggi necessari e forse obbligati dello sviluppo e crisi del sistema capitalistico.
Pubblichiamo un saggio “a puntate” di Giovanni Mazzetti, per approfondire la questione della riduzione dell’orario e delle redistribuzione del lavoro, passaggi necessari e forse obbligati dello sviluppo e crisi del sistema capitalistico.
tratto da REDISTRIBUIRE IL LAVORO: Formazione online – Periodico di formazione on line a cura del centro studi e iniziative per la riduzione del tempo individuale di lavoro e per la redistribuzione del lavoro sociale complessivo.
E se il lavoro fosse senza futuro?
Perché la crisi del capitalismo e quella dello stato sociale trascinano con sé il lavoro salariato (I Parte)
Quaderno Nr. 3/2016
Il nostro percorso di formazione richiede una strutturazione. Per questo pubblichiamo, in sequenza, un testo a dispense, dal titolo E se il lavoro fosse senza futuro? Nell’insieme si tratta di cinque dispense, nelle quali viene ricostruita su un piano storico e teorico l’evoluzione che ci ha condotto alla situazione in cui ci troviamo.
Non tutti sanno che a metà anni Novanta ci fu un timido accenno ad un’apertura verso il riconoscimento della crescente difficoltà di riprodurre il rapporto di lavoro salariato. Un timido accenno che non riuscì a determinare alcun cambiamento sostanziale nei confronti del problema della disoccupazione nemmeno in quei paesi, come la Francia, che con una riduzione generalizzata dell’orario di lavoro sembravano aver imboccato la via verso il riconoscimento del nuovo stato delle cose.
La prima parte, pubblicata oggi, si riallaccia al dibattito dell’epoca e cerca di rievocare il problema per come veniva percepito all’epoca

Parte prima:
Il posto del lavoro salariato
Introduzione
“Viviamo in un universo dove molti individui, a torto o a ragione, si sentono bloccati, o paralizzati, in tutte le loro aspirazioni, ostacolati nel realizzare i loro obiettivi più legittimi.”(René Girard 2004)
“C’era la volontà, ma mancava la capacità.” (Karl Marx 1844)
“Nel nostro attuale stadio di sviluppo culturale esistono concetti che afferriamo con l’intuito ma non arriviamo ad esprimere con le parole.” (Nicholas Humphrey 1992)
Chi, tra venti o trenta anni, cercherà di descrivere la fase storica che noi, individui del mondo sviluppato, stiamo attraversando oggi si troverà di fronte un fenomeno apparentemente inspiegabile. La grande industria ha da lungo tempo raggiunto e superato il culmine della sua fioritura, e viene sempre più sostituita dai servizi come pilastro dello sviluppo (1). Dunque un fenomeno preconizzato da Marx agli albori dell’industrializzazione – quando aveva sostenuto che l’espansione dell’industria sarebbe inevitabilmente sfociata in una situazione nella quale “la creazione della ricchezza reale sarebbe venuta a dipendere sempre meno dal tempo di lavoro e dalla quantità di lavoro impiegato e sempre di più dalla potenza degli agenti messi in moto nel lavoro”, e cioè dalla qualità di quest’ultimo – si è concretamente avverato. Il fattore determinante della produzione, come tutti ormai riconoscono, è infatti diventato “lo sviluppo della scienza ed il progresso della tecnica”. Ma tutto ciò non si è accompagnato ad un mutamento sociale che, sempre ad avviso di Marx, avrebbe dovuto intrecciarsi con quello tecnico, e avrebbe dovuto riguardare il modo in cui viene sperimentato l’arricchimento e viene reso possibile l’ulteriore sviluppo. Se la ricchezza aggiuntiva viene a dipendere sempre meno dalla quantità di lavoro, è infatti evidente che “il tempo di lavoro erogato non può più essere ciò che la misura”. Questa misura andrebbe piuttosto ricercata nel tempo che viene reso “disponibile” per ognuno grazie allo sviluppo della “produttività”; uno sviluppo che può essere ulteriormente favorito proprio dalla maggiore libertà economica acquisita. Ma ai nostri giorni l’orientamento prevalente muove in direzione decisamente opposta. Coloro i quali lavorano si vedono imporre prolungamenti della giornata lavorativa e intensificazione dei ritmi; chi sta per andare in pensione viene ricacciato indietro e costretto a lavorare ancora per anni, anche se il mondo della produzione dichiara di non avere più bisogno di lui; chi trova un lavoro precario e malpagato è spesso costretto ad accollarsene un altro per la miserabile retribuzione che riceve. Insomma, con l’appello ai sacrifici per la crescita, si continua ad agire come se la produzione della ricchezza continuasse a dipendere quasi esclusivamente dalla quantità di lavoro erogato. D’altra parte, la possibilità dello sviluppo viene evocata attraverso il ricorso a fantomatiche politiche di “liberalizzazione (2)” che, poggiando sull’inevitabile reintroduzione di una radicale concorrenza tra lavoratori (3), avrebbero come unico risultato di far leva su un tentativo di accrescere ulteriormente la massa del lavoro erogato, senza che a ciò corrisponda necessariamente un’espansione dei bisogni soddisfatti. Nessuno discute se e come trovare un impiego produttivo per il tempo che non si riesce a trasformare nuovamente in lavoro, appunto perché quest’uso del tempo appare privo di valore e necessariamente improduttivo; una convinzione che spinge a credere che una sua espansione finirebbe con l’impoverire la società. (4)
Se a questa situazione si accompagnasse un senso di appagamento, o anche solo di accettazione, non ci sarebbe ovviamente alcuna recriminazione da fare. Ma, nonostante lo sviluppo reso possibile dall’espansione della grande industria abbia permesso, da un lato, enormi conquiste materiali, la società è precipitata, dall’altro lato, in un grave stato d’insoddisfazione (5), di disorientamento e d’impotenza. C’è dunque da interrogarsi, senza aspettare che qualcuno dei posteri lo faccia quando ormai saremo polvere.
Miseria e potenza, ricchezza e impotenza
Ricostruiamo brevemente l’evoluzione storica. Da una situazione nella quale, appena un secolo fa, i più iniziavano a lavorare tra i dieci e i quattordici anni, per sfamarsi con poco più di un tozzo di pane 6, si è passati ad un’altra nella quale si comincia a lavorare mediamente intorno ai venticinque anni, magari soffrendo di un problema di sovrappeso corporeo. Le ore erogate annualmente da chi entra nel mondo della produzione sono precipitate, in Europa, da oltre tremila a circa mille e cinquecento/mille e settecento (7). La durata della vita media è nel frattempo cresciuta di circa trent’anni, e continua a crescere. La scolarizzazione superiore ha coinvolto milioni di persone, in una misura che, appena tre generazioni fa, con un terzo della popolazione analfabeta e i tre quinti con le sole elementari alle spalle, sarebbe apparsa inimmaginabile. La disponibilità di reti di comunicazione, di libri, di quotidiani, di riviste, e di altri strumenti di informazione è cresciuta in maniera ancora più esponenziale. Se, com’è stato efficacemente riassunto da Claudio Gnesutta, “l’aumento della capacità produttiva, misurata dallo stock di capitale fisso disponibile nell’economia, presenta (negli USA) una dinamica superiore a quella del prodotto … ed era solo del 5% del flusso del prodotto nel 1812, del 50% nel 1913, per sfiorare il 90% negli anni Novanta del XX secolo” 8, ci troviamo di fronte a due “mondi” completamente diversi! Dal prevalere della miseria, siamo entrati in una realtà caratterizzata da un’abbondanza inimmaginabile appena qualche generazione fa. Eppure il senso di frustrazione nei confronti delle difficoltà sociali che sono emerse negli ultimi tre decenni non è molto inferiore (9) rispetto a quello che, all’inizio del Novecento, attanagliava i nostri poveri nonni in occasione delle precedenti crisi.
Basta, infatti, interrogare uno qualsiasi dei lavoratori disoccupati o precari, che ormai in Europa cominciano a contarsi a decine di milioni, sul perché della situazione in cui si trova, senza ricevere una risposta sensata. Non solo non sa, in genere, spiegarsi le ragioni delle incertezze e delle angosce che sono piombate sulla sua esistenza. Ma, nel migliore dei casi, si rifugia nell’argomentazione più banale, imputando la sua “sfortuna” alla prevaricazione e all’arbitrio altrui. Non cerca una comprensione della dinamica dei rapporti sociali che evolvono contro di lui; si accontenta di trovare dei colpevoli ai quali imputare le sue – per lui inspiegabili – sofferenze. Nel caso peggiore condivide invece passivamente l’ideologia con la quale si cerca di convincerlo che non ci sarebbe una via alternativa alla precarietà, perché dovrebbe adeguarsi a circostanze nuove, più miserevoli di quelle di prima, del cui sopravvenire lui ed ancor più i suoi genitori sarebbero immediatamente responsabili 10. I padri e le madri non fanno, d’altronde, eccezione rispetto ai loro stessi figli. Nonostante l’età, nonostante l’esperienza, nonostante siano al lavoro da quindici, venti o trenta anni o addirittura siano in età pensionabile, subiscono allungamenti del tempo di lavoro, mutamenti nei rapporti gerarchici di potere della vita quotidiana, drastici ridimensionamenti delle retribuzioni e dei trattamenti pensionistici, oltre a significativi tagli di tutti i pubblici servizi. Spesso protestano, manifestando il loro malcontento anche in forme esteriormente grandiose 11, ma non per questo riescono a sottrarsi alla deriva sociale in atto da quasi trent’anni.
Che fine ha fatto tutta la ricchezza aggiuntiva della quale come individui abbiamo goduto grazie allo sviluppo intervenuto dalla Seconda guerra mondiale? Che fine ha fatto l’enorme scolarizzazione della quale siamo stati partecipi? Che uso abbiamo fatto del maggior tempo che abbiamo conquistato per ciascuno di noi, rispetto al lavoro senza fine dei nostri nonni? Ognuno di noi ricorda il giorno della sua prima comunione o della sua prima vittoria sportiva, l’incontro col suo primo amore, il momento in cui si è laureato, il giorno del suo matrimonio, quando gli sono nati i figli, così come ricorda i giorni tristi delle sventure personali e del lutto. Perché non ha fissato in alcun modo i momenti nei quali la sua vita come individuo sociale ha subito, nel bene o nel male, cambiamenti altrettanto profondi di quelli nei quali si riconosce come individuo particolare? Perché il contesto sociale si è trasformato in un vero e proprio labirinto, nel quale si dissolvono quasi tutti i comuni riferimenti passati e diviene praticamente impossibile ogni anticipazione positiva dell’avvenire?
Come cercare un ordine nel disordine
Mentre mi ponevo queste domande, in un modo che può essere facilmente considerato retorico, sono stato folgorato dai risultati di una ricerca 12 su una piccola popolazione india della giungla amazzonica, i Piraha. Secondo gli antropologi che hanno vissuto con loro, nella cultura di quella tribù esistono solo tre grandezze aritmetiche – uno, due, molti – ed essi sembrano incapaci di apprendere qualsiasi altra forma di numerazione più articolata. Ad esempio non sanno distinguere due disegni nei quali sono raffigurati rispettivamente dieci pesci e cento pesci, perché entrambi rientrano nella categoria dei “molti”, nell’ambito della quale per loro non c’è differenza nella quantità di pesci. Questo fenomeno – che è molto meno lontano da noi di quanto si potrebbe ingenuamente credere, viste le grandi difficoltà con le quali, ad inizio Ottocento, si è passati al sistema metrico decimale (13) – mi ha ricordato l’aspetto centrale di ogni processo di apprendimento, ed esattamente che c’è sempre un particolare modo di presentarsi dell’esperienza,, che consente o impedisce di elaborare le specifiche rappresentazioni attraverso le quali si struttura ogni particolare cultura. Il processo di apprendimento al quale siamo abituati – che fa parte, cioè, del nostro consueto modo di conoscere, e che costituisce il risultato della particolare acculturazione alla quale siamo stati sottoposti – comporta un confronto con problemi che sono già stati formulati. In questo caso, si tratta solo di appoggiarsi a soluzioni più o meno articolate, nell’ambito di una forma di pensiero che guida il cammino dell’imparare. Come ha spiegato Lurija (14), la coscienza non può essere concepita come un “campo aperto”, nel quale la mente svolge liberamente i suoi processi. Al suo stesso emergere essa prende già una forma e un contenuto corrispondenti alla determinata cultura di cui sono espressione, forma e contenuto che strutturano i processi mentali, delimitando ciò che è spontaneamente concepibile.
Ci sono però problemi che non sono formulabili all’interno del modo di pensare già dato, e che pure ci piombano addosso con l’evolvere della vita sociale. In questi casi si tratta di sviluppare una conoscenza diversa, la cui necessità viene apparentemente (15) imposta dal di fuori, ma che dobbiamo elaborare perché, grazie allo sviluppo, siamo finiti su un terreno sconosciuto, che non sappiano ancora calpestare. In questi casi è la formulazione stessa del problema a costituire un problema. Vale a dire che non sappiamo ancora come pensare, come rappresentare ciò che eventualmente cerchiamo di comprendere. Analogamente ai Piraha, che non riescono a confrontarsi spontaneamente con un “mondo” fatto dai numeri decimali, a causa dell’astrattezza di questo sistema (16), non siamo in grado di confrontarci spontaneamente con alcune delle difficoltà causate dall’evoluzione del contesto sociale che è scaturito dal nostro stesso arricchimento. E se vogliamo sperare di fare un passo avanti dobbiamo avere la pazienza di imparare a misurarci con circostanze che, pur costituendo un prodotto delle generazioni precedenti e della nostra stessa azione, non conosciamo adeguatamente. In un certo senso dobbiamo riconoscere che, purtroppo, siamo diventati degli analfabeti nei riguardi della stessa dinamica sociale nella quale siamo inseriti.
Dal “futuro promessa” al “futuro minaccia”
Non a caso la maggior parte dei cittadini dei paesi europei ha difficoltà a rispondere ad un quesito relativamente semplice (17): per quale ragione i padri fondatori della Repubblica italiana e di altri paesi europei moderni hanno sentito di dover sottolineare che, nel dopoguerra, la nuova società si stava costituendo come una “repubblica democratica fondata sul lavoro”? Cercavano forse banalmente di richiamare un fatto scontato e noto da tempi biblici, e cioè che “il continuo lavorare e produrre è alla base del mondo in cui viviamo”? Volevano forse enfatizzare principi astratti, che costellano idealisticamente il firmamento delle utopie sociali ? O intendevano piuttosto chiamare in causa qualcosa di storicamente più significativo? Un mutamento positivo nel modo stesso dell’esistenza collettiva, che i costituenti hanno additato come un “valore”, perché le conquiste dell’epoca consentivano di spingere praticamente l’evoluzione dell’organismo sociale al di là dei suoi precedenti limiti, e di costruire un futuro diverso dal passato, basato sulla certezza dell’erogazione del lavoro possibile? (18)
Su questa base, con il lavoro come soggetto (19) di uno sviluppo straordinario, avrebbe dovuto essere costruita una realtà nuova, contraddistinta da un miglioramento nelle condizioni di vita inimmaginabile appena qualche generazione prima. Una realtà che è stata effettivamente costruita fino alla metà degli anni Settanta, ma che ha appunto rappresentato un “mondo nuovo”, col quale il lavoro ha mostrato di avere una difficoltà ad interagire produttivamente. (20)
A mezzo secolo di distanza dal momento in cui questo ruolo centrale del lavoro è stato acquisito l’edificio sociale scricchiola così piuttosto rumorosamente, evidenziando che quelle fondamenta non riescono più a reggere saldamente tutto ciò che (di positivo) vi è stato eretto sopra, con la caduta di tanto in tanto di qualche istituto essenziale. D’altronde, le concezioni del mondo che hanno mediato quel passaggio non sono diventate un patrimonio individuale, e dunque non riescono a rinsaldare i legami sociali e ad indirizzare il procedere collettivo. Non solo le (passate) conquiste del lavoro non riescono più a guidare il cammino della società, ma non sono nemmeno in grado di tener ferme le stesse acquisizioni dello Stato sociale, che pure hanno costituito il pregevole risultato di lunghe lotte e di grandi sacrifici. Cercando di descrivere questo collasso sociale due studiosi francesi hanno sostenuto che la società moderna, “oltre ad aver perso nel giro di una sola generazione il proprio fondamento principale, l’ha visto rovesciarsi nel suo contrario” (21). Il “futuro promessa di trent’anni fa (22) è cioè diventato il futuro minaccia di oggi”.
Le riflessioni esposte nelle pagine che seguono sono state sollecitate proprio da quei continui cedimenti e, soprattutto, dall’infelice stato in cui, assurdamente, versano oggi coloro che si muovono nel mondo del lavoro. Un dramma che, seppure con diversa intensità, investe sia le società economicamente sviluppate che i paesi sottosviluppati, e talvolta raggiunge livelli che echeggiano quelli danteschi dell’alba del capitalismo 23. Se e quando riescono finalmente a superare le forche caudine della disoccupazione strutturale, i giovani che cercano un impiego diventano spesso oggetto di angherie, oltre ad essere normalmente privati di una sostanziale fiducia nell’avvenire. Dal canto loro i lavoratori avanti negli anni, se non sono ancora stati espulsi brutalmente dal processo produttivo, sono sempre più additati come dei privilegiati da sottoporre al pubblico ludibrio (24). La loro colpa? Il ragionevolissimo rifiuto di essere ricacciati indietro di mezzo secolo e di sopportare quelli che vengono erroneamente considerati come “necessari sacrifici”(25). Un rifiuto che, non accompagnandosi, in genere, ad una consapevolezza sul come contrastare questa deriva, finisce però con l’apparire come un pio, quanto inesaudibile, desiderio (26). Ma anche quella metà dei lavoratori che ancora non è stata completamente travolta dal regresso intervenuto negli ultimi venticinque anni, subisce sistematiche intensificazioni dei ritmi, continui prolungamenti del tempo di lavoro, drastici tagli delle retribuzioni reali e drammatici peggioramenti delle condizioni ambientali nelle quali svolge la propria attività. Oltre a dover spesso sopportare stupidi sermoni (27) sul come riconciliarsi pacificamente con la pessima condizione nella quale è stata precipitata.
A dar conto di come si è giunti a questa situazione è dedicata la prima metà di questo lavoro.
Perché la volontà di cambiare non basta
Qua e là cominciano, però, a manifestarsi i primi timidi segni che la misura è ormai colma, e che la frustrazione sta raggiungendo un livello tale da generare il bisogno di un radicale cambiamento. D’altra parte, il collasso finanziario ed economico in corso rende impossibile la pura e semplice continuazione delle strategie economiche sin qui seguite. Sembra cioè che, seppure ancora oscurata da nubi, all’orizzonte si intraveda l’alba di una nuova fase storica, che metta finalmente a tacere l’ideologia neoliberista, nonostante i suoi paladini stiano ancora cercando di raccogliere gli ultimi stracci prima di abbandonare la scena. In questi momenti di passaggio è tuttavia necessario che non si cada nell’errore di assecondare le spinte puramente reattive e di imboccare le stesse vie lungo le quali si è giunti alla sciagurata situazione dalla quale si cerca di uscire. 28 Troppe volte, dopo l’inizio della crisi, ogni segno di protesta è stato confuso con l’inizio di un capovolgimento di tendenza. Ma la volontà di cambiare, anche quando si manifesta con forza, non contiene in sé necessariamente la capacità di farlo e la protesta costituisce più il segno del bisogno di cambiamento, che l’indicazione della concreta via attraverso cui attuarlo. Può così accadere, com’è ricorrentemente accaduto negli ultimi trent’anni, che non si sia in grado di comprendere i problemi sociali che hanno determinato la crisi e la lotta sfoci in mera ribellione, risolvendosi in drammatiche sconfitte, che generano solo ulteriore rassegnazione. 29 O, viceversa, che si finisca col condividere molti luoghi comuni dei conservatori, sull’onda di un malinteso postmodernismo. Insomma, se ci si batte senza interrogarsi sulle forme di vita ereditate e sui problemi che hanno generato si finisce col muoversi all’intero di quella specifica dinamica che Freud ha definito come “coazione a ripetere”, che rende incapaci di concepire un’alternativa e risospinge nella situazione di impotenza dalla quale si cerca di emanciparsi. Ancora peggio è quando si crede di poter imboccare bambinescamente una via meramente conciliativa di fuoriuscita dalla crisi (30); come se le difficoltà scaturissero realmente solo dal contrasto delle volontà, piuttosto che dall’evoluzione degli stessi rapporti sociali e dai mutamenti intervenuti.
Per rendere con un esempio concreto come questa tendenza alla banalizzazione del conflitto poggi su una grave amnesia della storia recente, vorrei qui ricordare il caporedattore economico di un giornale romano che, in occasione di un confronto sulle pensioni, ha dato sfogo ad un approccio ingenuamente volontaristico: “gli anziani di oggi”, ha detto, “sono molto ‘fortunati’; perché concentrare la nostra attenzione in loro difesa? Dovremmo invece pensare ai giovani ‘che sono particolarmente sfigati’. I sindacati”, ha aggiunto, “saranno credibili solo quando organizzeranno manifestazioni di piazza a sostegno dei giovani, piuttosto che a sostegno degli anziani”. Il signore in questione, che pure ha attraversato da adulto l’ultimo mezzo secolo, ha evidentemente memoria corta, e ha dimenticato che nel corso degli anni Settanta ed Ottanta il movimento dei lavoratori ha cercato in ogni modo di afferrare l’altro bandolo della matassa, rispetto a quello che ha cercato di afferrare negli ultimi anni con la lotta sulle pensioni. I sindacati si sono infatti strenuamente battuti con numerosissime manifestazioni di massa, con proposte legislative (le liste speciali), con tentativi di organizzazione istituzionale dei giovani disoccupati (le leghe), con compromessi normativi (i contratti di formazione-lavoro), con ricerche, convegni e dibattiti, che hanno sortito qualche sporadico effetto positivo, ma che nel medio periodo sono sfociati in un drammatico fallimento generale. E il loro impegno passato deve costituire un punto fisso, dal quale non possiamo prescindere mentre cerchiamo di muoverci nel labirinto nel quale siamo precipitati. Così come le residue resistenze ai tagli e ai sacrifici in ogni campo – sanità, scuola, assistenza sociale, ecc. – debbono essere valutate positivamente, senza imputarle a un disinteresse per il resto.
Attribuire l’attuale situazione di sofferenza ad una mancata volontà di battersi, da parte delle forze sociali che agognano al cambiamento, è, dunque, del tutto errato e contribuisce all’accrescersi del disorientamento. Al contrario, se si vuole veramente procedere oltre, occorre analizzare perché alle lotte passate, nelle quali il problema della disoccupazione giovanile era al centro di una forte azione sociale, è a poco a poco subentrato uno svuotamento, che ha impedito di continuare a praticarle nelle forme date, in quanto accentuavano il senso di impotenza. I giovani non sono cioè degli “sfortunati”, dei penalizzati dalla “lotteria” della vita, né le vittime di un qualsiasi sopruso o indifferenza, bensì i primi soggetti investiti da una dinamica che, dilagando ben presto in tutta la società, ha comportato la progressiva esautorazione dell’embrione di potere che il lavoro salariato aveva conquistato a partire dalla fine della Seconda guerra mondiale 31. Un potere che si è dissolto proprio perché, “concependo se stesso in forma unicamente politica”, pretendeva ingenuamente “di scorgere il fondamento di tutti i mali nella volontà” negativa altrui, alla quale sarebbe bastato contrapporre la propria volontà positiva e i propri valori. Se negli ultimi anni si è cercato di attestarsi in difesa delle pensioni – sulle quali si può dire tutto meno che rappresentino una “fortuna” – è stato solo perché esse costituivano l’ultimo baluardo nel quale un residuo sostanziale di quel potere continuava ad esprimersi. Solo salvando questo baluardo, ma ponendo anche fine alla rappresentazione volontaristica del contrasto, si poteva sperare di tornare a battersi sui fronti che sono stati persi in passato (32). Anche se il senso di impotenza dilagante sta investendo ampiamente anche questo campo.
Le basi di un nuovo potere
Ma se la via volontaristica è preclusa, come individuare un potere nuovo capace di mediare lo sviluppo futuro attraverso l’emancipazione del lavoro salariato? Certamente non con un ottimistico appello alla “società civile” che, sostituendosi alle forze politiche, dovrebbe essere in grado di muoversi spontaneamente in modo adeguato “nell’organizzazione diretta della vita e delle relazioni sociali”. 33 Il disorientamento politico non è infatti qualcosa di diverso dal disorientamento della società. E la società non può trovare il bandolo della matassa che conduce alla soluzione dei suoi stessi problemi riproduttivi senza esprimerlo anche in forma politica.
Da questo punto di vista, mi è sembrato che la diatriba sulla “fine (o meno) del lavoro” costituisse il terreno appropriato per sviscerare alcune delle problematiche che, in questa fase storica, condizionano sotterraneamente l’evoluzione sociale in quasi tutte le sue manifestazioni, incluse quelle della società civile. Prendendo le mosse da quella diatriba, ho cercato di ripercorrere quella che ho definito come “l’epoca del lavoro salariato”. La disoccupazione strutturale, la caduta dei salari reali, l’attacco alle pensioni, il dilagare della precarietà, lo stesso smantellamento dello Stato sociale, possono essere tutti riletti alla luce di questa tematica che, per qualche anno ha embrionalmente preso corpo, senza riuscire però ad imporsi come problema collettivamente condiviso. Tant’è vero che oggi il dibattito sembra essersi concluso con la tacita liquidazione di quel filone di pensiero e con il definitivo accantonamento di qualsiasi ipotesi di una riduzione dell’orario di lavoro (34). Ma un disoccupato che non sa argomentare su questo terreno è già un disoccupato perdente. Un pensionato che non sa confrontarsi con questo problema è già un pensionato relegato all’angolo. Un lavoratore che non sa dire nulla sulle prospettive future del lavoro è già un soggetto che non sa anticipare gli effetti della propria partecipazione al particolare modo di produzione nel quale è immerso, e dunque non sa incidere sulle contraddizioni che lo caratterizzano (35). Un sindacalista che non sa dar criticamente ragione dell’attuale debolezza del lavoro salariato è necessariamente un soggetto in malafede (36). Un politico progressista che prospetta retoricamente la possibilità di uno sviluppo sociale senza analizzare ciò che lo ostacola, limitandosi a ripetere nel nuovo secolo i luoghi comuni sull’innovazione, sulla flessibilità e sulla concorrenza che hanno prevalso nella prima parte del secolo scorso, è come un disco rotto che scoraggia ogni anelito partecipativo (37). Uno studente che pretende di acculturarsi senza approfondire perché la società in cui vive incontra crescenti difficoltà a riprodursi, è destinato ad acquisire un sapere del tutto inconsistente.
Se, come vedremo, “il lavoro in forma immediata sta cessando di essere la grande fonte della ricchezza” e ad essa si sta sostituendo, come possibile “pilone di sostengo di un (ulteriore arricchimento), lo sviluppo dell’individuo sociale”, ogni tentativo di restare sul terreno che ha prodotto buoni frutti nel passato, ma che è stato eroso dalla crisi, è destinato ad ottenere risultati miserevoli. I miseri risultati che stiamo, appunto, ottenendo con le lotte degli ultimi decenni. Ma per procedere altrimenti è necessario imparare a conoscere le forze in campo in maniera approfondita. Un approfondimento che ho cercato di fare nella seconda parte, tesa a cogliere le potenzialità di sviluppo insite nel “tramonto del lavoro salariato”.
Come ha sottolineato una studiosa che ha grandemente contribuito alla comprensione delle dinamiche sociali della modernità, il futuro è ormai entrato come elemento determinante della storia corrente 38 e senza la capacità di anticiparlo coerentemente si è disarmati. Vale a dire che non si contribuisce a fare la storia, bensì ci si limita a subirla. Per questo ho dedicato i miei sforzi a dipanare una matassa che serve a tessere la vita di ognuno, senza che la maggior parte di noi se ne renda conto. E nel farlo sono partito da un interrogativo apparentemente inquietante: per quale motivo, ragionando attorno al mondo nuovo che viene preparato dallo stesso sviluppo capitalistico, Marx ha contrapposto l’emergere dell’individuo consapevolmente sociale alla pura e semplice crescita ed egemonia del lavoro salariato? Quale differenza tra queste due forme dell’individualità sociale lo ha spinto ad una simile distinzione? Come si lega tutto ciò al tema politico e sociologico sollevato negli ultimi decenni da numerosi autori sulla “fine del lavoro”? E come si ripercuote tutto ciò sul “diritto al lavoro” sul quale è stata – politicamente – costruita la società moderna?
Se questo tentativo di approfondimento si rivelerà una fatica di Sisifo, la stanca ripetizione di una spinta utopistica a sbarazzarsi dei problemi che abbiamo, o consentirà un mutamento positivo nelle lotte future, proprio perché saprà fare coerentemente i conti con le difficoltà di cui soffriamo, dipenderà non solo dal valore analitico di ciò che verrò esponendo, ma anche da quanto la frustrazione attuale avrà educato i bisogni degli individui alla necessità di un nuovo orientamento sociale. Consentendo a chi anela ad un “mondo diverso” di assumersi il faticoso compito di individuare le condizioni per produrlo, anziché di limitarsi ad invocarlo.
Certo, per non rimanere aspiranti ad un mondo migliore e diventare, invece, suoi produttori occorre saper tollerare di confrontarsi con interrogativi che non si comprendono spontaneamente, con concetti che non costituiscono già parte integrate della propria coscienza sociale, con mediazioni riflessive che non si coltivano quotidianamente. Insomma si deve procedere alla ricerca di quel “soggetto del cambiamento”, che in molti a sinistra evocano, innanzi tutto misurando il bisogno e la capacità di cambiare se stessi. Per questo senza essere esploratore chi ci legge non potrà sperare di condividerci o di confutarci. Non avendo avuto nemmeno l’intuizione della propria impotenza, e del bisogno di elaborare concetti nuovi per comprendere la situazione nuova nella quale ci troviamo, dirà puramente e semplicemente che non trova alcun senso in quello che stiamo cercando di dire. E la confusione, la stanchezza e la noia che lo coglieranno costituiranno solo la misura di ciò che ci separa realmente da un altro mondo possibile.
LIBRO PRIMO
L’epoca del lavoro salariato
Parte prima
Dove siamo?
Capitolo primo
Le formulazioni intuitive del problema e la loro confutazione
“Le parole possono intromettersi tra noi e i nostri oggetti in innumerevoli e sottili maniere, se non ci rendiamo conto della natura della loro potenza”. (C.K. Ogden, I.A. Richards, 1923)
Nell’ormai vastissima letteratura psicologica sui problemi della comunicazione interpersonale viene riferito un episodio particolarmente emblematico di una questione che investe la nostra riflessione. Racconta la madre di un adolescente che, una volta, mentre usciva di casa per andare a far visita ad un’amica che abitava dall’altra parte della strada, chiese al figlio di assicurarsi, se avesse voluto raggiungerla, di “tirare la porta di casa dietro di sé”, cioè di accertarsi che fosse chiusa. Un’ora dopo, quando decise di seguire la madre, il giovane tirò via la porta dai cardini e la appoggiò al muro esterno dell’abitazione, lasciando l’ingresso completamente spalancato. Il ragazzo in questione era autistico, cioè incapace di quella relazione con il mondo circostante che è alla base della normale comunicazione. Ma non bisogna essere autistici per incontrare difficoltà ad interagire con gli altri. Ci sono infatti persone “sane” che recepiscono la comunicazione esattamente come viene; senza cogliere “la ricchezza dei significati spesso sepolti nel normale uso del linguaggio”, e così facendo non incontrano affatto le intenzioni di chi sta cercando di comunicare con loro 39. La ragione di questo appiattimento sulla lettera di ciò che viene detto è stata approfondita in molti studi, ed è stata sinteticamente espressa sostenendo che coloro che cadono in questa trappola soffrono, in genere, di una percezione monodimensionale del mondo, tutta ripiegata su se stessa. Essi mostrano quasi sempre un’incapacità di superare i test delle false credenze e non riescono a partecipare a giochi che richiedono finzioni. 40 Poiché non si rendono conto che altre persone possono nutrire convinzioni che non corrispondono alle loro conoscenze, anche quando quelle convinzioni trovano un probabile fondamento nell’esperienza di quegli individui, sono incapaci di immaginare altri mondi o che il mondo potrebbe essere diverso da come si è manifestato ai loro sensi. 41 In altri termini, questi soggetti agiscono come se il contesto fosse sempre ad una dimensione, e perciò intrinsecamente trasparente. Quello che loro “sanno” sarebbe quello che tutti sanno o, comunque, dovrebbero sapere, in quanto corrispondente a ciò che è.
Se e quando gli interlocutori muovono da una diversa conoscenza, e quindi interpretano il pensiero e l’interazione con l’ambiente in modo diverso da come questi soggetti li concepiscono, il loro ripiegamento impedirà di convenire che quello può essere un altro modo di cogliere la realtà, che rinvia ad un’altra possibile dimensione del dato storico e ad un’altra possibile prospettiva futura 42. Ed essi si sentiranno spinti a rimproverarli “di rigirare il mondo” 43. Questi individui pretendono cioè di essere creduti sulla parola, facendo riferimento solo a ciò che dicono e immaginano di dire, negando qualsiasi spazio a quella che è nota come interpretazione del messaggio. 44 Una “interpretazione” il cui bisogno scaturisce proprio dal fatto che, di norma, i mondi di coloro che dialogano 45 – o, se si vuole, le loro esperienze – non sono immediatamente coincidenti, e spesso si ignorano a vicenda. 46 Per dirla in breve, la forma di comunicazione in questione comporta un totale misconoscimento della problematicità del linguaggio e della non univocità delle forme del comportamento e della conoscenza che lo accompagnano. Inoltre non sa che qualsiasi comprensione muove dall’individuazione di ciò che ciascuno di noi non vede, ma l’altro sostiene di vedere, e quindi rende quella forma di esperienza che è nota come intuizione un qualcosa da sviscerare.
La controversia sulla “fine” del lavoro.
Il breve rinvio a questa particolare modalità di interazione umana ci torna utile per avviare il nostro ragionamento sulla controversia che, per qualche anno, ha alimentato le braci che hanno consumato i resti della sinistra, inerente, appunto, alla cosiddetta “fine del lavoro”. Una controversia che, pur essendo vitale per le prospettive di qualsiasi alternativa sociale, ha finito col precipitare nel dimenticatoio. Richiamiamola dapprima nei termini usati allora da un autore che più di altri ha avanzato riserve nei confronti di questa formula. Riccardo Bellofiore, riprendendo una posizione già espressa nel 1979 47, è intervenuto nella fase acuta del dibattito sostenendo che, nel corso degli anni Novanta, “l’analisi della globalizzazione e del postfordismo 48 si prolungava (spontaneamente) in quella della fine del lavoro; e i pochi critici venivano visti come non troppo simpatici cantori del bel tempo andato. Ora, che il lavoro ‘garantito’ dell’era keynesiana fosse ormai agli sgoccioli”, ha aggiunto, “non era certo una novità: ma che il tempo di lavoro e la centralità della condizione lavorativa fossero avviate all’estinzione è qualcosa che”, a suo avviso, “è stato smentito drasticamente negli anni successivi”.49 50 Nello stesso periodo, dalla Svizzera, interveniva anche Christian Marazzi per affermare che “l’utopia della ‘fine del lavoro’, che molti hanno visto come realistica grazie alle nuove tecnologie a risparmio di lavoro, è un esempio di inadeguatezza delle categorie politiche. … La sopravvivenza della storia di questo secolo, l’immanenza, nel linguaggio monetario, del lavoro nella sua accezione classica di ‘lavoro socialmente necessario’, ci hanno portato altrove rispetto alle utopie della ‘fine del lavoro’” 51. Con un linguaggio decisamente diverso, ma procedendo sulla stessa falsariga, Riccardo Antunes, in un testo che ha avuto ampia diffusione in America Latina, ha sostenuto: “possiamo concludere [contro la tesi di una tendenza alla fine del lavoro] che la classe operaia non sparirà tanto rapidamente e, cosa fondamentale, che non si può prospettare, neanche in un lontano futuro, alcuna possibilità di eliminare la classe-che-vive-di-lavoro”.52 Ciò perché “le macchine intelligenti non possono sostituire completamente i lavoratori” realizzando “la completa estinzione del lavoro vivo”. Senza risalire troppo indietro negli anni, ricordiamo poi una drastica presa di posizione di Bruno Trentin che, seguendo lo stesso filone emotivo, ha affermato: “tutta una serie di dati empirici dimostrano che la vera prospettiva non è tanto la scomparsa del lavoro, almeno nel medio-lungo termine, quanto quella di una sua redistribuzione selvaggia …. Non c’è il segno di una scomparsa del lavoro, ma di una tendenza alla sua monopolizzazione da parte dei ceti e dei gruppi sociali in grado di accaparrarsi la maggior quantità di sapere nella società” 53.
D’altra parte, alcuni dei migliori ricercatori che affiancano il sindacalismo di base non si sono sottratti al procedere della corrente. Per loro si sarebbe trattato di “forzare l’orizzonte a partire dal superamento dei confini sociali fra classe operaia propriamente detta, gli intellettuali, nuove figure del lavoro, del lavoro negato, del non lavoro, e di accomunare questi gruppi sociali nella loro lotta per l’emancipazione sociale; ritrovandosi nei fatti nel conflitto capitale-lavoro, superando nella lotta gli schemi dell’ormai, decretata da alcuni studiosi anche di origine marxista, fine del lavoro. Ma quale fine del lavoro! Sempre più è viva l’analisi scientifica di Marx sul lavoro salariato, sulla ‘proletarizzazione’ ed immiserimento, assoluto e relativo, di strati sempre maggiori delle società a capitalismo avanzato; per non parlare dei livelli di schiavitù, di feudalesimo e di miseria assoluta del Terzo e Quarto Mondo. Gli ex marxisti, che oggi amano definirsi critici del marxismo per cadere nelle braccia del neoliberismo, che sparlano di fine del lavoro, pongono falsi problemi. Nella migliore delle ipotesi si tratta di una scorretta lettura della realtà, che ripercorre i vecchi schemi sociali, economici e teorici: quelli liberisti e neoliberisti, quelli che vogliono il capitalismo come fine della storia.” 54 Elvio Dal Bosco, nel suo bel libro sulla globalizzazione 55, pur senza entrare nel merito, ha preso a sua volta le distanze, esclamando: “altro che fine del lavoro!”. Una posizione subito condivisa da Alberto Burgio, che, giunto per ultimo, quando ormai il dibattito si stava esaurendo, ha dovuto esagerare qualificando la teoria della fine del lavoro come “il mito dei miti, che ispira la fine della lotta delle classi … Un ciarpame di cui occorrerebbe far piazza pulita … Perché consente di far piazza pulita dei più pesanti contraccolpi del liberismo sul lavoro” 56. Anche taluni giornalisti della sinistra meno accomodante, con alle spalle una lunga esperienza, hanno civettato talvolta con il fastidio prevalente nei confronti della formula della “fine del lavoro”. Ha scritto ad esempio Valentino Parlato, in occasione dello sciopero generale della CGIL del febbraio del 2003, che ha portato milioni di lavoratori a Roma: “Siamo ad un confronto drammatico, forte, che si pone in una fase di grande trasformazione dell’industria e del lavoro. Una trasformazione che, come in vario modo altre volte nel passato, ha indotto il colto e l’inclita a decretare la fine del lavoro … Questo è il dato della cultura dominante” (dunque degli avversari dei lavoratori): “il lavoro non c’è più e può essere anche inquinante”.57 Mentre Bruno Ugolini, parlando delle lotte dei metalmeccanici, ha sottolineato che essi sono ancora tanti “malgrado la profezia circa l’ormai inevitabile ‘fine del lavoro’”. 58 Poi, col passare dei mesi e degli anni, lentamente, ma inesorabilmente, è calato il silenzio, salvo qualche reminiscenza come quella della Camusso, che in occasione di un intervento televisivo 5 ha incautamente sostenuto che la teoria della fine del lavoro sarebbe “servita a lanciare la speculazione finanziaria”.
Per mettere a fuoco il problema.
“Utopia”, “scomparsa completa”, “sostituzione totale”, “estinzione”, “eliminazione”, “sparizione”, “redistribuzione selvaggia”, “monopolizzazione”, “fine della storia”, “falso problema”, “realtà inquinante”, “mito dei miti”, “ciarpame”, “vezzo del colto e dell’inclita”, “profezia”, ecc.; ma se quella della “fine del lavoro” fosse soprattutto una metafora? Se chi l’ha usata non intendesse riferirsi ad una vera e propria dissoluzione del lavoro, ma ad un fenomeno più complesso, del quale la figura della “fine” costituiva solo un espediente rappresentativo per catturare l’attenzione di lettori e di ascoltatori spesso distratti o confusi da una sovrabbondanza di messaggi? Che utilità potrebbe in tal caso avere l’opposizione alla lettera con la quale alcuni studiosi hanno tentato di significare il fenomeno sociale al centro dell’attenzione? Perché evitare di penetrare nel senso di ciò che hanno cercato di affermare, semmai confutando le mediazioni analitiche con le quali hanno tentato di rappresentarlo? Non che qua e là non ci siano stati individui o gruppi che, a causa di una sostanziale povertà intellettuale, hanno finito col recepire la formula in termini non metaforici e con il riproporla in forma letterale. Qualche60 sostenitore della proposta del reddito di cittadinanza, ad esempio, ritiene – evidentemente senza aver mai criticamente riflettuto sul problema – che il lavoro non sia più condizione di (ri)produzione della ricchezza e, su questa base, rivendica per tutti una partecipazione al reddito derivante dal puro e semplice fatto di esistere 61, e dunque senza che nessuno sia costretto a svolgere alcun lavoro. 62 Ma si tratta di eccezioni. Se molti di coloro che sono ricorsi alla formula della “fine del lavoro”, come ad esempio Jeremy Rifkin 63, Pierre Carniti 64, Adam Schaff 65, Dominique Mèda 66, Ermanno Bencivenga67, Domenico De Masi 68, Benjamin Hunnicutt 69, Ulrich Beck 70 hanno scritto, ognuno, centinaia di pagine per spiegare l’oggetto al quale si stavano riferendo, è ovvio che il processo di risoluzione di milioni di parole nella piatta espressione “fine del lavoro”, è il segno di un probabile autismo dei riceventi (71), che va al di là delle ammissibili manchevolezze della rappresentazione (72).
Personalmente non condivido molte delle riflessioni di Rifkin, quando dalla storia passa alla teoria; ho avanzato approfondite critiche a Schaff (73); ho dialogato criticamente con Hunnicutt (74); ho recensito positivamente, ma criticamente il testo della Medà, e non ho mai indulto all’uso della locuzione “fine del lavoro”; ma solo perché sono pienamente consapevole delle difficoltà comunicative che contraddistinguono l’attuale epoca storica. Il fatto di non aver considerato positivamente il ricorso a questa figura non mi spinge però a schierarmi con chi si è limitato a rigettarla per semplificare la realtà (75), sbarazzandosi del problema. Non basta cioè affermare che non c’è “la fine” del lavoro. Ritengo piuttosto, con Heilbroner (76), che si debba assolutamente porre al centro del dibattito in tutti i paesi – economicamente sviluppati e sottosviluppati – la questione del “futuro del lavoro”, e che a tal fine la figura della “fine del lavoro” abbia fatto meno male di quanto non ne abbia fatto l’opposizione che ha subito da una parte significativa di coloro che pure non accettano passivamente l’evoluzione in corso. Con la prima si è cercato di cogliere un problema che incombe su di noi, e di individuare i mutamenti sociali che consentirebbero di affrontarlo; con la seconda si è cercato di sbarazzarsene, come se non fosse richiesto alcun cambiamento. La prima spingeva per un mutamento qualitativo nelle forme e negli obiettivi del conflitto sociale; alla seconda bastava un’intensificazione quantitativa del conflitto nelle forme operaie, studentesche, ambientaliste, femministe o pacifiste ereditate dal passato, perché tutte ed ognuna potevano essere interpretate come una ripresa del movimento, per il quale non sarebbe essenziale misurarsi col problema – nuovo e centrale – della riproducibilità o meno del rapporto di lavoro salariato.
Per tornare all’esempio con cui abbiamo aperto questo capitolo, se, invece di chiedere metaforicamente al figlio di “tirarsi” dietro la porta, la madre gli avesse più banalmente detto di “chiuderla”, l’errore del figlio forse non sarebbe intervenuto. Ma ciò non depone contro la madre, appunto perché la porta andava chiusa e lei, probabilmente, sapeva di doverlo ricordare al figlio. Ciò che non poteva fare altrimenti che con il suo linguaggio. Insomma, il lavoro interpretativo del problema emerso va impostato partendo dalla (in)capacità di comprensione del figlio, che può indubbiamente essere letta alla luce della particolare forma del messaggio che la madre gli ha inviato. Ma senza incorrere nell’errore di imputare a quest’ultima il comportamento improprio del figlio, che ha agito addirittura in maniera opposta rispetto al necessario e a ciò che gli aveva chiesto la madre. Così l’interrogativo, per noi, riguarda il fastidio che molti, a sinistra, hanno provato nei confronti della tesi sulla “fine del lavoro”, spingendoli a sbarazzarsi del problema che con quella tesi si cercava di evocare, invece convenire sulla possibilità che non comprendevano ciò di cui si stava parlando, e di provare a misurarsi criticamente con ciò che esso eventualmente implicava.
E non basta obiettare che, in qualche caso, la critica alla figura della “fine del lavoro” ha costituito una reazione all’uso che ne è stato fatto da destra, per cercare di chiudere definitivamente la fase della storia che è stata dominata dal “diritto al lavoro”. 77 Se dagli anni Ottanta i conservatori in recupero hanno cercato di negare i problemi che affliggono la società moderna, trincerandosi dietro ad una particolare lettura della “fine del lavoro”, fantasticamente tesa ad anticipare la scomparsa del loro antagonista storico, 78 è altrettanto certo che, per tornare a contare nella società, quell’antagonista deve affrontare un problema nuovo che lo riguarda, che è stato dapprima espresso, anche se rozzamente, con la formula della “fine del lavoro” 79. Così è innegabile che Rifondazione Comunista, nel momento in cui aveva ancora un peso significativo nel quadro politico nazionale, ha sostenuto che “contrariamente alla vulgata sulla ‘fine del lavoro’ nel mondo, sia ora che nelle previsioni future di tutti gli enti internazionali che si occupano degli scenari economici e sociali, il lavoro dipendente è cresciuto ed è destinato a crescere enormemente su scala mondiale, qualunque sia la forma giuridica o la definizione sociologica che assume da paese a paese”, facendo sua la posizione degli avversari dei teorici della “fine del lavoro”. Una unilateralità accentuata dalla presa di posizione del Segretario dell’epoca che, in pieno congresso, ha liquidato ogni riflessione qualificando la teoria della “fine del lavoro” come “un incredibile bufala che ha fatto il giro del mondo!”, ottenendo così il disastroso risultato di far scendere definitivamente il sipario sull’argomento.
Se almeno i sedicenti “marxisti” avessero tenuto presente un frammento dei Lineamenti fondamentali, che circola in Europa da più di cinquant’anni – nel quale Marx sostiene che “il capitale impiega le macchine solo nella misura in cui abilitano l’operaio a lavorare per il capitale una parte maggiore del suo tempo. … E’ vero che, con questo processo, la quantità di lavoro necessario alla produzione di un determinato oggetto viene ridotta a un minimo, ma solo perché un massimo di lavoro venga valorizzato nel massimo di tali oggetti. Il primo lato è importante, perché il capitale riduce qui, senza alcuna intenzione, il lavoro umano (il dispendio di forza) ad un minimo. Ciò tornerà utile al lavoro emancipato ed è la condizione della sua emancipazione” 80 – forse sarebbero riusciti a trasformare il fastidio in una sollecitazione ad interrogarsi 81.
Per facilitare il compito a chi ha difficoltà di comunicazione e viene confuso dalle metafore, proveremo pertanto a riformulare il nostro problema in termini difficilmente 82 equivocabili. Ci chiederemo: l’evoluzione sociale dell’ultimo secolo, con il radicale rivoluzionamento della vita 83 che ha determinato nei paesi sviluppati, prospetta l’esistenza di un limite ravvicinato alla riproducibilità del lavoro salariato? Insomma, l’anticipazione di Marx sulla tendenza del capitale a ridurre sistematicamente il lavoro ad un minimo, seguita ad un elevato grado dello sviluppo dall’involontaria incapacità di reimpiegarlo pienamente, ha trovato, dopo un secolo e mezzo, una qualche conferma storica, o è stata invece confutata? Dobbiamo cioè concludere che questo tipo di attività produttiva venga oggi riprodotto e possa 84 continuare ad essere riprodotto senza difficoltà e senza determinare effetti contraddittori o che sia invece vero il contrario? In altri termini, il lavoro salariato è un lavoro che ha un futuro, nel senso che è capace di mediare un ulteriore sviluppo, o ha invece raggiunto un limite che impone un suo primo superamento, nonostante possa e debba per qualche tempo continuare a costituire la base della vita che abbiamo ereditato dal passato, e di un suo eventuale consolidamento? E se è così, in che cosa può concretamente consistere l’emancipazione alla quale Marx fa riferimento? Vale a dire, c’è un qualcosa d’altro che dovrebbe eventualmente riempire positivamente il nostro futuro, sostituendo il lavoro salariato come elemento propulsore di un nuovo sviluppo?
Ritengo che la realtà sociale odierna ci offra numerose testimonianze a favore della validità dell’anticipazione di Marx, e che la diatriba contro la “fine del lavoro” esprima proprio l’incapacità di cogliere la differenza che passa tra un futuro nel quale ci si limita a cancellare il lavoro – immaginando che al recedere di quest’attività subentri solo un vuoto o, al massimo, un’esistenza umana dominata, in una ristretta cerchia, dallo spasso e dal divertimento e, per il resto, dalla miseria servile – ed un futuro nel quale il peso del lavoro salariato recede significativamente, perché si riesce a, o almeno si tenta di sostituirlo in generale con un’attività produttiva qualitativamente superiore. Costretti a ciò proprio dalla difficoltà di procedere, nelle società sviluppate, al reimpiego del lavoro salariato reso superfluo dall’innovazione tecnologica. Il rifiuto di questa costrizione può rendere la sinistra ancor più autistica di quanto ha sin qui dimostrato di essere nell’elaborazione delle soluzioni che consentirebbero di uscire dalla situazione di crisi nella quale siamo piombati. Infastiditi dalla complessità dei problemi che vengono posti dalla vita, e che rimangono dapprima sepolti in essa proprio perché semanticamente oscuri, buona parte di coloro che si battono per una società alternativa, potrebbero cioè decidere di “scardinare la porta”, che dovrebbero invece solo “tirarsi” dietro per “chiudere” la fase storica appena trascorsa. Così facendo dimostrerebbero però di non aver compreso i compiti che le generazioni che ci hanno preceduti ci hanno inconsapevolmente trasmesso, e che conseguono proprio dalla soluzione dei compiti che la storia precedente aveva loro consegnato (85)
Se il lavoro salariato non è riproducibile sulla scala necessaria (86), e la sua espansione non può garantire un nuovo sviluppo, ogni tentativo di procedere nella direzione del pieno impiego senza muovere da questo punto fermo è destinato a sfociare in un disastro. Si tratta dello stesso drammatico effetto che subisce chiunque insista ad offrire una merce sul mercato anche in presenza di segnali che testimoniano una strutturale eccedenza di quel prodotto rispetto alla domanda. Né basta obiettare che questo effetto non si dovrebbe verificare perché l’offerta di forza lavoro non è uguale a quella delle altre merci. Affinché questa obiezione non rimanga nel limbo delle questioni etiche, occorre appunto che il tentativo di partecipare all’attività produttiva si sottragga al meccanismo offerta-domanda proprio del mondo delle merci e non si accontenti più di evocare idealisticamente lo stato come figura altra, capace di spingersi al di là dei limiti del mercato. Insomma è necessario che prenda corpo un soggetto in grado di elaborare pratiche produttive nuove, che oltrepassino la pura e semplice riproduzione del rapporto salariato, nell’ambito del quale abbiamo – positivamente – costruito la vita negli ultimi duecento anni.
Ma per procedere in questa direzione si deve affrontare il problema che è stato sollevato a suo tempo dai cosiddetti teorici della “fine del lavoro”, tra i quali non mi annovero, ma ai quali sento che tutti noi dobbiamo concedere la necessaria attenzione, appunto perché, esplorando uno spazio al di là del dato, hanno posto in essere quel comportamento indispensabile per lavorare attorno al problema centrale di cui, in quest’epoca storica, abbiamo cominciato a soffrire.
Capitolo secondo
Un bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno?
Definiamo con più precisione l’oggetto al centro della contesa sulla quale stiamo ragionando. Scrive Rifkin in La fine del lavoro: “oggi, su scala globale la disoccupazione ha raggiunto il livello più elevato dai tempi della Grande Depressione degli anni Trenta. Nel mondo, più di 800 milioni di persone sono disoccupate o sottoccupate”. “Questo numero è probabilmente destinato ad aumentare ulteriormente … poiché milioni di individui si affacceranno per la prima volta sul mercato del lavoro, per ritrovarsi senza alcuna possibilità di occupazione. Molte saranno le vittime di un’innovazione tecnologica che sostituisce sempre più velocemente 87 il lavoro umano con le macchine, in quasi tutti i settori dell’economia globale”. 88 Egli parte dunque dal porre l’accento sul lato negativo della situazione che si è instaurata nell’ultima fase del XX secolo, su ciò che in essa sembra non andare nel verso giusto. Come si dice, egli nota la parte vuota del bicchiere.
Gli rispondono gli avversari 89: “non è vero che il capitalismo contemporaneo veda il ridursi dell’occupazione. Al contrario, la forza lavoro mondiale è aumentata dal 1965 al 1995 da 1.329 e 2.476 milioni di lavoratori, e se ne prevede l’ulteriore espansione a 3.656 milioni per il 2025. Quello che è successo è che si è avuta una ridislocazione dell’attività manifatturiera su scala mondiale. Una ridislocazione che ha colpito, mediante massicce espulsioni di manodopera, soprattutto i lavoratori delle grandi imprese, e ancor di più quelli delle grandi imprese produttrici di beni di consumo di massa, la cui tecnologia non è più privilegio dei paesi più avanzati” 90. Con un’argomentazione che echeggia molto da vicino la famosa teoria economica antikeynesiana della compensazione, secondo la quale le occupazioni perse in conseguenza dell’innovazione tecnica tendono sempre ad essere sostituite da altre, si dice che il bicchiere non è affatto mezzo vuoto, ma solo mezzo pieno, e in attesa di essere riempito del tutto.
Due brevi critiche di metodo
L’enunciato offre però il fianco a due prime critiche elementari. Nel trentennio considerato l’aumento della forza lavoro in termini relativi sarebbe stato, secondo gli specifici dati della Banca Mondiale riportati, 91 di poco superiore all’80%; ma negli stessi anni la popolazione mondiale non è forse aumentata di una percentuale molto vicina a quella stessa grandezza? Al massimo si potrebbe dunque parlare di una crescita assoluta degli occupati, che però corrisponderebbe ad una normale riproduzione relativa del loro numero 92. Ciò che deporrebbe senz’altro contro la tesi sulla “fine del lavoro”, ma non giustificherebbe affatto il suo baldanzoso rovesciamento. Ma le cose non stanno proprio in termini così tranquillizzanti! Si noterà, infatti – ed è questo il secondo e più grave errore – che lo stesso Rifkin, parlando di una “crescita di quanti si riversano (anche per la prima volta) sul mercato del lavoro”, non fa altro che ipotizzare il sussistere di una dinamica che determina un aumento assoluto e relativo della forza lavoro mondiale. Dunque non si può contrapporre questo aumento alla sua argomentazione, visto che lo concepisce addirittura come punto di partenza del ragionamento! Egli si riferisce, invece, e più sensatamente, alla possibilità che questo numero crescente di individui, che vogliono agire come lavoratori salariati, trovino effettivamente un’occupazione. Per Rifkin il problema dovrebbe diventare drammatico, appunto perché all’espansione dell’offerta mondiale di forza lavoro, sulla quale nessuno ha dubbi, se non altro perché le forme produttive più arcaiche tendono ovunque a dissolversi in modo accelerato, non dovrebbe corrispondere una comparabile crescita dell’occupazione. 93
Certo, se si prende l’espressione “fine del lavoro” alla lettera, basta spiattellare i dati sull’aumento assoluto di quanti si offrono come “forza lavoro” a livello mondiale per credere di averla confutata. E’ cioè sufficiente riconoscere che c’è un numero crescente di soggetti che cerca lavoro, per negare che il rapporto di lavoro salariato sia realmente giunto al termine del suo sviluppo 94. Ma se non ci si avvale di questa semplificazione arbitraria, che risolve un processo complesso in uno solo dei suoi momenti, tutto torna in alto mare, ed occorre affrontare un problema cruciale: il numero crescente di coloro che cercano e cercheranno lavoro è in grado di trovarlo? 95 Vale a dire, la velocità alla quale viene creato lavoro è tale da compensare il lavoro distrutto dal progresso tecnico oltre a far fronte all’impetuosa crescita della forza lavoro, determinata sia dall’aumento della popolazione mondiale, sia dal fatto che molti di coloro che prima non si riversavano sul mercato del lavoro, ma producevano in altra forma, ora lo fanno? Insomma, chi cerca di praticare il rapporto di lavoro su scala allargata dal lato dell’offerta, trova dall’altra parte, cioè dal lato della domanda, qualcuno capace di soddisfare questa richiesta nella misura corrispondente?
I pochi e confusi dati a nostra disposizione 96 non depongono a favore di questa ipotesi e confutano alla radice sia la tranquilla certezza degli economisti che la avanzano, che le foghe oratorie di chi, sul piano politico, prospetta un’alternativa che elude il problema. Richiamiamoli sinteticamente.
Innanzi tutto va tenuto presente che il povero Rifkin non ha tirato fuori la valutazione dal suo cappello, ma ha citato puntualmente il documento dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, The World Employment situation, Trends and Prospects 97, dal quale la traeva. Se non si concordava si doveva, ovviamente, entrare nel merito e confutarla. Ma ci si è ben guardati dal farlo, contrapponendole, senza operare alcuna comparazione metodologica, i dati proposti da un altro organismo, la Banca Mondiale, che non entravano nemmeno nel merito del problema che lui sollevava, o i dati dell’O.I.L. del 1996, relativi all’andamento dell’occupazione, ignorando però quelli della disoccupazione e della sottoccupazione, che nella prospettiva indicata da Rifkin risultano centrali. Ma ragioniamo attorno alle statistiche disponibili ipotizzando che esse, pur nella generale confusione, abbiano un qualche elemento di validità.
Nel corso degli anni Sessanta, per la concomitante azione dello Stato sociale nei paesi industrialmente avanzati e della residua tenuta dei preesistenti modi di produzione nei paesi economicamente arretrati, la disoccupazione mondiale si collocava tra il 2 e il 3% e, su una forza lavoro formalmente rilevata di poco più di 600 milioni di lavoratori, riguardava poco più di 12 milioni di unità. 98 Volendo accettare per buona la stima della Banca Mondiale, che colloca invece a circa 1.350 milioni di unità la forza lavoro mondiale dell’epoca, e supponendo che la disoccupazione fosse più elevata nei paesi nei quali il mercato del lavoro non era sotto controllo statistico, si può arrivare ad un valore di più o meno 30 milioni di disoccupati. Sempre accettando per buona la stima della forza lavoro mondiale della Banca Mondiale relativa al 1995, che quantifica le unità di coloro che si riversano sul mercato del lavoro in 2.500 milioni circa, se non fossero sopravvenuti gravi problemi di riproduzione del lavoro, ci saremmo ovviamente dovuti trovare con un incremento della disoccupazione non più che proporzionale rispetto all’incremento relativo della forza lavoro. I disoccupati in più rispetto al 1965 avrebbero dovuto cioè essere circa 25 milioni, portando il loro ammontare complessivo a non più di 55 milioni. Le stime per quell’anno da parte dell’ILO, fatte proprie dalla Banca Mondiale, individuano invece in ben 136 milioni il numero dei disoccupati su scala globale. E mentre nel 2000 si quantifica in 160 milioni il numero dei senza lavoro nel mondo, nel 2003 lo si quantifica in 186 milioni. Siamo cioè ad un ordine di grandezza che supera comparativamente del trecento per cento quello degli anni Sessanta e che, cosa quanto mai significativa, colpisce soprattutto i giovani. Per non parlare delle forme di sottoccupazione – relative, appunto, ad una riproduzione stentata del rapporto salariato – che vedono coinvolte centinaia di milioni di persone 99.
Inutile dire che si tratta di dati che vanno presi solo come grossolani indicatori di una tendenza, appunto perché una conoscenza del reale andamento della riproduzione della forza lavoro su scala planetaria è al di là da venire. Ma è un dato di fatto che, mentre negli anni Sessanta i governi tendevano a vergognarsi di una disoccupazione superiore al 3%, dagli anni Ottanta ha cominciato a prevalere una tendenza opposta. Qualsiasi livello di disoccupazione necessario a garantire la stabilità dei prezzi, anche se quattro o cinque volte superiore rispetto agli anni Sessanta, ha finito con l’essere accettato, dopo essere stato classificato dagli economisti conservatori come “un tasso naturale di disoccupazione”. Tenendo fermo questo rovesciamento si può far riferimento ai tassi di disoccupazione per grosse regioni, relativi al 1995, che risultano essere:
Tabella n°1
Tassi di disoccupazione per regione 100
Paesi sviluppati 9,1
America Latina e Caraibi 8,1
Asia e Pacifico 4,6
Medio Oriente 10,9
Africa del Nord 10,5
Con simili grandezze, che a nostro avviso, sottovalutano la potata del problema 101, ci sembra che sia del tutto sensato chiedersi: il lavoro – e quando parliamo di lavoro ci riferiamo ovviamente al lavoro salariato – continua a garantire “l’arricchimento umano” o sta solo mediando un miglioramento – antagonistico 102 – delle condizioni di vita di coloro che vivono in società dominate da un’estrema povertà, mentre nei paesi economicamente sviluppati “ha addirittura cessato di essere la fonte di un arricchimento superiore” 103 che, su basi alternative, sarebbe invece possibile?
Il quadro statistico complessivo fornito dall’I.L.O. Relativo al tasso di disoccupazione mondiale periodo 1994-2010, d’altronde, confuta alla radice le argomentazioni dei critici della “fine del lavoro”, in quanto configura il quadro evolutivo in maniera più vicina alle ipotesi di Rifkin che a quelle di coloro che lo hanno contrastato. Come si può facilmente rilevare negli ultimi quindici anni il tasso di disoccupazione è risultato sempre decisamente elevato. Per quanto riguarda poi l’occupazione va notato che c’è una tendenza di lungo periodo al declino del tasso degli occupati in rapporto alla popolazione mondiale, visto che questo scende dal 62,5% del 1994 al 61% del 2010, e che a fine 2011 l’I.L.O. ha conteggiato la disoccupazione mondiale a di sopra dei 200.000.000 di unità. Si tratta, letteralmente, dell’esatto opposto di quello che sostengono i critici dell’ipotesi della “fine del lavoro”.
Una considerazione a parte va fatta per interpretare il presunto miglioramento del quale si gloriano i sostenitori della cosiddetta “flessibilità”. In Europa, sostengono, negli ultimi quindici anni, proprio grazie ad un crescente recupero delle dinamiche proprie del mercato, la disoccupazione si sarebbe ovunque dimezzata e in alcuni paesi sarebbe addirittura scesa ad un terzo rispetto agli anni Ottanta. Un confronto con simili argomentazioni è decisamente peggiore rispetto a quello sul quale ci siamo cimentati fino a questo punto. L’argomento poggia infatti su una vera e propria mistificazione. Chi non vive alla giornata e interagisce criticamente con il contesto che lo circonda sa che i dati statistici possono registrare delle differenze, sia perché è effettivamente intervenuto un cambiamento del fenomeno, sia perché la stessa situazione viene osservata nel tempo con criteri e con misure differenti. Eurostat, ed in Italia l’ISTAT, hanno introdotto nel corso degli ultimi venticinque anni numerose modifiche nei criteri con i quali vengono svolte le rilevazione campionarie del mercato del lavoro. Se oggi in Italia si usassero gli stessi criteri in vigore nella fase di ascesa del Welfare keynesiano, il tasso di disoccupazione non sarebbe al livello del 6,7%, come indicato nelle statistiche ufficiali, bensì risulterebbe addirittura del 15,2%. 104
Ma al di là della disoccupazione vera e propria, non è forse la stessa precarietà di cui soffre ovunque il lavoro salariato 105, sulla quale molti studiosi ormai convengono, che va interpretata come manifestazione di una incapacità di riprodurre il rapporto? O bisogna piuttosto accondiscendere con i più ingenui, secondo i quali si tratterebbe di una manifestazione consapevole e voluta del potere delle classi egemoni?
Parte seconda
Collocare il lavoro salariato in una prospettiva storica
Capitolo terzo
La sensibilità necessaria per valutare le vicende del lavoro salariato
“Il nemico più pericoloso è sempre costituito da una sintesi troppo affrettata, sia essa fondata sulla superstizione tradizionale o sull’istinto obsoleto o su una conoscenza scientifica incompleta. Insorgere risolutamente contro questa propensione alla sintesi affrettata dovunque essa si manifesti, anche a costo di andare incontro a possibili incoerenze o di vedere frustrati i nostri ideali, dev’essere il compito di tutti i ricercatori disinteressati.”
(Bertrand Russell 1959)
“… si perde il reale a totalizzare troppo presto e a trasformare senza prove il significato in intenzione, il risultato in obiettivo realmente raggiunto.”
(Jean-Paul Sartre 1960)
Per ragionare sul problema che ci accingiamo ad affrontare può esserci di aiuto una categoria che ha trovato un’ampia diffusione negli ultimi trent’anni, quella relativa al risultato nel quale si risolve l’azione sociale. Abbiamo così “giochi” a somma positiva, quando la società finisce col trovarsi meglio rispetto alla fase antecedente, giochi a somma negativa, quando la società regredisce e perde una parte della ricchezza e delle capacità delle quali prima godeva, e giochi a somma zero, quando i cambiamenti producono effetti che si elidono a vicenda. Il nocciolo del concetto di gioco a somma zero è ben espresso da una formula frequentemente usata nell’ambito dell’economia ortodossa. Sostengono infatti gli ortodossi 106 che, nella riproduzione della società, “non può mai esserci un pasto gratuito”. Una metafora con la quale intendono affermare che ogni prodotto o servizio di cui si gode ha un costo corrispondente.
Dietro a questa vaga metafora si nasconde però un problema che ha investito lo svolgimento di tutto il pensiero economico moderno, nei suoi due secoli e mezzo di vita 107. Che la produzione, qualsiasi produzione – a differenza dei miracoli – comporti un costo, cioè l’impiego di risorse e di attività, è cosa ovvia. E dunque il contrasto teorico non riguarda questo fatto, quanto piuttosto la necessità che tra valore del prodotto e costo della sua produzione vi sia sempre equivalenza. Insomma la controversia si riferisce alla possibilità che nel processo di produzione intervenga o non intervenga una creazione di ricchezza aggiuntiva, cioè un prodotto che eccede ciò che esso è costato. Nell’ipotesi che un prodotto eccedente sia impossibile, ciò che viene sostenuto dagli economisti ortodossi è tautologicamente vero: nella riproduzione si può “avere” di più solo se si “immette” di più nel processo produttivo. E quindi si può “dare” qualcosa a qualcuno solo se ed in quanto glielo si fa produrre direttamente o lo si toglie a qualcun altro, che da questa decisione viene dunque impoverito. Ma se il processo produttivo, per il modo in cui viene organizzato, consente di ottenere dei prodotti il cui valore eccede i costi sostenuti, è altrettanto evidente che, in tal caso, l’eccedente non ha un costo equivalente. Si può allora avere di più senza immettere “ di più”, solo perché quello che si immette viene impiegato in modo più produttivo. Un esempio può permettere di comprendere concretamente il problema. Una famiglia che, per il proprio approvvigionamento idrico dipende da una sorgente lontana può distogliere l’attività di alcuni membri dall’approvvigionamento idrico, per destinarla alla costruzione di un piccolo bacino di raccolta dell’acqua piovana nelle vicinanze della propria abitazione. Il lavoro impiegato in questo modo consente di ottenere una quantità d’acqua molto maggiore di quella che si sarebbe ottenuta continuando ad impegnare quella capacità produttiva nella vecchia maniera. Per questo si può parlare del risultato di un gioco a somma positiva, nel quale si può dare qualcosa a qualcuno senza toglierlo a nessuno o, addirittura – là dove domina il rapporto di scambio – favorendo anche colui che viene chiamato a dare. Questo perché, grazie a quel contributo produttivo, non si crea solo l’eccedente, ma anche una delle condizioni affinché chi produce quell’eccedente possa produrre i beni di cui gode 108: cioè la domanda da cui scaturisce la sua stessa attività. Una questione che approfondiremo più avanti.
Ora, per comprendere l’evoluzione del rapporto di lavoro salariato e le probabili tendenze future alle quali la sua riproduzione va incontro, occorre tener ben presente questa problematica, appunto perché l’affermarsi di questo rapporto, come relazione universale, è conseguito dall’instaurarsi di un gioco a somma positiva, e la sua sostenibilità è collegata la continuo ripetersi di questo gioco a somma positiva. Se questo gioco produce effetti contraddittori, che sfuggono alla percezione del senso comune, il futuro del lavoro salariato può non essere così aperto come si crede. D’altra parte il senso comune si rapporta di norma alla propria esistenza ingenuamente, ignorando che la forma della vita costituisce il risultato di un complesso, non necessariamente consapevole e spesso contraddittorio, sviluppo sociale. Per questo ogni interrogativo sul “futuro del lavoro” diventa fonte di disagio e genera un comprensibile, ma non condivisibile, rifiuto. Ma, come abbiamo accennato, se si vuol comprendere la crisi di cui soffriamo oggi non si può evitare di indagare sulle condizioni che potrebbero eventualmente garantire un futuro al lavoro e sulle dinamiche che potrebbero invece precludere una prospettiva positiva, per quanto paradossale possa apparire il dubbio.
Come ricordavamo sopra, alcuni degli economisti, che pure accettano il sussistere di un gioco a somma positiva, hanno elaborato una risposta che sposa l’ingenuità prevalente e tende a rimuovere quel disagio, svolgendo un’argomentazione che è nota come “teoria della compensazione” 109. Messi di fronte agli effetti immediati della continua innovazione tecnica nella produzione 110 – che a parità di prodotto determina un risparmio di lavoro diretto e di risorse e materie prime (dunque di lavoro indiretto) – essi hanno sostenuto e sostengono che questo risparmio può eventualmente causare solo difficoltà occupazionali transitorie, perché il lavoro che viene via via eliminato dal progresso tecnico sarà ogni volta spontaneamente sostituito da un altro lavoro. Che cosa c’è di più ovvio del fatto che tutti noi abbiamo una moltitudine di bisogni insoddisfatti? E che cosa c’è di più sensato del riconoscere che, per soddisfarli, dobbiamo agire produttivamente? E come si può agire produttivamente se non che “lavorando” 111? Dunque, anche se l’innovazione tecnica distrugge alcune delle occupazioni esistenti, per coloro che svolgevano i compiti che l’innovazione ha fatto scomparire non può esserci che un nuovo lavoro. La prospettiva prevedibile corrisponderebbe così, sia ad un futuro fondato su sempre più lavoro, che ad un lavoro al quale non si potrebbe negare un futuro, 112 appunto perché il processo di una continua riproduzione del lavoro salariato viene posto come un dato immanente. Se in un qualsiasi momento non tutta la forza lavoro disponibile trova un impiego, ciò non esprimerebbe il lato contraddittorio delle relazioni prevalenti, bensì accadrebbe solo per il sopravvenire di distorsioni o ritardi rispetto alla fisiologica evoluzione del sistema economico, che di per sé farebbe sempre emergere il lavoro aggiuntivo e sostitutivo che gli individui cercano di svolgere e dovrebbero svolgere 113. Insomma, nella fase storica che stiamo attraversando, il lavoro salariato e coloro che ne decidono l’impiego non sarebbero precipitati in un labirinto, bensì avrebbero solo momentaneamente smarrito l’orientamento in un percorso sempre aperto, cosicché non ci sarebbe alcun bisogno di elaborare una nuova mappa del procedere sociale, per imboccare la via dello sviluppo. Al massimo si tratterebbe di travolgere quei signori – siano essi imprenditori, banchieri, politici o sindacalisti – che impediscono il cammino verso un futuro positivo, insito nella dinamica sociale ereditata (114).
I contrasti sulla natura della disoccupazione e le diverse sensibilità sottostanti
Ma la questione non è così semplice, visto che al presentarsi delle crisi economiche – soprattutto di quelle disastrose che, per un secolo e mezzo, si sono susseguite fino alla Seconda guerra mondiale – gli economisti 115 hanno finito ogni volta col dividersi in due schieramenti contrapposti. Da un lato c’era una minoranza, che traeva spunto dal dilagare della disoccupazione e della miseria per svolgere una radicale critica del sistema dei rapporti sociali prevalenti, sostenendo che gli imprenditori si dimostravano incapaci di dominare le stesse forze produttive che facevano venire alla luce, nel mentre cercavano di ottenere un profitto. Dall’altro lato si collocava una maggioranza, che avanzava invece una critica alla capacità di adattamento della popolazione lavoratrice, alla quale chiedeva di procedere con maggiore flessibilità, in modo da non frapporre ostacoli 116 alle iniziative degli imprenditori. Un adattamento che, in un secondo momento, avrebbe garantito la riconquista del pieno impiego ed il godimento dei frutti prodotti dalle nuove forze produttive, nel frattempo create dai capitalisti.
Che le cose non fossero tanto chiare è dimostrato dai non rari passaggi degli studiosi da uno schieramento all’altro. E’ rimasto famoso quello di uno dei padri fondatori dell’economia politica, David Ricardo, che, dopo aver sempre sostenuto la seconda posizione, nell’ultima edizione della sua opera più importante 117 ha finito col rivalutare la prima. Ma non è stato da meno quello di un conservatore come Lord Beveridge, che, dopo aver per decenni ragionato all’ombra di un orientamento fortemente influenzato dal secondo approccio, divenne, dal 1942, il principale sostenitore del processo di creazione del Welfare in Gran Bretagna, che ha fatto leva soprattutto sul primo (118).
Questo corpo a corpo, che ha attraversato l’evoluzione del pensiero economico, era in passato pienamente giustificato. L’esperienza storica insegnava infatti che, nel sottomettere a sé la produzione ereditata dai precedenti modi di produrre e nell’impostarla secondo criteri decisamente nuovi, il capitale procedeva indubbiamente a risparmiare lavoro, ma il fine di questo risparmio era, altrettanto indubitabilmente, quello di “conservare il valore della vecchia industria, creando le condizioni per una nuova”. 119 Le risorse e la forza lavoro “liberate” dai preesistenti compiti avrebbero dunque dovuto, nelle intenzioni degli imprenditori, trovare un nuovo impiego in un’ulteriore espansione della (loro) ricchezza. Era pertanto del tutto comprensibile che i primi economisti cogliessero la “natura positiva di questo orientamento”, esaltandone la portata rivoluzionaria rispetto a tutti i precedenti modi di vita, nell’ambito dei quali si puntava invece a riprodurre l’attività produttiva senza far leva sul continuo incremento di produttività, ma al solo fine di garantire i “lussi” delle classi egemoni. E dunque non si puntava a risparmiare lavoro nelle attività date per reimpiegarlo in nuove. Ma l’esperienza storica insegnava, anche, che – instauratosi quel sistema – subentravano fasi nelle quali questa dinamica positiva, per ragioni apparentemente incomprensibili, e comunque indifferenti alle intenzioni degli imprenditori, si bloccava e tutta la società, invece di arricchirsi, precipitava in uno stato di grande disoccupazione e di terribile miseria. Ed era dunque altrettanto sensato che alcuni economisti critici cogliessero questo tratto negativo, mettendo a nudo la ricorrente impotenza degli imprenditori, non già a tutelare se stessi, obiettivo che alcuni di loro riuscivano a raggiungere, bensì a porre fine alle sofferenze della società. Poiché queste sofferenze non trovavano alcuna giustificazione oggettiva nelle condizioni tecniche che erano state nel frattempo prodotte, rinviavano necessariamente alla natura dei rapporti sociali che mediavano la produzione.
Entrambi gli approcci contenevano dunque un elemento ricavato dall’esperienza, che diventava fuorviante in conseguenza della pretesa di farlo valere come unico criterio di caratterizzazione del sistema economico capitalistico. Nella realtà la tendenza del capitale era sia quella di puntare ad espandere indefinitamente la produzione e di cercare di impiegare la forza lavoro nella misura più ampia possibile, sia quella di trovarsi ripetutamente nell’impossibilità di riutilizzare la forza lavoro appena resa superflua; col conseguente sopravvenire di un blocco della produzione e dell’occupazione che non era giustificato da una qualsiasi ragione tecnica. Cosicché a fasi nelle quali si riusciva a perseguire efficacemente l’obiettivo sociale prevalente – quello dell’accumulazione – subentravano fasi nelle quali insorgevano inspiegabilmente ostacoli che sbarravano il passo. I ricorrenti scarti positivi e negativi tra domanda e offerta determinavano, d’altronde, delle oscillazioni della produzione che, paradossalmente, fornivano una convalida ora all’uno ora all’altro approccio, confermandoli nella loro unilateralità. Vale a dire che nei periodi di boom, nei quali la domanda attesa sopravanza l’offerta, il capitale riusciva a spingere la società molto al di là del livello di soddisfazione dei bisogni già dati, creando bisogni nuovi e nuovo lavoro ad un ritmo molto accelerato; mentre nei periodi di recessione, nei quali l’offerta sopravanza la domanda effettiva, non riusciva paradossalmente, nemmeno a garantire una ragionevole soddisfazione degli stessi bisogni che fino a quel momento venivano normalmente soddisfatti, lasciando inutilizzata una quota rilevante della forza lavoro esistente e dei mezzi di produzione disponibili. Da questa dinamica bivalente e contraddittoria, ampiamente testimoniata dall’andamento ciclico della produzione e dell’occupazione tra il 1800 e il 1950, ogni orientamento traeva conferma per le proprie conclusioni unilaterali pro o contro il capitale. Si può avere un’idea del fenomeno ricostruendo l’andamento dei cicli economici nel corso del secolo appena trascorso, con particolare riferimento agli USA, un andamento che mostra ampiamente la normalità del susseguirsi di cicli straordinariamente positivi e disastrosamente negativi fino agli anni Cinquanta del XX secolo. Come si può facilmente rilevare dal grafico che segue, ad intervalli ricorrenti la produzione saliva molto al di sopra non solo dei livelli minimi precedenti, ma anche di quelli medi e, viceversa, precipitava molto al di sotto non solo di quelli massimi, ma anche di quelli medi. Fornendo in tal modo, alternativamente, una momentanea conferma sia agli apologeti che ai critici dei rapporti capitalistici.
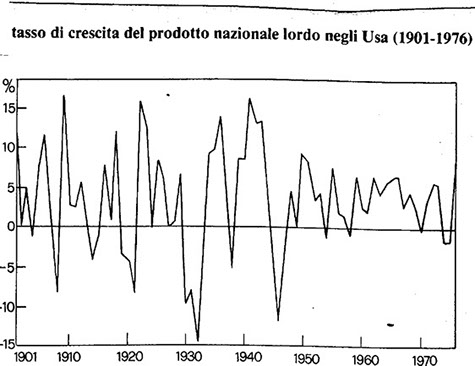
Fonte: Bruna Ingrao, Il ciclo economico, Editori Riuniti
Tra i pochi che hanno saputo sottrarsi a queste forme unilaterali di analisi vanno soprattutto ricordati, sebbene siano vissuti in due momenti storici profondamente diversi, Marx e Keynes. Dalle loro opere, contenenti un aperto riconoscimento della natura storica dei rapporti capitalistici, possiamo trarre una sorta di periodizzazione, utile per comprendere il fenomeno della riproduzione del lavoro salariato al di là delle vicende congiunturali.
Le fasi storiche dello sviluppo del lavoro salariato
Entrambi fanno infatti riferimento ad una prima fase dello sviluppo capitalistico, nella quale la borghesia in ascesa impone progressivamente un rapporto che prima era del tutto marginale, se non addirittura inesistente: quello di un lavoro che, oltre a scambiarsi con un salario, deve operare come lavoro produttivo. 120 Questa attività si distingue da quelle preesistenti in quanto non si limita a riprodurre le condizioni dell’esistenza di coloro che la erogano e di coloro che vivono del loro sfruttamento, oltre a reintegrare gli strumenti produttivi consumati nel processo di produzione, bensì crea sistematicamente un prodotto addizionale. Un sovrappiù, che trova un uso non tanto nel consumo immediato di chi la impiega, come accadeva nel periodo in cui prevaleva la schiavitù e la servitù, quanto nella sistematica crescita del capitale, cioè di una ricchezza che “crea altra ricchezza”. Ciascun capitalista, nel suo particolarismo, è capitalista in quanto genera questo lavoro al fine del continuo accrescimento del valore del proprio capitale. Ma questa angusta finalità non cancella lo straordinario sviluppo delle forze produttive sociali che indirettamente consegue dalla sua egemonia. Pur non essendo dei filantropi, i capitalisti infatti “arricchiscono la società”, in quanto, creando continuamente mezzi di produzione innovativi, beni di consumo prima inesistenti e conoscenze nuove, allargano la base produttiva rispetto ai miseri limiti preesistenti.
Per sgomberare il campo da ogni dubbio sulla natura storicamente positiva di questi rapporti, citerò un’argomentazione ricorrente di Marx: “la produzione di plusvalore relativo, ossia la produzione di plusvalore basata sull’aumento e sullo sviluppo delle forze produttive, esige la produzione di nuovi consumi; esige cioè che il circolo del consumo .. si allarghi …. In primo luogo: un ampliamento quantitativo del consumo esistente; in secondo luogo: la creazione di nuovi bisogni mediante la propagazione di quelli esistenti in una sfera più ampia; in terzo luogo: la produzione di bisogni nuovi e la scoperta e la creazione di nuovi valori d’uso … esige … che la sfera delle differenze qualitative del lavoro sia costantemente ampliata, resa più varia e internamente più differenziata….. Per il capitale e per i lavoratori liberati 121 occorre creare una nuova branca di produzione qualitativamente differente, che soddisfa e produce nuovo bisogno…. E non è soltanto divisione del lavoro – questa creazione di nuove branche di produzione, ossia di tempo supplementare qualitativamente nuovo; bensì una repulsione da se stessa della produzione limitata, in modo da creare un lavoro che ha un valore d’uso nuovo; è lo sviluppo di un sistema sempre più ampio e globale di tipi di lavoro, di tipi di produzione, ai quali corrisponde un sistema sempre più ampliato e ricco di bisogni”. 122
Come abbiamo appena visto, questo sviluppo non procede però in modo lineare. Sorge dunque il quesito del perché una produzione che scaturisce dalla pretesa di abbattere tutte le limitazioni precedenti e di realizzare una crescita continua 123, finisca con l’incappare ricorrentemente in limitazioni che non sono volute, e addirittura in drammatici immiserimenti. In altri termini, si pone l’interrogativo del perché, nonostante il capitale intenda impiegare sistematicamente su scala allargata il lavoro che rende di volta in volta disponibile, liberandolo dai precedenti compiti, e addirittura voglia trasformare tutti gli individui in lavoratori salariati che producono sempre di più, in alcune fasi non riesca ad occuparne una quota significativa. Ed è qui che interviene la divaricazione esplicativa lungo le sole direttrici possibili. Chi nega la normalità delle crisi sostiene che il blocco riproduttivo è dovuto al non funzionamento dei rapporti sociali prevalenti, che non consentono di reimpiegare positivamente il prodotto eccedente e la forza lavoro liberata e, pertanto, dovrebbero subire un mutamento; chi non ravvede alcuna possibile anomalia nel funzionamento dei rapporti sociali, tende, al contrario, ad attribuire alle crisi una veste fisiologica, sostenendo che si tratterebbe soltanto di reperire le risorse che mancano o sono state sperperate, restaurando il normale andamento delle relazioni, che sarebbe stato disturbato da qualche comportamento improprio. 124
Fino all’inizio del XX secolo i capitalisti erano d’altronde convinti che l’incessante espansione della produzione di merci – beni materiali e servizi – potesse costituire un fine in sé. E dunque aderivano praticamente, oltre che ideologicamente, al secondo approccio. Non tenendo conto della domanda effettiva, essi tendevano così a porre in essere un’offerta che in più occasioni trascendeva le possibilità di vendita. Sopravveniva allora una caduta dei prezzi, i costi non riuscivano più ad essere coperti e il profitto si dissolveva, rovesciandosi in perdita. Di fronte a questo evento inatteso, essi non sapevano far altro che rinunciare all’uso di una parte della forza lavoro e del capitale esistente, facendo precipitare la società in uno stato di miseria, per la loro incapacità di perseguire un obiettivo diverso da quello dell’accumulazione, anche quando non sussistevano più le condizioni per attuarla. Solo dopo questa fase sacrificale di distruzione del valore, della durata di qualche mese o di qualche anno, gli investimenti, tornando ad essere profittevoli, riuscivano a riprendere – da un livello ben più miserevole di quello precedentemente conquistato – e a garantire un nuovo periodo di sviluppo al di là del livello di prima. Intervenendo sempre sulla stessa base sociale, questo finiva però, qualche anno dopo, con lo sfociare in un nuovo crollo produttivo.
Ma dall’inizio del secolo, anche in conseguenza di un significativo superamento della concorrenza (125) e del dilagare degli oligopoli, le cose cominciarono a cambiare, con l’instaurarsi di una scissione tra comportamento pratico e ideologia liberista. Non solo, grazie alle concentrazioni di imprese, l’offerta fu in grado di procedere in modo più integrato, riducendo le spinte alla sovrapproduzione e alla sottoproduzione, ma la stessa intrapresa in nuove branche avvenne con una crescente attenzione per le possibilità di sbocco dei nuovi prodotti sul mercato. Da questo punto di vista, i cosiddetti teorici del postfordismo (126) pospongono erroneamente, collocandolo alla fine del Novecento, un fenomeno che è invece intervenuto molto prima, ed esattamente all’inizio del secolo. L’impresa cosiddetta fordista si muoveva già in un orizzonte che teneva conto della domanda effettiva delle merci che produceva, e dunque aveva già abbandonato il principio prevalente nella fase concorrenziale, quando la produzione per la produzione era lo scopo di ciascun centro produttivo. Ad esempio, quando Ford riesce finalmente a spingersi al di là del limitato livello di tutti gli altri produttori di automobili, diventando un oligopolista prevalente, la spunta anche perché fa in modo di trovare i compratori innanzi tutto nei suoi stessi dipendenti e di sollecitare un consumo di massa che prima veniva addirittura inibito (127). Per questo la diffusione delle automobili negli U.S.A. si moltiplica per dieci nel breve arco del decennio 1920-1930, passando da un’auto ogni cento abitanti, ad una ogni dieci. L’espansione del lavoro salariato cosiddetto fordista poggia così su un aperto riconoscimento del rapporto che intercorre tra espansione della domanda e creazione del lavoro, e dunque si distingue da quello che ha prevalso nella fase precedente, in quanto fa i conti con la limitatezza degli sbocchi. Si tratta però sempre di un lavoro che il neocapitale impiega al fine di procedere nell’accumulazione. Una determinazione che ben presto torna ad imprimere un segno negativo all’evoluzione della dinamica riproduttiva.
Il singolo capitalista è infatti al massimo in grado di incidere realmente sulla capacità di acquisto della propria forza lavoro, alla quale “chiede” però, come contropartita del miglioramento delle proprie condizioni materiali di esistenza, di accrescere ulteriormente la produttività. Per questo la soluzione, sfociando inevitabilmente in un’espansione accelerata dell’offerta che trascende la crescita della domanda, finisce ben presto col mordersi la coda ed esplode una crisi, come quella degli anni Trenta, che per durata e gravità non ha paragoni con quelle precedenti (128). Nei paesi colpiti più pesantemente la disoccupazione raggiunge il 25% e il prodotto interno lordo in termini di valore crolla alla metà rispetto agli anni precedenti.
Da subito si scontrano due interpretazioni. Una, che potremmo per semplicità storica definire come “einaudiana” (129), tutta tesa a riaffermare l’insuperabilità del laissez faire, considera la crisi come una fisiologica reazione a pregresse distorsioni del comportamento degli agenti economici, una salutare risposta del tessuto sociale che, in qualche modo, può contribuire a rimettere la società sulla retta via. L’altra, che sempre semplificando potremmo chiamare “keynesiana”, considera la crisi come la manifestazione paradossale di un profondo ed irreversibile cambiamento nelle condizioni materiali e sociali che determinano la produzione, e dunque spinge per individuare la natura dell’obliqua via, che ha finito con l’essere inconsapevolmente imboccata.
Se coloro che ai nostri giorni si stracciano le vesti di fronte all’uso della locuzione “fine del lavoro” avessero fatto lo sforzo di rileggere approfonditamente il dibattito dell’epoca – nel quale le opposizioni di “normalità/anormalità”, “nuova economia/vecchia economia”, “flessibilità/rigidità”, “imprenditorialità/precarietà”, “intraprendenza economica/speculazione finanziaria”, “liberalizzazioni/crescita delle dimensioni delle imprese”, si sprecavano – avrebbero scoperto che già allora la questione del futuro del lavoro era balzata, in quasi tutti i paesi economicamente sviluppati 130, al centro dell’attenzione. Prendendo atto della tendenza in corso, determinata dal fatto che “negli anni a venire” si sarebbe sempre più sentito parlare di “una disoccupazione dovuta alla nostra invenzione di strumenti in grado di economizzare il lavoro ad un tasso che sopravanza quello al quale possiamo trovare nuovi usi per esso” 131, Keynes ad esempio prospettava a medio termine un futuro di sofferenze sociali derivanti dalla difficoltà di creare nuovo lavoro sulla vecchia base, che si sarebbe accompagnata all’incapacità diffusa di accettare questa evoluzione. Dominati dal “vecchio Adamo che è in noi, avremmo avuto bisogno di svolgere un qualche lavoro per confermarci”. Ma si sarebbe trattato di un bisogno che avrebbe potuto essere soddisfatto solo accettando di spartire quanto più possibile tra tutti le sempre più limitate attività lavorative che avrebbero potuto essere riprodotte (132) “Giornate di lavoro di tre ore e settimane di quindici ore, avrebbero forse consentito di farlo”. Ma a questa situazione, allo stesso tempo positiva e negativa, si sarebbe potuti giungere solo se, nel frattempo, si fosse fatto fronte alla specifica difficoltà strutturale di riprodurre il lavoro salariato, che era scaturita dal “lasciar fare” ai capitalisti.
La chiave di lettura di quella difficoltà la troviamo esplicitata nella Teoria generale. “Poiché sembra probabile che le fluttuazioni nelle stime negative che il mercato fa dei rendimenti attesi dei diversi tipi di capitale siano troppo grandi per essere bilanciate da un[a qualsiasi politica di stimolo degli investimenti privati attraverso l’]abbassamento dei tassi di interesse, mi aspetto,” scrive Keynes, “che lo stato, che è nella posizione di calcolare l’efficienza marginale dei beni capitali sul lungo periodo e sulla base del vantaggio sociale generale, assuma una sempre maggiore responsabilità nell’organizzare direttamente gli investimenti”, decretando così la fine del laissez faire (133).
L’argomentazione complessiva è chiarissima. La spesa di capitale, cioè l’iniziativa degli imprenditori lasciati a se stessi, non può più mediare la riproduzione del lavoro salariato su una scala corrispondente alla piena utilizzazione della forza lavoro e delle risorse disponibili. Questo gioco a somma positiva – creazione di un prodotto eccedente e di una forza lavoro superflua, e l’impiego di entrambi in una branca produttiva nuova organizzata capitalisticamente – è giunto al termine. Se si vuole produrre la ricchezza materialmente producibile, e creare il lavoro necessario per eliminare la disoccupazione, non basta sollecitare i capitalisti, abbattendo il costo del credito, bensì deve subentrare una spesa di reddito, che il capitale è incapace di attuare perché, dal suo punto di vista, risulta dissipatoria. Il capitale subordina infatti ogni decisione di spesa al calcolo della profittabilità, e se i rendimenti attesi mancano, non è in grado di riconoscere qualsiasi altro “vantaggio sociale generale” corrispondente alla creazione di una ricchezza materiale che soddisfa bisogni, ma non paga un profitto (134). Dunque, mentre da un lato Keynes prospetta una difficoltà futura a riprodurre il lavoro salariato in tutte le sue possibili forme, dall’altro individua il sussistere di una mediazione sociale che può transitoriamente consentire di riprodurre quell’attività fino a garantire, per qualche generazione, il pieno impiego della forza lavoro attraverso un nuovo meccanismo espansivo.
Su questa base, dopo l’ultimo conflitto mondiale, prende avvio il secondo periodo della storia del lavoro salariato, che raggiunge il momento culminante nel corso degli anni Sessanta, quando il sistema del “diritto al lavoro” conquista la sua piena maturità, con la politica keynesiana del “pieno impiego”. Ed è proprio per consolidare questa “base” che la nostra costituzione, analogamente a quella di molti altri paesi europei, riconosce il lavoro come “fondamento della società”.
Una chiara comprensione del contenuto formale di questo passaggio storico ce la fornisce una riflessione anticipatrice di Marx. Nei Lineamenti fondamentali egli sostiene: “il capitale raggiunge il suo più alto sviluppo quando le condizioni generali del processo sociale di produzione non vengono create traendole dal prelievo del reddito sociale, dalle imposte pubbliche, – dove è il reddito, e non il capitale, che figura come labour fund 135, e l’operaio, pur essendo un operaio salariato libero come gli altri, tuttavia dal punto di vista economico è in un rapporto diverso [con il processo riproduttivo] -, ma dal capitale in quanto capitale. Ciò denuncia da un lato il grado in cui il capitale ha subordinato a sé le condizioni della produzione sociale, e perciò, dall’altro, il grado in cui la ricchezza riproduttiva sociale è capitalizzata e tutti i bisogni vengono soddisfatti nella forma dello scambio; anche i bisogni dell’individuo posti come sociali, quei bisogni cioè che egli soddisfa e che gli si impongono non come singolo individuo nella società, ma collettivamente insieme agli altri – il cui modo di consumo è, per sua natura, sociale – anche questi vengono non soltanto consumati, ma anche prodotti per mezzo dello scambio, dello scambio individuale” (136).
Se la crescente soddisfazione dei bisogni collettivi ha potuto aver luogo, nella seconda fase dello sviluppo del lavoro salariato, solo attraverso una straordinaria crescita degli investimenti pubblici e all’imporsi del cosiddetto sistema dei diritti sociali (137), ci troviamo, evidentemente, di fronte ad un’espansione della ricchezza collettiva che è potuta intervenire solo perché ed in quanto si è instaurato un “diverso rapporto” di una parte rilevante del lavoro con le condizioni della sua stessa erogazione. La politica del pieno impiego, praticata solo dopo la definitiva vittoria dell’impostazione keynesiana seguita alla Seconda guerra mondiale, ha rappresentato sì una politica finalizzata a riprodurre il rapporto di lavoro salariato su scala allargata, ma lo ha fatto attraverso una rottura nel modo di riprodurlo. Vale a dire che, col keynesismo, si è riusciti a trovare un altro gioco a somma positiva, da sovrapporre a quello capitalistico, in via di ridimensionamento relativo. Ora, è stato proprio questo modo di erogare il lavoro che ha raggiunto “il culmine” nel corso degli anni Sessanta, e che, in un secondo momento, ha cominciato ad incontrare delle difficoltà, precipitate in una vera e propria crisi nel corso degli anni Ottanta. Ma prima di soffermarci su questo secondo aspetto, chiudiamo i conti col primo.
Per fornire una misura della nuova base dello sviluppo è opportuno riportare una tabella sull’espansione della spesa pubblica come determinante della creazione (del lavoro e) del reddito in Gran Bretagna.
Tabella n. 2
Spesa pubblica della Gran Bretagna come percentuale del P.I.L.
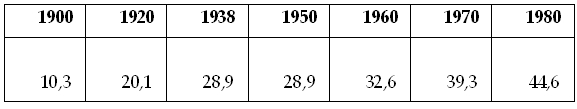
Daniel Cohen 138, Statistiques et Etudes Financiéres (Ministre de l’Economie e des Finances, France 1983).
In molti altri paesi economicamente avanzati, inclusa l’Italia, nel 1980, la percentuale del PIL che derivava dalla spesa pubblica superava abbondantemente il 50%.
Tuttavia, l’insegnamento keynesiano è stato mal digerito dalla società, che, avendo “naturalizzato” il rapporto di lavoro salariato, ha finito con l’ignorare le differenze tra la prima fase dello sviluppo di questo rapporto, quando il capitale trainava la riproduzione della società, e la seconda fase, quando la riproduzione sociale in forte espansione è stata trascinata prevalentemente dalla spesa della pubblica amministrazione. Per l’ingenuo senso comune si è trattato di una pura e semplice crescita del lavoro salariato, come “naturalmente” sarebbe dovuta intervenire! E’ paradossale come gli economisti conservatori abbiano, in questi anni, sottolineato questa differenza al tempo stesso negandone il valore storico, quando si sono lamentati che praticamente tutta l’occupazione aggiuntiva creata in Europa tra la Seconda guerra mondiale e l’inizio degli anni Ottanta è stata occupazione pubblica 139. Illudendosi poi, con l’ondata neoliberista, che un ridimensionamento dell’occupazione pubblica avrebbe potuto stimolare un dispiegamento aggiuntivo di lavoro, derivante da una rinnovata subordinazione di questa attività al capitale.
Dal canto loro molti economisti non conservatori hanno classificato la fase dell’espansione keynesiana come un “glorioso trentennio”. Ma, dimentichi del discorso keynesiano di lungo periodo, hanno pensato che la soluzione che garantiva la “gloria” non sarebbe stata transitoria, bensì definitiva. Un’opportuna miscela di laissez faire privato e di intervento pubblico avrebbe cioè consentito, secondo gli economisti degli anni Sessanta, tutti sedicenti keynesiani, di gestire illimitatamente i processi di sviluppo. Quando sono sopravvenute delle nuove difficoltà, e si è aperto il terzo periodo della storia della riproduzione del rapporto di lavoro salariato, essi hanno finito così con l’essere completamente spiazzati e col non comprendere i nuovi problemi.
Il nocciolo di questa nuova fase storica è stato ben riassunto da Giorgio Lunghini quando ha affermato che, a partire dagli anni Settanta “si è spezzato il nesso tra aumento della produzione e aumento dell’occupazione” 140. Va notato che il sussistere di questa eventualità era già stato al centro dell’attenzione di Keynes negli anni Trenta, quando aveva dovuto valutare una delle proposte alternative a quella che avanzava: quella secondo la quale l’unica via d’uscita dalla Grande Crisi avrebbe potuto essere quella di una drastica riduzione generalizzata dell’orario di lavoro (141). Keynes la scartò sostenendo che, nonostante l’abbondanza di capitale, le condizioni materiali di vita dell’epoca erano ancora troppo miserevoli per convenire con i sostenitori della non riproducibilità del lavoro salariato sulla scala necessaria a garantire il pieno impiego, fermo restando l’orario prevalente (142). Cosicché esisteva ancora un nesso positivo tra aumento della produzione e aumento dell’occupazione. Certo, come abbiamo appena visto, questo lavoro avrebbe potuto essere prodotto solo su una nuova base sociale, nella quale l’arricchimento sarebbe dovuto conseguire da un modo di consumo per sua natura apertamente sociale – i diritti sociali – e scaturire da decisioni consapevolmente elaborate attraverso iniziative pubbliche, che non subordinavano più il consumo necessario ed aggiuntivo all’accumulazione. Ma c’erano troppi bisogni primari insoddisfatti per poter decretare che “il lavoro immediato avesse cessato di essere la fonte dell’arricchimento”. Vale a dire che la produzione aggiuntiva di ricchezza sociale dipendeva ancora dall’erogazione di un lavoro aggiuntivo, anche se questo non sarebbe stato tale da garantire direttamente un’accumulazione di valore (143).
Tuttavia, che nel lungo periodo lo sviluppo della grande industria minasse il futuro del lavoro salariato (144) era per Keynes – come per Marx! – indubitabile. Se, grazie alle politiche del pieno impiego, gli esseri umani avessero imparato ad evitare il ripetersi di crisi disastrose, avessero inoltre saputo prevenire guerre distruttive, come quelle che si erano succedute per tutta la storia precedente, oltre a conquistare un controllo sui processi demografici, “la scoperta di mezzi che economizzano l’uso del lavoro avrebbe, nel giro di qualche generazione, superato il tasso al quale si sarebbero potuti trovare nuovi usi per il lavoro”(145). E dunque la fase di una riproduzione su scala allargata del lavoro salariato mediata dall’intervento dello stato sarebbe giunta anch’essa al termine (146), appunto perché le dinamiche distruttive, che in passato avevano di volta in volta costretto la società a tornare indietro, sarebbero state inibite, mentre gli effetti positivi dell’aumento della produttività avrebbero potuto dispiegarsi nella loro pienezza, emancipando l’umanità economicamente sviluppata dalla miseria.
Per gli economisti di sinistra che si stracciano le vesti di fronte all’espressione “fine del lavoro” questa periodizzazione sarebbe del tutto strampalata. Ma essi non ce ne forniscono un’altra. 147 O meglio, a loro avviso i rapporti capitalistici si sarebbero riprodotti immutati, nell’essenza, dal momento della loro genesi ad oggi. La configurazione che il lavoro salariato ha assunto nei “trenta anni gloriosi” non sarebbe così altro che “un interludio temporaneo e instabile della lunga storia del capitale, che non avrebbe senso assumere come paradigma” nell’analizzare questa relazione. 148 Molti di loro si spingono fino al punto di considerare lo stesso Stato sociale solo come una forma dissimulata di dominio della borghesia, negando che nella seconda metà del Novecento sia prevalso quel “diverso rapporto con le condizioni sociali della riproduzione” del quale ha parlato Marx, descrivendo la differenza tra una misura della ricchezza definita in termini di “reddito” invece che in termini di “capitale”. Insomma, questi pensatori negano che la vita degli esseri umani in ogni epoca è sempre un impasto confuso di varie età, non ben lievitato in tutte le sue parti, mal cotto, pieno di residui di vecchi elementi (ma anche) di fermenti di nuovi, con un continuo mutamento del peso relativo di vari modi di riprodurre l’esistenza umana. Ad ogni stadio troveremmo sempre e soltanto un organismo caratterizzato da una forma sociale, che talvolta viene accolta favorevolmente, mentre altre volte genera contrasti, che le classi egemoni cercano di risolvere con la dissimulazione ideologica dei problemi che si presentano. Ciò che sarebbe avvenuto anche per tutta la seconda metà del XX secolo, con la conseguenza che quello della riproducibilità o meno del lavoro salariato sarebbe un falso problema.
Capitolo quarto
Esiste un unico paradigma dell’evoluzione del rapporto salariale?
Ovvero, il lavoro salariato è al di fuori della storia?
Il rapporto di lavoro salariato non è un rapporto “naturale”. “La natura”, scrive ironicamente Marx, “non produce da una parte possessori di denaro o di merci e dall’altra puri e semplici possessori della propria forza lavorativa”. E aggiunge: “questo rapporto non è un rapporto risultante dall’evoluzione naturale e neppure un rapporto sociale comune a tutti i periodi della storia. Esso stesso è evidentemente il risultato di uno svolgimento storico precedente, il prodotto di molti rivolgimenti economici, del tramonto di tutta una serie di formazioni più antiche della produzione sociale”149. Il lavoro salariato come base della produzione generale è dunque un’espressione dell’imporsi dei rapporti capitalistici 150. Come ci ricorda Heilbroner nell’introduzione al testo di Rifkin, nel 1810 negli USA appena 75.000 persone erano impiegate come “salariate” nel neonato settore manifatturiero. In Inghilterra, paese allora all’avanguardia nel tentativo di imporre i rapporti borghesi, il numero era all’epoca superiore, ma non di molto. Insomma, in piena corrispondenza con il peso marginale dei rapporti capitalistici che cominciavano ad affermarsi, il lavoro salariato di tipo produttivo era una relazione sociale ancora in gestazione. 151 Esso è dilagato solo in un secondo momento, con l’espandersi di quei rapporti. E, in quei paesi che hanno imboccato con decisione la via dello sviluppo borghese, è diventato la forma dominante di partecipazione al processo di produzione, con la conseguenza che può giustamente essere considerato come una creatura generata e allevata dal capitale.
Ma una volta che, nei paesi investiti da questo sviluppo, la gran massa degli individui è stata trasformata in lavoratori salariati, una volta, cioè, che l’evoluzione dei rapporti capitalistici ha da lungo tempo raggiunto il momento della fioritura 152, si deve per forza continuare a considerare lo spazio nel quale il lavoro salariato può manifestarsi come espressione esclusiva del potere sociale del capitale? O si può invece avanzare l’ipotesi che, fermo restando il bisogno del capitale di creare lavoro per alimentare il processo di accumulazione, la domanda di una parte crescente della forza lavoro sia potuta – o in talune circostanze addirittura sia dovuta – provenire anche da una qualche altra soggettività? Un soggetto che ha perseguito e può perseguire scopi diversi da quello della continua crescita del valore, come ad esempio quello della piena occupazione e della soddisfazione dei bisogni primari 153? Insomma, per quale ragione la pianta del capitalismo, dopo la sua straordinaria fioritura, avrebbe dovuto essere esente da un possibile appassimento? Ancora di più, ma questo è un problema che affronteremo più avanti, si deve considerare il lavoro salariato come una forma di attività che è in grado di mediare qualsiasi sviluppo, perché esprime una forma della soggettività pienamente coerente con la condizione umana, o si deve invece verificare l’ipotesi, avanzata da alcuni studiosi, che quell’attività possa non essere all’altezza dei bisogni che tendono a prender corpo quando la libertà degli esseri umani dal bisogno immediato cresce significativamente? Formulando la questione in altri termini: possono gli individui, imparando a praticare altre forme di proprietà, diventare più umani di quanto lo siano diventati attraverso lo sviluppo della proprietà privata 154 e creare allo stesso tempo una ricchezza alternativa, la cui produzione viene ostacolata da quel rapporto?
La “rivoluzione keynesiana” è una leggenda?
Come abbiamo visto sopra, ci sono molti economisti, anche di sinistra, che insistono su una sostanziale invarianza del “paradigma”, che consentirebbe di seguire le vicende del lavoro salariato. Tempo fa Bellofiore 155 lo ha fatto con maggior chiarezza e determinazione rispetto ai molti altri che si limitano ad esprimere un confuso disagio. Ma per far questo ha dovuto negare ogni validità alla periodizzazione che abbiamo proposto nel precedente capitolo. Per lui non saremmo cioè “dove”, con le considerazioni sopra svolte, ci è sembrato che la nostra società sia giunta. Ci troveremmo sì in un mondo che non è immediatamente uguale a quello di due secoli fa, ma non si tratterebbe di un altro mondo, perché la forma delle relazioni dominanti oggi non sarebbe molto dissimile, nella sostanza, da quella che ha prevalso tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX. In altri termini, l’evoluzione sociale sarebbe intervenuta unicamente all’interno del legame sociale che unisce il lavoro salariato, come soggetto subordinato, al solo capitale, come soggetto egemone156. Un’egemonia che non sarebbe stata intaccata dagli sviluppi del Novecento, visto che fino al crollo borsistico del 2008 “il capitale avrebbe goduto di ottima salute”. 157 Seguiamo dunque le sue considerazioni, per valutare se la critica, condivisa da buona parte del senso comune di sinistra, sia recepibile.
“Spesso, nella discussione degli ultimi anni,” scrive il nostro Autore, “si è attribuita l’etichetta di ‘keynesiano’ all’intero trentennio che segue la fine del secondo conflitto mondiale”. (Un’attribuzione che, indubbiamente, in questo testo abbiamo posto in essere, e che, negli scritti degli ultimi venti anni, in numerosa compagnia, abbiamo ripetutamente avanzato, dopo averla elaborata all’inizio degli anni Settanta. 158) “Il keynesismo di cui si parla”, sottolinea criticando questa periodizzazione, “sarebbe stato la risposta ‘dall’alto’ 159 alla crisi della domanda degli anni Trenta, indotta dal salto organizzativo e tecnologico, prima di Taylor e poi di Ford, a fronte del sottoconsumo delle masse. Tale risposta sarebbe consistita, per un verso in una crescita della domanda di consumi parallela alla crescita della produttività, e, per l’altro verso, in una spesa pubblica in disavanzo.” Ma a suo avviso questa ricostruzione non solo fornirebbe “un quadro alquanto sbrigativo” ma costituirebbe “poco meno di una leggenda”. Questa critica radicale cerca un sostegno in una serie di argomentazioni, che analizzeremo criticamente in modo circostanziato.
La prima riserva, di natura squisitamente teorica, ci viene contrapposta nei seguenti termini. “Per cominciare, non si può attribuire a Keynes l’idea che i consumi trainino la domanda effettiva e, quindi, il reddito. Sono semmai, gli investimenti privati, la spesa pubblica e le esportazioni nette ad essere le componenti autonome, cioè ‘indipendenti’ della domanda, che si trascinano (!) dietro i consumi”. 160 Chi conosce i testi di Keynes sa però che egli non partecipa affatto di questo approccio monistico alla spiegazione dei fenomeni economici. Nel suo pensiero il consumo si presenta, né più e né meno di come accade in Marx 161, come un elemento subordinato, che però retroagisce a sua volta come componente problematica e determinante di ciò che di volta in volta lo determina. Per rifiutare questo punto teorico essenziale del keynesismo bisogna cadere nell’errore che Keynes stesso imputava agli economisti ortodossi, i quali credevano che “il capitale fosse un’entità capace di autosostenersi e di esistere a prescindere dal consumo”. 162 O, peggio ancora, che trascinasse sempre il consumo possibile. Che una simile illusione potesse imporsi nella prima fase dello sviluppo dei rapporti capitalistici – cioè nel corso del XIX secolo – non era del tutto insensato. La miseria era tale che lo sviluppo dei mezzi di produzione poteva ragionevolmente apparire come un fine in sé, perché il consumo potenziale sarebbe sempre stato all’altezza dell’offerta praticabile. Ma la teoria di Keynes si risolse proprio nel riconoscimento che il sopravvivere di questa convinzione ancora nel XX secolo fosse ingiustificato. Non tedieremo il lettore con una valanga di citazioni; ma qualche riferimento è necessario.
Aprendo la Teoria generale con una confutazione della legge di Say 163, Keynes critica proprio l’ipotesi – sostanzialmente ortodossa – secondo la quale le componenti della domanda che conseguono alle decisioni degli imprenditori “trascinino” sempre e necessariamente dietro di sé i consumi. Se così fosse, la produzione capitalista non soffrirebbe di alcun grado di contraddittorietà, perché la domanda garantirebbe sempre uno sbocco adeguato all’offerta 164, e dunque ogni sovrapproduzione sarebbe impossibile. Ma nel mondo dei rapporti mercantili, e della forma di proprietà che ad essi corrisponde, il consumo gode – o, meglio soffre! – di una sua autonomia 165, e dunque si presenta come un elemento problematico, che a parere di Keynes va sottoposto ad un controllo consapevole, né più e né meno delle altre variabili macroeconomiche. 166 L’obiezione deve dunque essere accantonata, riconoscendo che in Keynes, e nelle strategie di politica economica che propone, i consumi costituiscono un elemento essenziale, determinante 167 nel decidere il livello dell’attività produttiva e nello stabilire la misura del prodotto effettivo; che essi non intervengono cioè nella dinamica economica come un elemento passivamente trascinato alla Say. Ma c’è di più: prima di Keynes la mera esistenza di una propensione al consumo di gran parte della società non era condizione sufficiente per procedere alla produzione, perché gli imprenditori capitalisti si muovevano solo di fronte ad una domanda che appariva certa, e che, per di più, avrebbe garantito anche una eccedenza dei ricavi sui costi. Keynes afferma invece che la propensione al consumo va sostenuta anche quando non è ancora in grado di assumere spontaneamente la forma di una domanda, appunto perché in genere esprime bisogni esistenti, ai quali è necessario offrire l’opportunità di manifestarsi – rendendoli cioè solvibili – per ottenere un prodotto che l’indagine economica dimostra tecnicamente producibile, ma che non verrebbe prodotto sulla base delle relazioni sociali capitalistiche lasciate a se stesse 168. Inutile dire che, in tal caso, la solvibilità di quei bisogni potrebbe essere assicurata solo da un intervento esterno rispetto al processo riproduttivo del capitale 169, visto che la produzione non potrebbe essere remunerativa, e dunque il capitale non potrebbe e non vorrebbe porla in essere. In altri termini, il prodotto aggiuntivo che consegue dal gioco a somma positiva di tipo capitalistico, non può tornare capitalisticamente in circolo senza determinare un risultato negativo – le perdite d’impresa – ma può tornare in circolo grazie alla spesa pubblica, perché l’espansione dei consumi assicura un risultato positivo, non attraverso l’accrescimento del capitale, bensì attraverso l’accrescimento del reddito. Cioè attraverso una modificazione del gioco.
D’altra parte, quando nel 1919 Keynes costruisce l’innervatura della conoscenza che lo spingerà in direzione di una vera e propria “rivoluzione” teorica, lo fa nei seguenti termini: nell’Ottocento “l’Europa era organizzata, dal punto di vista sociale ed economico, in modo da assicurare la massima accumulazione di capitale. Nonostante si verificasse un qualche continuo miglioramento nelle condizioni di vita della massa della popolazione, la società era strutturata in modo da sottomettere al controllo della classe che meno probabilmente l’avrebbe consumato la maggior parte dell’accresciuto reddito. I nuovi ricchi del XIX secolo non erano stati educati a porre in essere grandi spese in consumi, e preferivano il potere che derivava loro dall’investimento ai piaceri del consumo immediato. Di fatto fu proprio l’ineguaglianza nella distribuzione della ricchezza che rese possibile quell’ampia accumulazione di capitale fisso e i suoi miglioramenti, che hanno contraddistinto quell’era da tutte le altre. In ciò giaceva la maggiore giustificazione del sistema capitalistico. Se i ricchi avessero speso la loro nuova ricchezza per il loro godimento, il mondo avrebbe trovato da lungo tempo un simile sistema intollerabile. Ma come formiche essi hanno risparmiato e accumulato, avvantaggiando in tal modo l’intera società, nonostante agissero con prospettive più anguste. L’immensa accumulazione di capitale fisso che, con grande beneficio per l’umanità, è stata realizzata nel mezzo secolo che ha preceduto la guerra non avrebbe mai potuto aver luogo in una società nella quale la ricchezza fosse stata divisa equamente. Le ferrovie del mondo, che quell’era ha costruito come un monumento per la posterità, furono, non meno delle piramidi d’Egitto, il risultato di un lavoro che non era libero di consumare nel godimento immediato il pieno equivalente della sua attività.”
“Quel sistema rimarchevole dipendeva, così, per il suo sviluppo da una duplice illusione o inganno. Da un lato, le classi lavoratrici accettarono per ignoranza o impotenza, o furono obbligate, persuase, o vincolate ad accettare … una situazione nella quale potevano considerare come propria solo una piccola parte della torta che esse, i capitalisti e la natura cooperavano a produrre. E, dall’altro lato, alle classi capitaliste era permesso di indicare come propria la parte migliore della torta, e di considerarsi astrattamente libere di consumarla, alla condizione tacitamente implicita che, in pratica, ne consumassero solo una piccolissima parte. Il compito di ‘risparmiare’ [per investire] divenne quasi l’unica virtù e la crescita della torta lo scopo della vera religione…. In tal modo la torta crebbe; ma a quale scopo non era chiaramente contemplato. Gli individui non erano tanto esortati ad astenersi quanto a rinviare, e a coltivare i piaceri della sicurezza e della prefigurazione. Il risparmiare era ‘per la vecchiaia’ o ‘per i figli’; ma ciò era vero solo in teoria – la virtù della torta stava proprio nel suo non dover essere mai consumata. In ciò che sostengo,” aggiungeva poi, “non c’è alcun disprezzo implicito nei confronti del comportamento di quelle generazioni.170 Negli inconsci recessi del suo essere la società sapeva ciò che stava facendo. La torta era in realtà troppo piccola in proporzione agli appetiti del consumo, e nessuno, se fosse stata divisa tra tutti, sarebbe stato meglio. La società non stava lavorando per i piccoli piaceri correnti, ma per la sicurezza futura e per il miglioramento della specie – cioè per il ‘progresso’. Se solo la torta non fosse stata divisa, e si fosse riusciti a farla crescere in progressione geometrica … forse sarebbe giunto un giorno nel quale ce ne sarebbe stata abbastanza per tutti e nel quale la posterità avrebbe potuto iniziare a godere dei frutti del lavoro. … Desidero solo evidenziare”, concludeva, “che il principio dell’accumulazione fondato sull’ineguaglianza era una componente essenziale dell’ordine prebellico della società e del progresso, per come lo intendevamo. Ma desidero anche sottolineare che questo principio dipendeva da condizioni psicologiche instabili, che potrebbe essere impossibile ricreare. Non era naturale che una popolazione nella quale così pochi godevano dei conforti della vita accumulasse così tanto. La guerra ha dischiuso la possibilità del consumo per tutti e l’inutilità dell’astinenza di molti. In tal modo l’inganno è stato scoperto; le classi lavoratrici potrebbero non essere più disposte a rinunciare così tanto, e le classi capitaliste, non più fiduciose nel futuro, potrebbero cercare di godere più pienamente della libertà di consumare, fintanto che dura. Anche se in tal modo non faranno altro che accelerare l’ora della loro espropriazione.”171
Com’è noto a chi conosce i tratti essenziali della storia moderna, la Gran Bretagna non diede grande ascolto ai suggerimenti di Keynes per più di venti anni, cioè fino alla Seconda guerra mondiale; ma egli non si stancò mai di insistere su questo punto, visto che nelle “Note conclusive” della Teoria generale, scritte nel 1936, sostenne: “la nostra argomentazione ci conduce pertanto a desumere che, nelle attuali condizioni, la crescita della ricchezza, lungi dal dipendere dall’astinenza dei ricchi, come comunemente si crede, è con ogni probabilità ostacolata da essa”. Con la conseguenza che “degli interventi finalizzati a ridistribuire il reddito in modo da far crescere la propensione al consumo possono dimostrarsi favorevoli alla crescita del capitale” 172 Da questo punto di vista si fa torto a Keynes se si riduce il suo insegnamento alle varie “sintesi” operate dagli economisti successivi, tutti impegnati a sbarazzarsi della componente analitica di rottura del keynesismo nei confronti dell’ortodossia. E, d’altra parte, se si nega la rilevanza del consumo nel sistema teorico keynesiano, poco tempo dopo aver sostenuto, come ha fatto qualcuno dei nostri critici, che “è improbabile che una crisi da realizzo venga impedita grazie ad un aumento ‘spontaneo’ 173 degli investimenti – se questi ultimi dipendono, come vi è ragione di credere, da una domanda futura di consumi” 174, si cade in un’evidente contraddizione.
Si fa poi torto all’esperienza storica quando si sostiene che, “in effetti, lo sviluppo postbellico fu prodotto da un eccezionale dinamismo di tutti e tre gli ingredienti della domanda autonoma”. 175 Si vuol in tal modo forse sostenere che tra il periodo del primo sviluppo dei rapporti capitalistici, così ben descritto da Keynes, e il mondo dei rapporti che sono venuti a maturazione tra la fine della Prima guerra mondiale e quello che è noto come Stato sociale, non ci siano significative differenze? Si vuol cioè aderire alla lettura revisionistica, così ben espressa tempo fa da Cohen, secondo la quale: “il successo delle idee keynesiane fu immenso, ma c’è qualche confusione tra l’efficacia delle sue ricette e la riuscita del recupero economico del dopoguerra dei paesi dell’OCSE. E’ ora (!) abbastanza chiaro che il ricorso alle politiche keynesiane non fu tanto la causa dei successi economici del dopoguerra, ma che piuttosto il brillante procedere di quegli anni rese possibile l’attuazione pratica delle idee keynesiane”? 176 Basta dare un’occhiata al grafico che segue, nel quale sono riportati i salari orari reali negli Stati Uniti per il periodo 1840-1960, per rendersi conto che la storia va nella direzione indicata da Keynes, e non in quella proposta dai molti economisti “revisionisti”.
Salario medio operaio a valori costanti USA 1840-1960
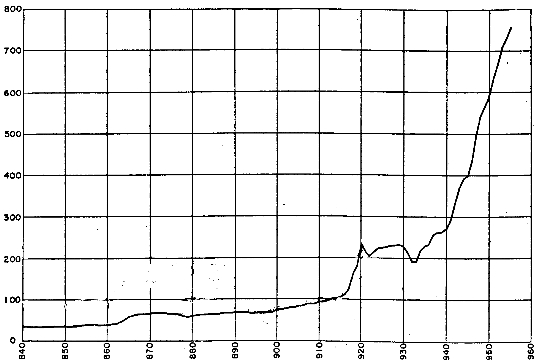
Fonte: Neil W. Chamberlain, Labor, McGraw-Hill, New York 1958. (Elaborazione su dati del Bureau of Census USA).
Si badi bene come il punto di svolta, nel quale sopravviene una “metamorfosi del consumo da vizio a virtù”, corrisponda proprio al momento storico indicato da Keynes, quando ha sottolineato che, dopo la Prima guerra mondiale, le classi lavoratrici non avrebbero più tollerato una situazione – di fame – come quella che aveva caratterizzato il secolo precedente.
Dopo settant’anni di salari in lieve crescita, a fine conflitto ha infatti inizio una rapida ascesa, che, col trionfo del keynesismo nel dopoguerra – il quale pone il consumo delle masse come fattore dello sviluppo, ben al di là di quanto aveva fatto il fordismo – assume un andamento addirittura esponenziale177.
D’altronde, anche gli studiosi più ingenui sanno che, per descrivere uno dei profili caratterizzanti della realtà sociale che ha preso corpo nella prima metà, e che è esplosa nella seconda metà del XX secolo, si è ricorsi al concetto di consumismo. Dovremmo forse concludere che si tratta solo di un’iperbole, che non ci aiuta a comprendere l’evoluzione sociale, o dovremmo invece riconoscere che in qualche modo quel termine si riferisce ad un elemento dinamico nuovo della realtà sociale che era allora in formazione, e che è giunto a maturazione nel “mondo keynesiano”?
Il quesito è ovviamente fondamentale, e anche chi si oppone alla periodizzazione che abbiamo proposto lo aveva risolto, in passato, in modo decisamente diverso, sostenendo che “è possibile interpretare …la grande crisi degli anni Trenta come una crisi di sovrapproduzione. La via d’uscita concretamente sperimentata alla crisi fu, com’è noto, l’ampliamento del consumo improduttivo 178 e lo stato interventista, (cioè) il keynesismo” 179. Quale delle due opposte tesi è vera? A nostro avviso quella che stiamo cercando di riprendere in questa sede, in quanto offre un senso alla verificabilità del problema della riproduzione del rapporto di lavoro salariato.
Gli economisti ortodossi, dal canto loro, hanno buon gioco nel sottrarsi al dilemma. La loro rappresentazione dei rapporti capitalistici è tale da includere il consumo crescente come movente immediato dello stesso imprenditore. Nel loro sistema di pensiero non c’è alcuna opposizione tra la natura astratta della ricchezza prodotta – il valore di scambio delle merci – e la sua forma concreta – il loro valore d’uso. Cosicché la produzione capitalistica non si distinguerebbe dalle forme di produzione che l’hanno preceduta, ed il maggior prodotto finale di volta in volta ottenuto si riverserebbe sempre in consumi aggiuntivi. Ma Marx e Keynes 180 avevano un’idea profondamente diversa della dinamica propria dei rapporti capitalistici – dei quali sottolineavano la specificità storica. E su quella base hanno ricostruito l’imporsi di una prima fase nella quale è prevalsa una tendenza alla “produzione per la produzione” come meccanismo che, nel garantire l’arricchimento della borghesia industriale, ha mediato il processo di riproduzione su scala allargata del lavoro salariato. 181 In quella fase il capitale ha agito come se la domanda non dovesse mai rappresentare un ostacolo all’accumulazione, appunto perché, a suo avviso, il consumo avrebbe sempre seguito inerzialmente l’offerta, e pertanto poteva e doveva essere limitato, per consentire all’accumulazione di creare le condizioni per la soddisfazione degli infiniti bisogni, senza che da ciò conseguisse alcun problema riproduttivo strutturale. Producendo valore su scala allargata, i capitalisti astraevano sistematicamente dal valore d’uso, cioè da quel momento, il consumo, nel quale il prodotto si realizza e dà il finishing stroke al processo riproduttivo, creando le condizioni fisiologiche di un nuovo inizio della produzione. E ciò era “giusto”, appunto perché il livello del consumo era miserevole e una sua espansione inebitabile. Gli ortodossi hanno assecondato l’illusione, alla Say 182, che le cose avrebbero potuto procedere all’infinito sulla base di questo principio, perché l’offerta, data l’insaziabilità degli appetiti, avrebbe sempre e comunque incontrato una domanda. Ma le ricorrenti crisi hanno minato alla radice questa convinzione, aprendo uno spazio sociale al keynesismo e alle lotte che, senza necessariamente riferirsi a quella corrente culturale, tendevano a mutare i rapporti di potere. Tutto ciò nonostante, sul piano ideologico, il capitale 183 abbia quasi sempre continuato a sostenere la tesi di una sua incondizionata capacità di espandere non contraddittoriamente la produzione, attraverso l’accumulazione.
Il keynesismo, che prima di vincere è cresciuto su una situazione di ristagno che in Gran Bretagna 184 si è protratta per un ventennio ed è sfociata in una grave crisi mondiale, ha sfondato definitivamente proprio su questo terreno, convincendo anche i capitalisti che il recedere dell’antagonismo nei confronti del consumo a livello aziendale non bastava, perché il problema era quello di coordinare la propensione al consumo dell’intera collettività con l’offerta potenziale che il sistema nel suo complesso era in grado di porre in atto. Il keynesismo è dunque corrisposto al rifiuto della normalità di un qualsiasi tasso di disoccupazione 185 che non fosse dovuto a difficoltà tecniche di impiego della forza lavoro, visto che una parte rilevante della forza lavoro resa superflua dall’accumulazione capitalistica avrebbe potuto essere utilizzata nella soddisfazione immediata dei bisogni collettivi esistenti nel tessuto sociale. E ciò sarebbe corrisposto ad una specifica forma di espansione dei consumi mediata dall’intervento dello stato, oltre all’espansione dei consumi privati, determinata dagli effetti moltiplicativi della spesa pubblica.
La società, che masticava poco di questioni di tipo economico e ancora meno coglieva il senso di fenomeni sociali di natura paradossale come quello di una “povertà causata dall’abbondanza” 186, ha recepito il nocciolo dell’argomentazione keynesiana in termini solo politici 187 – rappresentandosela cioè come affermazione volontaristica di un sistema di nuovi diritti sociali 188 da far poggiare non già sulle problematiche economiche imposte dalla crisi, ma su principi etici di tipo redistributivo. Nella fase espansiva delle strategie keynesiane, questo approccio politicistico non ha inibito lo sviluppo, anzi, rivestendo le rivendicazioni di un’aura di “naturalità”, le ha semplificate, finendo col rafforzarle. Precisa in merito Cohen, “com’è stato dimostrato da Delorme e André 189, il Welfare State si è quasi imposto: col passare del tempo la società ha rivendicato sempre più diritti all’educazione, alla cura e alle pensioni, e queste rivendicazioni hanno sempre sopravanzato i programmi governativi”. 190
Per avere un quadro sufficientemente definito della dinamica di questa seconda fase in rapporto al ruolo del consumo, va ricordato che le proposte keynesiane non erano state le uniche a calcare la scena sociale degli anni Trenta come rimedio eterodosso alla crisi. Non a caso, nella Teoria generale, Keynes contrappose ai propugnatori della riduzione generalizzata dell’orario di lavoro, che gli contendevano il campo nel contrasto con gli ortodossi, le seguenti inequivocabili argomentazioni: “un’altra scuola di pensiero afferma che la soluzione dei problemi inerenti alle oscillazioni cicliche, non vada ricercata né nell’incremento dei consumi né degli investimenti, bensì nella riduzione dell’offerta della forza lavoro in cerca di occupazione; vale a dire, nella redistribuzione dell’esistente ammontare di lavoro senza procedere ad alcun aumento dell’occupazione o del prodotto. Tuttavia, questa a me sembra una politica prematura – molto prematura rispetto ad un programma di espansione del consumo. 191 C’è un livello al quale ogni individuo soppesa i vantaggi derivanti da un aumento del tempo disponibile rispetto ad un accrescimento del suo reddito. Ma attualmente c’è, a mio avviso, una forte evidenza che la maggior parte degli individui preferirebbe un maggior reddito ad un maggior tempo disponibile, ed io non vedo alcuna ragione per costringere quelli che preferirebbero un maggior reddito 192 ad accondiscendere a più tempo libero” 193.
Si osservi la continuità con le considerazioni del 1919. Il lavoro salariato può sì essere riprodotto su scala allargata, ma la mediazione che garantisce questa espansione è, appunto, quella di una crescita della produzione di valori d’uso, della soddisfazione diretta dei bisogni, i quali, per farsi valere come necessari, e non essere più subordinati alle decisioni delle imprese, finiranno con l’assumere la veste di “diritti”. Insomma o la società riconosce che è giunto il momento di godere più pienamente della ricchezza materiale producibile nel consumo di massa, o se invece punta a metabolizzare solo il consumo necessario a garantire un ulteriore accrescimento del capitale è destinata ad un ristagno senza fine. Quest’ultimo orientamento fa infatti precipitare la società in una situazione che non le consente più di trasformare il lavoro che rende superfluo con l’innovazione tecnica in nuovo lavoro. 194 In altre parole, spreca i frutti del gioco a somma positiva precedentemente ottenuti, a causa della propria incapacità di introdurre un altro gioco a somma positiva.
Essendo, quello che abbiamo appena richiamato, solo un risvolto del cambiamento che abbiamo già colto dal lato della dinamica dei salari è ovvio che dobbiamo ritrovare un andamento analogo anche dal lato della dinamica dei consumi. E infatti, come ci insegnano anche i manuali di più ampia divulgazione 195, a partire dagli anni Cinquanta e solo allora, il consumo comincia a crescere ovunque con un andamento esponenziale. In definitiva, se non ci si accomoda sull’ipotesi un po’ paranoica che lo Stato sociale – cresciuto dopo la Seconda guerra mondiale, soprattutto sulla base delle conoscenze che il keynesismo 196 ha imposto all’economia politica – sia stato solo un diversivo al quale la borghesia è ricorsa per conservare la sua egemonia1 97, si deve esplorare la possibilità che, nel “trentennio glorioso” il lavoro salariato si sia riprodotto in un modo che non è coinciso interamente con la riproduzione del capitale nelle forme date 198.
Se le cose stanno nei termini da noi suggeriti, abbiamo tre problemi con i quali dobbiamo confrontarci. In che misura il lavoro che non rientra nel paradigma lavoro salariato-capitale è cresciuto? In che misura il lavoro che rientra in quel paradigma ha potuto essere riprodotto grazie a forze esterne rispetto a quel rapporto, determinando una situazione di dipendenza del capitale da soggetti altri? Infine, per quale ragione anche il lavoro salariato che è stato generato sulla base di questo rapporto innovativo ha finito con l’incappare in un limite? Vale a dire: per quale ragione lo stato, ad un certo punto, non ha potuto continuare a praticare non contraddittoriamente la funzione di occupatore in ultima istanza, che molti keynesiani, ma non Keynes, hanno pensato di potergli illimitatamente attribuire?
Ma prima di entrare nel merito di questi tre quesiti dobbiamo fare i conti con quelle che a noi sembrano costituire altre distorsioni, questa volta storiche, che hanno consentito ad alcuni studiosi di confutare la periodizzazione che abbiamo proposto.
Capitolo quinto
Qualche precisazione storica
Ci sono altre tre argomentazioni alle quali, nella loro diatriba contro i teorici della “fine del lavoro”, alcuni studiosi ricorrono spesso; argomentazioni che, a nostro avviso, non trovano un adeguato riscontro storico. Affrontiamole sinteticamente.
La distribuzione del reddito con lo Stato sociale sarebbe rimasta immutata
Sostiene qualche autore che, nonostante l’inedita crescita dei salari reali, anche nel trentennio keynesiano questi restarono sempre indietro rispetto alla produttività, e il salario relativo registrò una caduta, secondo la tendenza propria del modo di produzione capitalistico. 199
Poiché in ogni sistema teorico degno di rispetto “tutto si tiene” – nel senso che ogni argomentazione analitica trova un sostegno nelle altre – è fuori di dubbio che, se le cose stessero realmente nei termini appena esposti, i critici dell’interpretazione che abbiamo avanzato sulla natura dello Stato sociale avrebbero pienamente ragione. Vale a dire che la specifica lettura del keynesismo che abbiamo fatto nostra, troverebbe una confutazione oggettiva in una crescita (o in una stabilità) della quota di reddito a favore dei profitti, che sarebbe intervenuta nel periodo in questione. Ma non è difficile dimostrare che le cose non stanno affatto come questa prima critica lascia intendere.
D’altra parte, una concisa confutazione dell’argomentazione circola anche tra coloro che dichiarano di non condividere la nostra ricostruzione. Essi sostengono infatti che “la crisi sociale degli anni Sessanta e Settanta, si è espressa fenomenicamente come compressione dei profitti”. Ora è evidente che nel rapporto diretto capitale-lavoro non è possibile riscontrare allo stesso tempo una “caduta del salario relativo” ed “una compressione dei profitti”, a meno che non ci si trovi di fronte ad una crisi come quelle che sopravvenivano prima dell’affermarsi del keynesismo, quando il prodotto interno lordo crollava drammaticamente del 20 o del 30%. Quasi tutte le svolte congiunturali negative dell’ultimo mezzo secolo, come mostra il grafico sulle crisi cicliche riportato a pag. 55, hanno comportato un transitorio blocco della crescita, ma non un vero e proprio crollo della produzione anche lontanamente comparabile con quelli del precedente secolo e mezzo. Pertanto, per necessità logica, i due fenomeni si escludono a vicenda. Se non c’è impoverimento generale, una delle due classi può cioè impoverirsi relativamente solo in quanto l’altra si arricchisce.
Quale delle due argomentazioni è dunque quella giusta? I dati statistici, nonostante la loro rozzezza, possono fornirci una prima grossolana indicazione di tendenza. La tabella che segue si riferisce alla situazione italiana, dove il cambiamento è quantitativamente più accentuato, e tuttavia non radicalmente diverso da quanto è avvenuto in altri paesi.
Tabella n. 3
Quota del reddito nazionale percepita dal lavoro dipendente in Italia
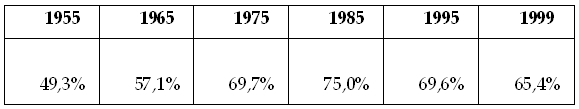
Fonte: ISTAT, Annuari statistici.
Tutte le possibili riserve sulla comparabilità dei dati, giustamente riconducibili alla diversa composizione della forza produttiva nazionale nei differenti momenti del mezzo secolo considerato, vengono ovviamente sbaragliate dallo straordinario ordine di grandezza del mutamento relativo statisticamente riscontrato: da metà del reddito corrente, nel dopoguerra, il lavoro salariato passa infatti, trent’anni dopo, ad appropriarsene i tre quarti. 200 L’onda di questo mutamento radicale fu così chiaramente riassunta dal Presidente della Confindustria verso la metà degli anni Settanta: “Ebbi la sensazione che fossimo definitivamente entrati in un sistema che potremmo definire di labour standard, in un sistema contraddistinto cioè dal salario come variabile indipendente 201. Fino al ’69 la politica monetaria aveva in qualche modo assorbito gli effetti degli squilibri insiti nel sistema ed aveva, sia pure in maniera imperfetta, contribuito alla conciliazione di vari obiettivi, ossia: un saggio di sviluppo soddisfacente, un’inflazione contenuta entro limiti accettabili, un sostanziale equilibrio della bilancia dei pagamenti esterni. Ma una volta che i sindacati riuscirono ad imporre un sistema di labour standard, rinforzato legislativamente da disposizioni quali la legge sullo Statuto dei lavoratori, ebbi la certezza che l’Istituto di emissione sarebbe stato sempre più espropriato della funzione di regolare la quantità di moneta”. 202
D’altra parte, alcuni economisti che conservano un’autonomia di giudizio rispetto alla corrente prevalente rappresentano l’evoluzione economica in termini molto vicini al nostro schema. 203 Sappiamo bene che poi 204 le cose cambiarono di nuovo. E infatti la serie di dati ci conferma anche che la spinta propulsiva del keynesismo, ad un’appropriazione di reddito più favorevole al lavoro salariato, e più in generale alle classi subalterne, si esaurisce poco dopo la recriminazione del Presidente della Confindustria, cosicché dopo la metà degli anni Ottanta assistiamo a un’inversione di tendenza. Ma nel periodo che va dagli anni Cinquanta agli anni Settanta i lavoratori riuscirono a far leva su una forza nuova per appropriarsi, pur gradualmente, di una quota crescente del reddito. Va, tra l’altro, tenuto presente che, nel prendere in esame la distribuzione del reddito, si deve anche tener conto del fortissimo incremento dei beni e dei servizi pubblici goduti per diritto che, essendo gratuiti, non si riflettono coerentemente nelle quantificazioni monetarie sopra riportate.
Per valutare la fondatezza della critica avanzata nei confronti della periodizzazione che abbiamo proposto, si potrebbero prendere altre misure. Ad esempio si potrebbe far riferimento alla distribuzione familiare del reddito e alle sue variazioni, assumendo implicitamente che una distribuzione meno diseguale corrisponda alla sottrazione di una parte dell’accresciuto reddito alle classi egemoni da parte delle classi subordinate e viceversa. Ma in questo caso il quadro 205 non risulterebbe affatto differente. Insomma, piaccia o no ai nostri interlocutori, nel corso degli anni Sessanta e Settanta 206 le classi subalterne di tutti i paesi economicamente avanzati hanno modificato – talvolta più, altre volte meno – a proprio vantaggio i rapporti di potere, espressi dalla quota di reddito della quale si appropriavano, e solo dalla metà degli anni Ottanta si impone una tendenza opposta. D’altra parte, se la dinamica prodotta dal keynesismo non fosse stata questa, e fosse invece corrisposta, alla “naturale” tendenza dei rapporti capitalistici, non si comprende perché sarebbe stata necessaria una reazione del capitale tesa a ristabilire condizioni più consone a quei rapporti. Paradossalmente numerosi economisti di sinistra insistono sul sussistere della reazione, ma confutano il verificarsi del fenomeno che sul piano logico avrebbe potuto determinarla.
Qui è necessario far cenno ad un’approfondita analisi della metà degli anni Settanta svolta da Roberto Convenevole. Quell’analisi sembra infatti convalidare l’ipotesi che, nel famoso trentennio, non abbia avuto luogo alcuna redistribuzione del reddito a favore del lavoro dipendente. Ma la tesi di Convenevole non contrasta affatto con la nostra convinzione, visto che lo porta a concludere che “se per tutto il periodo considerato si è verificata una precisa tendenza all’aumento del saggio del surplus dell’industria manifatturiera”, è tuttavia “mutata (anche) la capacità delle imprese di prelevare la propria quota di surplus”. 207 Poiché a nostro avviso questa è l’essenza del keynesismo – per il quale le aziende industriali dovevano continuare a produrre un surplus crescente, che avrebbe dovuto essere appropriato dalla società nel suo complesso attraverso la spesa pubblica – a noi sembra che le argomentazioni di Convenevole rafforzino la nostra periodizzazione, invece di confutarla.
I pareggi di bilancio registrati negli anni ’70 confuterebbero la strategia della spesa in deficit
Veniamo ora alla seconda obiezione, inerente alla spesa in deficit, come componente essenziale della strategia keynesiana, della quale secondo i critici della “fine del lavoro” non si troverebbe traccia nella reale evoluzione storica. E’ loro convinzione che i bilanci dello stato rimasero in sostanziale pareggio sin quasi alla fine degli anni Sessanta, pressoché dappertutto. La vicenda dei disavanzi sarebbe così una storia degli anni Settanta e Ottanta (quando ormai il keynesismo appariva in ritirata). Anche se sono disposti a concordare che vi fu un contributo alla crescita economica fornito da una spesa pubblica che aumentava in assoluto, assieme alle imposte. 208
Con questo ragionamento la carta vincente del keynesismo viene però usata contro Keynes, manipolando (o quanto meno fraintendendo) i termini del gioco interpretativo. La tesi di Keynes, riferita alla situazione dell’epoca, è nitida: lo stato deve spendere senza vincolare a priori la propria decisione di spesa a possibili rendimenti economici; ancora di più, deve spendere senza preoccuparsi della certezza di riuscire a coprire i costi che sostiene. Insomma, nel mentre soddisfa bisogni, la pubblica amministrazione non deve farsi limitare da una spinta a cercare di recuperare il denaro che spende – perché solo così riuscirà ad andare incontro ad una moltitudine di bisogni, che trascendono gli effetti diretti della sua spesa e che aspettano unicamente di trovare indirettamente un reddito nel quale esprimersi come domanda. Un reddito che incontreranno grazie alle spese poste in essere dai soggetti che verranno “pagati” dalla spesa pubblica e che, speso a sua volta, consentirà di generare altro reddito, per coloro che soddisfano la loro domanda.
La conferma della praticabilità di questa particolare via dello sviluppo, ben diversa da quella nella quale si esprimeva un’egemonia dalle finalità capitalistiche, non stava dunque nell’immediato sopravvenire di un deficit, bensì nel non verificarsi di un simile esito contabile. Occorre essere consapevoli della sequenza logica che è alla base delle strategie keynesiane. Una parte significativa della forza lavoro, portatrice di bisogni che potrebbero facilmente trasformarsi in domanda, non riesce ad incontrare il denaro che le consentirebbe di rendere quei bisogni socialmente validi, trasformandoli, appunto, in una domanda, perché, col sopravvenire della sovrapproduzione e del ristagno, risulta in esubero strutturale rispetto alle possibilità dell’accumulazione capitalistica. Per questo il capitale non torna ad assumerla, inibendo la possibilità di riconoscere a quei bisogni un potere sociale, espresso dal reddito di cui prima godeva lavorando. Se lo stato, per occupare quella forza lavoro avesse dovuto prima prelevare i soldi necessari a coprire la spesa, avrebbe inciso negativamente sulla domanda. In altri termini, avrebbe determinato una subordinazione di quei bisogni allo stesso principio che bloccava i capitalisti e l’instaurarsi di un’oggettiva concorrenza con le possibilità di sbocco della produzione privata, con un annullamento degli effetti positivi dell’intervento pubblico sul piano occupazionale.
Il sussistere di una simile domanda potenziale era, d’altronde, l’elemento che apparentemente sosteneva la validità della legge di Say – nella quale l’esistenza di bisogni insoddisfatti veniva confusa con la certezza della loro trasformazione in domanda effettiva – fornendo un alibi alle teorie ortodosse prekeynesiane 209, tutte tese a fare l’apologia del mercato concorrenziale. Quella domanda non poteva però manifestarsi perché avrebbe dovuto essere evocata da agenti che, perseguendo il fine dell’accumulazione, non potevano generarla, visto che, alle condizioni di scambio instauratesi, avrebbero quasi certamente subito delle perdite, cioè una dissoluzione di parte del denaro investito. E che cosa indicava quella modificazione in peggio delle ragioni di scambio? Che nel rapporto tra offerta e domanda, tra produzione e consumo, era sopravvenuto uno squilibrio, corrispondente al fatto che la crescita della prima aveva sopravanzato strutturalmente la crescita del secondo, con l’instaurarsi di una relativa abbondanza. Il valore prodotto non riusciva pertanto a realizzarsi nella sua interezza, perché il lavoro corrispondente era stato erogato senza tener conto della sua rispondenza alla domanda, cioè del suo essere socialmente metabolizzabile. Per questo i singoli, visti i prezzi in forte discesa, cercavano di conservare quel valore presso di sé, evitando una perdita, mediante un’astensione dall’investimento 210. Ma – e questo è il fulcro del sistema teorico keynesiano! – in una società che poggia sullo scambio, l’astensione dall’investimento genera un blocco dello stesso processo riproduttivo complessivo e uno spreco di risorse disponibili. 211 La mediazione dell’accumulazione, tutta tesa a conservare e a far crescere il potere del denaro, sfocia così in un decadimento dell’attività produttiva sociale, e rende evidente che la conservazione del potere del denaro poggia su una limitazione artificiale della produzione.
Posti di fronte a questa diagnosi, i conservatori replicavano: come si può mai agire produttivamente “se non ci sono i soldi”? La mancanza di soldi esprimeva per loro una carenza di risorse, e dunque li spingeva ad optare per una strategia di risparmi e sacrifici. Keynes obiettava che gli ortodossi non sapevano interpretare la dinamica sociale, perché la mancanza di soldi era piuttosto l’indice del tentativo dei proprietari privati di evitare delle perdite o di premunirsi per il futur 212, tentativo che, retroagendo sul corso del denaro, produceva l’effetto contraddittorio di causare perdite collettive maggiori di quelle che ciascuno cercava di non subire. Ogni soggetto che, in una situazione di difficoltà di sbocco del prodotto, evita una spesa possibile inaridisce la stessa sorgente dalla quale la ricchezza generale e, in un secondo momento, la sua stessa ricchezza scaturiscono. Egli infatti inibisce lo svolgimento di un’attività produttiva tecnicamente possibile, anche se non economicamente tale da garantire un profitto, e quindi inaridisce ulteriormente la capacità di compera, dalla quale la vendita che gli procura il denaro dipende 213. Detto in altri termini, poiché ciascuno tenta di salvarsi per proprio conto, senza badare alla salvezza degli altri, la nave non solo affonda, ma trascina con sé buona parte dei passeggeri e dell’equipaggio. Occorre trovare qualcuno che sappia cercare la salvezza – cioè il ripetersi dell’attività produttiva al livello raggiunto o una sua espansione fino al livello materialmente possibile – con uno sguardo d’insieme. La spesa pubblica, in un quadro come quello che si è instaurato nei paesi economicamente avanzati, nei quali è intervenuta una prima rozza emancipazione dalla miseria preesistente, va dunque decisa a prescindere dalla sua copertura con entrate previste o prevedibili, e in questo senso è “in deficit”!
La conferma della validità della spesa in deficit non sta dunque, sin dall’inizio, nel sopravvenire di un disavanzo, ma, al contrario, nella possibilità di determinare, in una prima fase, un effetto opposto. Infatti solo l’aumento multiplo del reddito, al quale consegue un aumento delle entrate da imposte senza aumento delle aliquote, costituisce la prova che esistono bisogni che il mercato non sa metabolizzare, ma che possono essere metabolizzati da chi non opera al solo scopo di accrescere il valore, ma accetta di limitarsi a soddisfar bisogni. 214
Per cogliere questo elemento chiave della teoria, si deve aver chiaro quello che è stato l’oggetto della controversia tra Keynes e gli ortodossi. Una controversia che fu estremamente chiara al primo, che sintetizzò il dissenso dicendo: “la pratica economica che, secondo me, ci permette di impiegare le risorse disponibili, secondo loro le sprecherà. Come se il non lavoro dei disoccupati potesse essere accantonato!”. 215 Questi ultimi dicevano infatti: quando sopravvengono le crisi, lo stato non può e non deve spendere, perché se lo fa finirà solo col dissipar risorse. Poiché queste sono scarse e sono state dilapidate, ne priverà i soggetti economici che potrebbero usarle oculatamente – cioè le imprese capitalistiche – le quali attuano spese solo quando possono agire per la crescita di cui c’è bisogno. Da qui la favola della maggior efficienza privata rispetto al pubblico. Keynes obiettava: le risorse non mancano, anzi sono diventate abbondantemente disponibili. Se lo stato spende non farà altro che facilitarne il necessario ritorno in circolo, anche se alcuni degli impieghi non risponderanno pienamente alle capacità tecniche che sono state acquisiti nel frattempo. Al contrario, quelli che pretendono di imporne un uso solo in vista di un’ulteriore crescita ne inibiscono i possibili impieghi, perché li subordinano al sussistere di condizioni che, data la relativa abbondanza dell’offerta rispetto alla domanda effettiva e la deflazione che ne consegue, non possono instaurarsi. Insomma il quadro è invertito rispetto alla percezione degli economisti ortodossi, che indubbiamente aveva un senso nell’ormai lontano passato dell’ascesa dei rapporti capitalistici; un senso che, con lo sviluppo, si è dissolto. Al tempo di Keynes, una parte delle risorse esistenti non torna in circolo perché risultano superflue rispetto a quei bisogni che, nell’ambito dei rapporti prevalenti, riescono ad esprimersi come domanda, cosicché il tentativo di impiegarle in un allargamento della produzione di merci determinerebbe un ulteriore crollo dei prezzi (di vendita). Invece di profitti, l’impiego finirebbe col produrre perdite! Occorre dunque consentire ai molti bisogni esistenti, che aspettano solo di calcare la scena come domanda, di esprimersi, per trovare un uso produttivo – anche se non profittevole – a quelle risorse. Pertanto la spesa pubblica non impoverirà la società, bensì l’arricchirà materialmente. E questo accadrà soprattutto se non si punta a reintegrare immediatamente, con simultanei prelievi in entrata, il denaro speso, perché il ritorno in circolo del denaro determinerà un aumento del reddito ed un aumento delle entrate pubbliche, nonostante l’invarianza delle aliquote fiscali. 216 Se invece ogni spesa si accompagnerà ad un aumento preventivo delle aliquote, o all’imposizione del pagamento di un corrispettivo per il valore del bene o del servizio offerto, determinerà una fuoriuscita di denaro dal circolo privato esattamente corrispondente a quello che vi si immette, e dunque non farà fronte al problema della sua mancanza.
Se questa strategia keynesiana si fosse risolta fin dalla prima fase in un deficit, avrebbe dunque subito una drastica confutazione pratica. Mentre se lo stato avesse speso senza condizionare la spesa alla certezza di poter ottenere delle entrare corrispondenti, avrebbe avuto una conferma dell’esistenza di quelle risorse se, e soltanto se, fosse sopravvenuta un’espansione del reddito che, grazie all’effetto moltiplicativo quantificabile attraverso la propensione marginale al consumo 217, sarebbe stata multipla rispetto alla spesa iniziale. Insomma la spesa in deficit, non era altro che una spesa non condizionata dalla disponibilità di denaro e finalizzata a far riferimento alla sola disponibilità delle risorse, e ai bisogni che con il loro impiego avrebbero potuto essere soddisfatti.
La conseguenza di questo approccio, rovesciato rispetto a quello ortodosso 218, fu di ottenere, senza che questo fosse lo scopo perseguito, un aumento delle entrate da imposte – ad aliquote invariate – commisurato al maggior reddito che veniva prodotto. 219 Ma no, obiettano in molti, buttando a mare la teoria del moltiplicatore, se lo stato avesse speso senza badare a coprire i costi avrebbe ovviamente dovuto farlo perché perseguiva lo scopo positivo di realizzare un deficit. Senza deficit la teoria non è credibile! Da qui l’ipotesi della “leggenda”. Ma la chiave di tutto sta proprio nel rovesciamento rispetto all’approccio ortodosso, che – leggendo la crisi nei termini di una penuria di risorse e non di un rapporto contraddittorio con esse – sosteneva la necessità, anche da parte dello stato, di avere una preliminare certezza della copertura delle spese che, di volta in volta, decideva di porre in essere o, addirittura, che esse garantissero una remunerazione positiva. Per Keynes, invece, la penuria costituiva un paradosso, e dunque la soluzione era paradossale: cioè il non condizionare la spesa alla copertura, come intenzione, era ciò che, come effetto, avrebbe garantito – per una fase storica – la copertura.
E’ forse opportuno spiegare l’intera questione con un semplice esempio. Se gli imprenditori non tornano ad utilizzare la forza lavoro che hanno reso superflua con l’innovazione tecnica non inibiscono solo il ripresentarsi della domanda diretta che quella forza lavoro poneva in essere, ma anche la domanda di coloro che producevano le merci destinate a soddisfare i bisogni che si esprimevano in quella domanda. Non essendo più possibile prevedere acquirenti, la produzione dei secondi diverrà superflua per l’effetto indiretto del risparmio di lavoro che ha luogo a monte. A questa prima ripercussione negativa se ne aggiungerà poi tutta una serie di altre, determinate dalla scomparsa dei lavori che venivano trainati dalla prima spesa, che è venuta a mancare. Il reddito complessivo risulterà così decurtato della somma di tutte queste successive contrazioni di domanda e l’attività produttiva si ridurrà in misura analoga, in totale contrasto con le possibilità tecniche esistenti.
Una volta che l’intero processo è intervenuto e la società soffre di un’alta disoccupazione, basta rimettere in moto la spesa iniziale – in settori diversi da quelli nei quali si è manifestata la sovrapproduzione 220 – per innescare la catena di attività che essa si tirava dietro. Per questo, data un’elevata forza lavoro disponibile, la spesa pubblica non si risolveva mai in se stessa, bensì sosteneva la produzione di un reddito multiplo rispetto alla spesa iniziale. E questa moltiplicazione del reddito garantiva una moltiplicazione degli introiti fiscali. Che però non costituiva affatto lo scopo perseguito con l’intervento o la sua condizione. Cosicché non si può dire che il mancato deficit comprovi la non intenzione dello stato di spendere senza copertura della spesa.
Certo c’è uno spartiacque che separa la fase, conclusasi alla fine degli anni Settanta, nella quale a quella spesa è spontaneamente conseguito un aumento del reddito in grado di garantire un ritorno delle imposte tale da coprire i costi sostenuti senza aumento delle aliquote, e la fase successiva, nella quale l’effetto moltiplicativo sul reddito è stato più contenuto, con l’emergere di una divaricazione tra spese ed entrate ad aliquota data .221 Ma questo spartiacque investe proprio il problema della riproducibilità del lavoro salariato e la periodizzazione storica che abbiamo proposto. Fintanto che il reddito cresce con facilità, in conseguenza della spesa pubblica, la società si trova di fronte ad una moltitudine di bisogni insoddisfatti che possono essere soddisfatti limitandosi a riprodurre il lavoro salariato. E si può pensare, come si fece dopo la Seconda guerra mondiale, ad un futuro immediato non contraddittorio di crescita per questo tipo di attività. Vale a dire che la società può procedere modificando solo uno dei momenti del processo riproduttivo; rimuovendo cioè gli ostacoli che si frappongono alle possibilità di manifestazione di una domanda potenzialmente già data, ostacoli derivanti da una prosecuzione della subordinazione di questa all’intrapresa capitalistica. Sostituendo keynesianamente una spesa di reddito alla mancata spesa di capitale, il sistema può tornare ad utilizzare buona parte delle risorse disponibili, incluse quelle che scaturiscono dall’impiego capitalistico. Quando, tra la fine degli anni Settanta e la prima metà degli anni Ottanta, questo meccanismo dimostra di aver dato quasi tutto quello che poteva dare, si arriva finalmente al cuore della possibilità di mantenere o meno una spesa pubblica condizionata dalla sola esistenza delle risorse e dei bisogni da soddisfare. Il keynesismo giunge cioè al suo nocciolo di verità, cioè ad un confronto esplicito con le condizioni storiche della sua validità. Ma siccome questa “verità” è completamente ignota alle grandi masse e ai politici che le “rappresentano”, ed è stata del tutto distorta dagli economisti ortodossi, che continuano a coltivare una descrizione dei rapporti che ignora i problemi connessi con il modo di produrre, il sapere prevalente finisce con mostrare la sua inconsistenza e il keynesismo, che si è avvalso di un Keynes unilateralmente letto, va in crisi.
Se, con un approccio sostanzialmente positivistico, tutta questa complessa evoluzione storica viene risolta nelle sue manifestazioni epidermiche, e il potere dello stato di sottomettere a sé l’insieme del processo riproduttivo viene concepito attraverso improprie analogie con il comportamento del “buon padre di famiglia”, o peggio ancora con quella di “un’azienda” 222, è ovvio che il keynesismo finisce col subire una radicale incomprensione. Ancora peggio per il tipo di lettura che viene proposto da coloro che negano il ruolo storico positivo delle politiche keynesiane, appunto perché, esaurito il ruolo propulsivo di una spesa che fa leva sul moltiplicatore, si può concludere che il capitale abbia deciso di sbarazzarsi dello stato – suo strumento(!) – per ricondurre sotto il suo dominio diretto ogni attività finalizzata a produrre le condizioni sociali dell’esistenza. Veniamo ora all’ultima obiezione.
Lo Stato sociale sarebbe una tarda invenzione USA, poi importata in Europa
Taluni autori si spingono, infatti, fino al punto di asserire che politiche dichiaratamente keynesiane non furono attuate, se non a partire dai primi anni Sessanta negli Stati Uniti di Kennedy e di Johnson e, con qualche ritardo, in Europa. 223
A nostro avviso ci troviamo qui di fronte ad un vero e proprio – ed incomprensibile – rovesciamento della storia, che viene letta con l’ingenuità di chi immagina che i flussi relativi alle mode musicali, dell’abbigliamento e di beni di consumo tecnologici, esprimano immediatamente le più complesse interazioni inerenti alle relazioni produttive. Kennedy e Johnson rappresentano timidi tentativi – peraltro non riusciti! – di importare negli Stati Uniti un modello sociale che si era affermato in Europa già durante la guerra 224 e che, a partire dall’inizio degli anni Sessanta, stava finalmente dimostrando la sua piena validità. Non va dimenticato che all’epoca quel paese si vergognava 225 del suo tasso di disoccupazione, superiore al 5%, che, risultando più che doppio rispetto alla media dei paesi europei, appariva intollerabile. E si affannava in ogni modo a cercare di recuperare il terreno perso, tentando di emulare il Welfare europeo. Non ci si deve far trarre in inganno dal fatto che in quegli anni il reddito pro-capite degli USA fosse ancora sensibilmente più elevato di quello della maggior parte dei paesi europei o che i cittadini europei importassero alcune tipologie di consumo statunitensi. Era infatti ben chiaro che l’Europa stava godendo di un processo di sviluppo più accelerato degli Stati Uniti e che, in qualche modo, gettava le basi di un sistema di soddisfazione dei bisogni superiore rispetto a quello esistente in quel paese. 226
Il keynesismo rimbalza cioè dall’Europa, dove si afferma già nel corso degli anni Quaranta e Cinquanta, negli Stati Uniti, dove, all’inizio degli anni Sessanta, “esplicitamente ispira i programmi di John F. Kennedy.” 227 …Un’influenza che ricadrà anche sul suo successore texano Lyndon B. Johnson che, “seguendo le orme di Beveridge 228, creò Madicare e Medicaid, per fornire una copertura sociale agli anziani e ai poveri”. 229 Come riconobbero molti economisti all’epoca, fu “solo nel 1961 che la Nuova Economia prese il comando a Washington”. 230
Qui non si tratta nemmeno di aderire a questa o quella interpretazione, bensì di recepire le stesse convinzioni soggettive di coloro che agirono in quella fase storica. Come altrimenti si potrebbe leggere la posizione del Senatore John F. Kennedy che, poco prima di diventare Presidente, dichiarava: “dobbiamo sviluppare le nostre risorse naturali, costruire scuole e ospedali, case di ricovero e strutture ricreative e così via. E ciò richiede un intervento pubblico, non semplicemente la soddisfazione personale dei nostri bisogni; richiede che i governi locali, regionali e nazionali facciano fronte alle loro responsabilità. E questa è sempre una battaglia, perché presuppone uno storno di fondi dal consumo privato, che è immediato, al consumo pubblico, che per l’individuo è meno evidente”. E all’intervistatore che insiste chiedendo: “ma come si farà a persuadere la gente a produrre, diciamo, meno televisori o meno lavatrici?” risponde: “penso che le lavatrici e i televisori contribuiscano alla nostra vita. Le lavatrici eliminano grosse fatiche e i televisori sono proprio come una finestra aperta per molte persone. Direi che dobbiamo far capire alla gente che nel settore pubblico vanno fatte certe spese, che questo è uno sforzo che va affrontato. Quello che rimane – tutto quello che il governo non ha necessità di prendersi attraverso il canale fiscale – sarà la gente stessa a decidere in che modo spenderlo: in questo può forse fare un lavoro migliore del nostro. Ma sono assolutamente convinto della necessità di soddisfare il bisogno di servizi pubblici” 231
Nonostante l’encomiabile rovesciamento di priorità politiche e sociali rispetto alle amministrazioni che l’hanno preceduto, con Kennedy siamo ancora molto lontani dal keynesismo di Lord Beveridge, che raccoglie le implicazioni economiche dell’insegnamento di Keynes, e sottolinea la necessità di impostare l’intervento pubblico sulla base, non già del denaro disponibile, ma delle risorse esistenti. Con la “Nuova Frontiera” kennediana ci muoviamo invece nei limiti di un approccio politicistico, che fa propria la tendenza culturale prevalente in Europa senza rovesciare la base economica di riferimento, dimostrando così la propria inferiorità rispetto al primo Welfare europeo 232, del quale ignora la natura produttiva. Insomma Kennedy e Johnson sono molto più vicini al Bismarck del XIX secolo, che al Keynes della metà del secolo XX. D’altra parte, la relazione di una Commissione del Ministero della Salute, dell’Educazione e del Welfare, insediata nel 1971, dichiara esplicitamente: “Con l’adozione nei primi anni Sessanta di un approccio keynesiano alle politiche economiche federali, ci è sembrato di imboccare un sentiero che avrebbe garantito il pieno impiego. Si abbracciò il concetto di un bilancio di piena occupazione e si accantonò l’onere di un equilibrio dei conti…” .233
Né si può sostenere, come fanno altri autori, che le radici del keynesismo debbano essere fatte risalire al New Deal di Franklin D. Roosevelt. Com’è stato giustamente argomentato da Ester Fano Damascelli 234, “..se indubbiamente l’orbita dell’intervento dello stato fu estesa, e l’intensa richiesta politica di misure reflattive spinse il governo ad un coraggioso sperimentalismo, i risultati rivelarono subito le contraddizioni interne dei programmi di Roosevelt e del cosiddetto Brain Trust; contraddizioni non soltanto intellettuali, ma dovute alla incompatibilità di fatto tra i vari obbiettivi di politica economica”. Una valutazione ampiamente condivisa, da posizioni culturali profondamente diverse, da Piers Brendon 235, il quale sottolinea che Roosevelt operò “tagli alla spesa pubblica”, “ridusse le retribuzioni federali”, “puntò al riequilibrio del bilancio pubblico” e, contemporaneamente, “fece abbandonare agli Stati Uniti la base aurea”, favorì il controllo della produzione agricola, avviò giganteschi interventi di risanamento dell’ambiente. E cioè diede corpo a “provvedimenti ampiamente estemporanei, sorprendentemente incoerenti e frequentemente inefficaci”. 236 Cosicché non fu mai possibile anche solo sfiorare il pieno impiego, fino alla Seconda guerra mondiale. 237
In conclusione, nessuna delle argomentazioni con le quali si è cercato di sostenere una periodizzazione storica diversa da quella che abbiamo proposto sembra reggere al vaglio di un’analisi critica. C’è pertanto bisogno di entrare nel merito dell’approccio teorico che ha consentito di procedere a quella particolare lettura della storia, per cercare di cogliere la problematicità dei quesiti ai quali dobbiamo dare risposta.
Note
1. Prima della Seconda guerra mondiale quasi la metà dell’occupazione scaturiva, nei paesi economicamente maturi, dall’industria, mentre oggi meno di un quinto si colloca in quel settore di attività.
2. L’idea che la concorrenza e le liberalizzazioni garantiscano una maggiore soddisfazione dei bisogni e lo sviluppo è un ferro vecchio ideologico ereditato dal XIX secolo, il cui uso ai nostri giorni può solo produrre catastrofi economiche.
3. Questa concorrenza è un fatto oggettivo fintanto che l’offerta complessiva di forza lavoro procede, come sta avvenendo dall’inizio della crisi dello Stato sociale, senza un coordinamento generale.
4. Molti interlocutori, di fronte alla proposta di riduzione del tempo di lavoro per ridistribuire il lavoro necessario tra tutti, reagiscono sostenendo che, in tal modo, si spartirebbe solo la miseria
5. La negazione di questa insoddisfazione da parte dei conservatori, i quali sostengono che i problemi sarebbero causati dal pessimismo di chi non condivide le loro politiche è, ovviamente, parte integrante del conflitto sociale in corso
6. La paga di un giornaliero nel 1870 a Roma era: una pagnotta, un’aringa affumicata, un cucchiaio di olio. Ma sempre a Roma, nel 1945-48, non era raro trovare ancora giovani commessi che lavoravano dieci ore al giorno per un chilo di pane
7. Misura relativa a quasi tutti i paesi europei avanzati
8. Claudio Gnesutta, Introduzione all’economia politica, Carocci Editore, Roma 2005, pag. 29. Altri studiosi sostengono che lo stock di capitale, sarebbe sensibilmente superiore, arrivando fino a quantificarlo al 500% rispetto al prodotto annuo
9. Anche se è indubbiamente diverso. L’annichilimento da fame, da freddo e da malattie, non può infatti essere valutato alla stessa stregua di un’impotenza che, salvo per una parte marginale della popolazione, non si riferisce più alla mancata soddisfazione dei bisogni primari
10. E’ nota la nenia ripetuta in tutti questi anni, secondo la quale avremmo vissuto al di sopra delle nostre possibilità economiche, gravando sulle spalle di qualcun altro, oltre a non tener conto del presunto merito dei migliori. Una nenia che confuteremo ampiamente nelle pagine che seguono
11. Il colpo d’occhio del Circo Massimo, nel 1994 e nel 2003, con centinaia di migliaia di persone che protestavano, è stato indubbiamente mozzafiato. Ma perché mai la tendenza sociale prevalente è subito dopo ripresa, come se quelle masse non fossero scese in campo?
12. La ricerca dello psicologo cognitivista Peter Gordon è stata pubblicata il 20 agosto 2004 sulla rivista on line “Science”
13. In Europa, “alla base del sistema popolare di calcolo, prima della scolarizzazione di massa, c’erano la divisione per due e, se necessario, ancora per due. La gente imparava quindi ad immaginare che cos’è un quarto ed un ottavo, ma non un quinto e un decimo”. Witold Kula, Le misure e gli uomini dall’antichità ad oggi, Laterza, Bari 1987, pag. 275
14. Aleksander R. Lurija, Uno sguardo sul passato. Considerazioni retrospettive sulla vita di uno psicologo sovietico, Giunti Barbera, Firenze 1983
15. E’ paradossale come gli esseri umani si ostinino in genere a rifiutare questi problemi, nonostante scaturiscano dalla loro stessa azione sociale, dimostrando così di aver superato solo in parte il guado che li separa dal restante mondo animale
16. Sul diverso modo di rapportarsi alle grandezze numeriche dei cosiddetti “primitivi” vedi in particolare L.S. Vygotskij e A.R. Lurija, La scimmia, l’uomo primitivo e il bambino. Studi sulla storia del comportamento. Giunti, Firenze 1987, pag. 108 e seg.
17. Sarebbe interessante conoscere la risposta a questo quesito di quel matematico che, posto di fronte ai risultati della ricerca sui Piraha pubblicata su Science, ha detto: “Beh, geneticamente gli uomini sono tutti uguali, e la capacità intellettuale è sempre la stessa; dunque chiunque può imparare a contare, anche se per molto tempo ha vissuto senza conoscere i numeri”. Gianluca Monastra, La matematica è dentro di noi impossibile vivere senza numeri. Intervista ad Alessandro Figà Talamanca, la Repubblica 23 agosto 2004, pag. 15. Forse, se fosse incappato nella ricerca di Lurja, dove si dimostra che “le rappresentazioni di spazio, tempo e numero, non vadano ricercate nelle categorie interiori della vita, ma nella storia concreta della società” (La storia sociale dei processi cognitivi, Giunti Barbera, Firenze 1976) , sarebbe stato più cauto.
18. E’ evidente che per cogliere il senso di questa affermazione si deve avere almeno un’idea approssimativa della storia della occupazione negli ultimi due secoli e rilevare che, spesso, una parte significativa del lavoro possibile non è stata erogata
19. Come cercheremo di dimostrare, si tratta di un soggetto nuovo, perché inserito nel processo riproduttivo attraverso relazioni diverse da quelle che hanno prevalso in passato
20. John M. Keynes, che ha saputo prevedere questa evoluzione, scrisse negli anni Trenta: “Ammettiamo, a titolo di ipotesi, che di qui a cent’anni la situazione economica di tutti noi sia in media di otto volte superiore a quella odierna.” (Misura che è stata ampiamente superata prima dei cento anni.) ….”Sarà un bene? Se crediamo almeno un poco nei valori della vita, si apre la possibilità che diventi un bene. Eppure io penso con terrore al ridimensionamento di abitudini e di istinti nell’uomo comune, abitudini e istinti concresciuti in lui per innumerevoli generazioni e che gli sarà chiesto di scartare nel giro di pochi decenni.” Vedi Prospettive economiche per i nostri nipoti, in Esortazioni e profezie, Garzanti, Milano, pag. 272.
21. Miguel Benasayag, Gérard Schmit, L’epoca delle passioni tristi, Feltrinelli Milano 2004 pag. 40.
22. Per avere un’idea di come questo concetto fosse concreto si veda AA.VV. Die Hoffnungen unserer Zeit, R. Piper & Co., München, 1963. La valutazione di Banasayag e Schmit è stata ampiamente condivisa nell’interpretazione della rivolta delle periferie francesi dell’ottobre-novembre 2005
23. Il testo di Naomi Klein, No logo, ha svolto la funzione di approfondimento di alcuni aspetti di questa nuova situazione di regresso
24. Ma in molti lo sono stati, vedi ad esempio AA.VV., Troppo giovani per la pensione troppo vecchi per lavorare, Atti del Convegno di Milano del 21 febbraio 2003
25. Per una critica a questo approccio culturale si veda il mio Il pensionato furioso. Critica dell’ortodossia previdenziale. Bollati Boringhieri, Torino 2003
26. Un perfetto esempio di questo tipo di recriminazione si trova in Giovanni Palladino, Le pensioni domani si salvi chi può!, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2004
27. Vedi, Pietro Ichino, A che cosa servono i sindacati, Mondadori, Milano 2007
28. Come risulterà chiaro dalle nostre argomentazioni dissentiamo radicalmente dall’ipotesi di Antonio Negri secondo la quale “la ribellione, la sovversione, che si radicano nella necessità dell’antagonismo, costituiscono un processo di atti di liberazione”. Vedi Antonio Negri, Marx oltre Marx, Feltrinelli, Milano 1979, pag. 176. A nostro avviso, esse possono costituire parte di un processo di liberazione, ma anche esaurirsi in se stesse, per l’incapacità da parte di coloro che si ribellano di elaborare un potere alternativo di natura produttiva
29. Dopo aver cacciato il primo governo Berlusconi per i suoi programmi di peggioramento del sistema previdenziale, si è passati, con il governo Dini, all’attuazione di programmi del tutto analoghi. Le recenti vicende della Grecia dimostrano che la pura e semplice ribellione, per quanto vasta, non è in grado di risolvere i problemi che investono la società
30. Ben rappresentata dalla continua sollecitazione alla concertazione e alla coesione
31. E che si era dapprima espresso proprio nel diverso comportamento dei lavoratori giovani dell’epoca
32. A dire il vero quasi tutto è già stato ceduto anche sul fronte previdenziale, con le “riforme” Amato, Dini, Maroni, Damiano e Fornero, cosicché anche su questo versante le speranze sono ridotte al lumicino
33. Fausto Bertinotti, Quindici tesi per il Congresso di Rifondazione Comunista, Liberazione 12.9.2004
34. Un processo che ha investito anche quei paesi, come la Germania e la Francia, che hanno fatto da battistrada
35. Si possono fare tutte le campagne politiche sulla necessità di aumentare salari e stipendi, ma se non si dimostra economicamente come questo aumento è possibile e perché è necessario si finisce col muoversi su un terreno meramente ideologico, che punta solo astrattamente nella giusta direzione, ma senza sapere nulla delle mediazioni sociali indispensabili per compiere i passaggi che sfociano, eventualmente, in quel risultato
36. Come ha ben spiegato Sartre, l’essere in malafede non è affatto sinonimo dell’essere imbroglioni, bensì rinvia alla pretesa di far valere un potere di cui non si è portatori
37. E finisce così nel rifugiarsi in quell’oggetto oscuro che va sotto il nome di “giustizia sociale”
38. Agnes Heller, L’uomo del Rinascimento, La Nuova Italia, Firenze 1977
39. Robin Dunbar, Dalla nascita del linguaggio alla Babele delle lingue, Longanesi & C. Milano 1998, pag. 112
40. Può essere utile richiamare un esempio. Si mostra ad un bambino una confezione di cioccolatini a tubo e gli si chiede: “che cosa c’è dentro?” Il bambino risponderà invariabilmente “cioccolatini”. Poi si toglie il coperchio e gli si mostra che il tubo di cartone, svuotato dei cioccolatini, è stato usato per metterci dentro delle matite. Dopo aver rimesso le matite nel tubo, si informa il bambino che entrerà un suo coetaneo, al quale verrà mostrato il tubo e verrà chiesto di dire che cosa c’è dentro. I bambini più grandi con difficoltà di comunicazione rispondono, come in genere fanno quelli che hanno meno di quattro anni, che dirà che ci sono delle matite
41. Robin Dunbar, ibidem
42. Ciò non vuol ovviamente dire che qualsiasi interpretazione della realtà debba essere accolta. Da qui l’importanza della critica, che insegna a distinguere tra ciò che è socialmente valido e ciò che non lo è, al di là del puro e semplice adeguamento a ciò che è considerato “normale”
43. Nelle versioni peggiori, tutto ciò si accompagna ad un’atmosfera di vaga paranoia, e si sosterrà che si è proceduto a “rigirare” anche ciò che è stato “detto”
44. Un’ottima descrizione delle dinamiche implicite in questo modo di procedere si trova nella prima metà del testo di Styrz, Narcisismo e socializzazione, Feltrinelli, Milano 1976
45. Magari in forme che intendono essere convergenti
46. La rilevanza dei problemi che si accompagnano all’approccio ripiegato su se stesso può essere compresa se si riflette sulla natura del cosiddetto “sciopero bianco”. I lavoratori che praticano questa forma di lotta sospendono la normale interpretazione degli accordi contrattuali ed applicano invece le clausole relative in modo letterale, consapevoli che da questa lettura unilaterale scaturirà un inevitabile sabotaggio del fluire della produzione
47. Riccardo Bellofiore, Ma quale fine del lavoro!, Rifondazione n. 5, 1997, pagg. 26 e seg
48. Come risulterà evidente più avanti, le nostre ipotesi teoriche non convergono affatto con le filastrocche sulla “globalizzazione” e sul “postfordismo”
49. Riccardo Bellofiore, Su Rifondazione e sulla rivista, la rivista del manifesto, n.22, novembre 2002, pag. 72
50. Al punto di determinare il seppellimento della teoria della “fine del lavoro”. Vedi il suo articolo Idee più chiare sull’alternativa, la rivista del manifesto novembre 2003
51. Christian Marazzi, E il denaro va, Bollati Borighieri, Torino 1998, pag. 13
52. Riccardo Antunes, Addio al lavoro?, BFS Edizioni, Pisa 2002, pag. 50
53. Carlo Callieri e Bruno Trentin, Il lavoro possibile, Rosenberg & Sellier, Torino 1997, pag. 31
54. Luciano Vasapollo, La teoria del valore in Marx per l’attualità scientifica della critica al capitalismo, in AA.VV. , Un vecchio falso problema, La trasformazione dei valori in prezzi nel Capitale di Marx, Media Print, Napoli, 2002, pag. 26
55. Elvio Dal Bosco, La leggenda della globalizzazione, Bollati Boringhieri, Torino 2004, pag. 84
56. Alberto Burgio, La leggenda della globalizzazione, L’Ernesto, n. 4, Luglio/Agosto 2004, pag. 82
57. Valentino Parlato, Sciopero, il manifesto, 21 febbraio 2003, pag. 1
58. Bruno Ugolini, I doppi precari metalmeccanici, l’Unità 9 gennaio 2006, pag. 26
59. La trasmissione era L’infedele di Lerner del 30 marzo 2009
60. Nella speranza di non essere fraintesi, ribadiamo che si tratta di qualche sostenitore, e non di tutti! Avversiamo la proposta del reddito di cittadinanza, ma non siamo così ingenui da fare di ogni erba un fascio
61. Si badi bene, non per coloro che incontrano ostacoli ad entrare nel mondo della produzione, ma per tutti
62. Con la conseguenza che anche il lavoro complessivo non avrebbe alcun bisogno di essere riprodotto
63. Jeremy Rifkin, La fine del lavoro, Baldini e Castoldi, Milano 1995
64. Pierre Carniti, Il lavoro è finito, Il Bianco e il Rosso, Roma 1994.
65. Adam Schaff, Occupazione e lavoro, in AA.VV. Rivoluzione microelettronica, EST Mondatori, Milano 1982
66. Dominique Méda, Società senza lavoro, Feltrinelli Milano 1997
67. Ermanno Bencivenga, Manifesto per un mondo senza lavoro, Feltrinelli, Milano 1999
68. Tra i molti testi di De Masi sull’argomento si può leggere: Il futuro del lavoro, BUR Saggi, Milano 1999
69. Benjamin Hunnicutt, Work without end, Temple University Press, Philadelphia, 1984
70. Ulrich Beck, Il lavoro nell’epoca della fine del lavoro, Einaudi, Torino 2000. (Ma il titolo originale era: Il bel mondo nuovo del lavoro.)
71. Che forse hanno letto i titoli, ma non i libri
72. Duole dire che troppo spesso il cosiddetto dibattito politico soffre a priori di questo tipo di problema, perché quasi tutti sono costantemente tesi a classificare ogni presa di posizione con gli schemi e con gli schieramenti preesistenti, sterilizzando qualsiasi elemento innovativo
73. Giovanni Mazzetti, Meno lavoro o più lavoro nell’età microelettronica?, in Lavoro e Non lavoro, Centro Studi e Iniziative per la Redistribuzione del lavoro, Roma 1986
74. Vedi il volume monografico di Nord e Sud sulla riduzione dell’orario di lavoro, Benjamin Hunnicutt – Giovanni Mazzetti, La riduzione dell’orario di lavoro sulle due sponde dell’Atlantico, Marzo-Aprile 1999, pagg. 17-70
75. Alcuni autori sostengono che sarebbe invece l’ipotesi della difficoltà di espandere il lavoro salariato che consentirebbe di semplificare i compiti di chi vuole cambiare la società. Confuteremo più avanti analiticamente un simile assunto
76. Vedi l’Introduzione, al testo di Jeremy Rifkin
77. Per un esempio di questa lettura di destra basta qui ricordare di Renato Brunetta, La fine della società dei salariati. Marsilio, Venezia 1994
78. Non sarà difficile ricordare, a chi ha più di quarant’anni come, negli anni Ottanta, si sostenesse a destra che la classe operaia stava scomparendo, e dunque non poteva più essere presa a riferimento da parte di coloro che pensavano di realizzare un nuovo sviluppo. Una trappola nella quale è caduta anche una parte non insignificante della sinistra moderata
79. Pur avendo scritto molti testi sulla possibilità o meno di riprodurre il lavoro salariato senza mai cadere nella semplificazione della formula “fine del lavoro”, non per questo ho trovato un’accoglienza più favorevole nella maggior parte degli ambienti di sinistra. Per questo credo che si tratti di un problema di inconcepibilità, cioè di incapacità di pensare in modo altro. Una incapacità che si nasconde dietro alla semplificazione che quasi sempre si accompagna alle idee sulle alternative possibili
80. Karl Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica, La Nuova Italia, Firenze 1970, vol. II, pag. 396. Va da sé che, se il capitale riuscisse a compensare illimitatamente questa riduzione al minimo del lavoro dato, con la sistematica espansione di un lavoro alternativo, il marxismo si sarebbe trovato di fronte ad una confutazione pratica. Scrive infatti Marx nelle pagine che seguono quelle appena citate: “Il capitale è, malgré lui, strumento di creazione della possibilità di tempo sociale disponibile, della riduzione del tempo di lavoro ad un minimo decrescente, sì da rendere il tempo di tutti libero per lo sviluppo personale. Ma la sua tendenza è sempre, per un verso, quella di creare tempo disponibile, per l’altro di convertirlo in pluslavoro. Se la prima cosa gli riesce, ecco intervenire una sovrapproduzione, e allora anche il lavoro necessario viene interrotto perché il capitale non può valorizzare alcun pluslavoro. Quanto più si sviluppa questa contraddizione, tanto più viene alla luce che la crescita delle forze produttive non può più essere vincolata all’appropriazione di plusvalore altrui, ma che piuttosto la massa operaia stessa deve appropriarsi del suo pluslavoro.” Senza questo svolgimento contraddittorio delle relazioni capitalistiche, che crea condizioni incompatibili con la pura e semplice preservazione dello stato di cose esistente, ogni tentativo di emancipazione sarebbe, per lo stesso Marx, solo “uno sforzo donchisciottesco”
81. Si prega di notare che “comprendere” non significa, in alcun modo, “aderire”. In questo testo si cerca di comprendere l’ipotesi teorica sottostante alla “fine del lavoro”, pur senza aderirvi
82. Non ci nascondiamo che la possibilità di equivoco è in agguato perfino nelle formulazioni più chiare, appunto perché la comprensione non è un processo che si risolve nel contenuto dell’enunciato, ma è condizionata anche dalle capacità di lettura del centro ricevente. Insomma la comprensione è condizionata a priori dalla possibilità che il ricevente ha di accettare il messaggio all’interno del sistema di pensiero che, in qualche modo, contribuisce a definire la sua stessa individualità
83. Chi non conoscere le profonde differenze tra la vita dell’inizio del XX secolo e quelle della sua fine non può, probabilmente, afferrare molti dei problemi sui quali ci soffermeremo
84. Si può infatti sostenere, come fanno in molti, che le difficoltà sussistono, ma siano di natura accidentale o comunque esteriori rispetto a questo tipo di relazione produttiva
85. Qui concordiamo completamente con Keynes quando, nel 1919, sostiene che, metabolizzando il capitalismo come forma positiva della vita, la società sapeva, “negli inconsci recessi della mente”, ciò che stava facendo nel XIX secolo. Tant’è vero che oggi la maggior parte di noi cittadini del mondo borghese mangia regolarmente, non soffre il freddo, acquisisce una cultura di base e non muore di malattie epidemiche, arrivando mediamente alla soglia degli ottant’anni
86. Come vedremo si tratta di un problema che ha investito anche i paesi in via di sviluppo
87. Il lettore è pregato di notare che la previsione non riguarda tanto il fatto della “sostituzione”, bensì la velocità con la quale essa interviene. Il progresso tecnico distrugge posti di lavoro più celermente di quanto se ne riescano a creare di nuovi
88. Ivi, pag. 15
89. Questo passaggio si trova in decine di documenti redatti da intellettuali e da movimenti di sinistra tra il 1997 e il 2002
90. L’intervento di Bellofiore al Convengo del Partito della Rifondazione Comunista del 15.2.1998. Vedi AA.VV. 35 ore, Editori Riuniti, Roma 1998. pag. 63. Si noti come l’Autore, pur contrastando la locuzione “fine del lavoro”, lo faccia da un’angolazione opposta rispetto a quella di Trentin. Non sarebbe cioè la monopolizzazione del sapere, ma al contrario, la fine del monopolio che spiegherebbe le difficoltà che qua e là si manifestano
91. Sarebbe interessante ricostruire come queste stime di un particolare organismo, di citazione in citazione, siano potute diventare, agli occhi degli avversari della “fine del lavoro”, le stime di “tutti” gli organismi internazionali che studiano i problemi relativi al mercato del lavoro
92. Da parte nostra abbiamo qualche dubbio nell’accettare la stima della Banca Mondiale relativa al 1965. Siamo infatti convinti che all’epoca il processo di disgregazione delle forme di produzione che hanno preceduto il capitale fosse piuttosto limitato. Non a caso l’ILO fornisce una cifra di molto inferiore al miliardo di persone che si muovo nell’ambito del rapporto di lavoro salariato
93. L’essere forza lavoro non comporta affatto la certezza di trovare un lavoro, né più e né meno di come il cercare funghi non comporta la certezza di trovarli
94. Come anche gli economisti principianti sanno, occorre distinguere tra crescita e sviluppo. Vale a dire che, tra l’altro, si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità che, la crescita non costituisca di per sé un indice di sviluppo
95. Bertinotti e Gianni, purtroppo, glissano proprio su questo problema essenziale sostenendo che, se “i dati ci parlano di una crescita del lavoro dipendente o comunque subordinato su scala mondiale,” e dunque rendono “le tesi sulla fine del lavoro del tutto infondate”, “tuttavia (essi convengono che) il mercato del lavoro si tripartisce tra un nucleo sempre più ristretto di lavoratori a tempo pieno e indeterminato, un’area crescente di lavoratori precari, una larghissima fetta di disoccupazione e inoccupazione.” Le idee che non muoiono, Ponte alla Grazie, Milano 2000, pag. 91
96. Non diversi, ovviamente, da quelli di cui dispongono coloro che aggrediscono i sostenitori della fine del lavoro, i quali ostentano una certezza statistica completamente fuori luogo, attribuendo la loro tesi a “tutti gli enti internazionali” che cercano di capire qualcosa sull’andamento del mercato del lavoro
97. Pubblicato a Ginevra nel 1994
98. International Labour Organisation, Year Book of Labour Statistics, 1975, Geneva, pagg. 436/439
99. Nel 2003 l’ILO quantifica i sottoccupati in più di 500 milioni, la maggior parte dei quali guadagnava un salario inferiore ad 1 dollaro al giorno. Sul piano che qui ci interessa va poi notato che l’ILO ha sottolineato che mentre nei dieci anni dal ’93 al 2003 la popolazione giovanile è aumentata del 10,5%, il numero degli occupati relativi alle stesse classi di età è aumentato di appena lo 0,2%
100. Gordon Betcherman, An overview of labour markets World-wide: Key trends and major policy issues, World Bank, New York 2002. Il dato ILO sui 160 milioni di disoccupati nel 2000 è riportato in questo studio. Dati ripresi da Global employment trends 2011, ILO, Geneva
101. Va ad esempio tenuto presente che, per un paese come la Cina, le stime ufficiali parlano di un tasso di disoccupazione di poco superiore al 3,5%, mentre numerose valutazioni critiche parlano di un tasso certamente superiore al 10% e probabilmente vicino al 15%
102. Che la maggior parte dei lavori possa rappresentare un avanzamento rispetto al puro e semplice marcire in una baraccopoli è cosa ovvia. Ma la questione è se essi consentano una vita almeno embrionalmente umana. Una questione che, come vedremo, è strettamente intrecciata con quella della riproducibilità del lavoro salariato
103. Karl Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica, Vol. II, La Nuova Italia, Firenze, 1970, pag. 401
104. Se un soggetto non ricerca l’occupazione in maniera sufficientemente attiva, cioè non ha fatto qualche azione concreta negli ultimi trenta giorni, anche se è disoccupato, il suo stato viene imputato alla sua passività, e quindi non viene conteggiato tra i disoccupati ufficiali. (In Italia si tratta, nel 2006, di ben un milione e centomila persone.) Se poi non si dichiara disposto ad accettare qualsiasi lavoro in qualsiasi posto la sua situazione viene imputata a questa sua rigidità, anche in questo caso con l’esclusione dai disoccupati ufficiali. (Si tratta di altre quattrocentocinquantamila persone.)
105. Per un’approfondita descrizione della precarietà in Italia vedi Luciano Gallino, Il lavoro non è una merce, Laterza, Bari 2007
106. Ma da qualche anno viene ripetuto anche da economisti che nella fase storica precedente si consideravano radicalmente a sinistra
107. Non a caso Marx aveva deciso di dedicare il IV libro del Capitale all’analisi di questo problema. Le sue ricche note preparatorie sono state raccolte in tre volumi pubblicati postumi col titolo di Teorie sul plusvalore, Editori Riuniti, Roma 1980.
108. La natura di questo fenomeno, apparentemente paradossale, verrà approfondita più avanti
109. Secondo Bellofiore, ad esempio, “si saprebbe benissimo che la riduzione del tempo di lavoro necessario a dar luogo ad un data produzione può essere controbattuta … da un’estensione dell’occupazione attraverso l’accelerazione dell’accumulazione di capitale e quindi attraverso l’allargamento della produzione”, con buona pace per Keynes. Riccardo Bellofiore, Ma quale fine del lavoro!, cit. pag. 26
110. La quale costituisce uno degli elementi caratterizzanti dei rapporti capitalistici
111. Va qui notato che buona parte della confusione argomentativa scaturisce dall’incapacità di distinguere il concetto astratto di lavoro, che può essere esteso a qualsiasi tipo di attività produttiva, della quale costituisce un sinonimo, con il concetto concreto, che si riferisce al lavoro salariato e alla produzione di merci. Si tratta di uno degli snodi del percorso riflessivo nel quale quasi tutti si perdono. A cercare di definire coerentemente la differenza tra il concetto generico di lavoro, usato come sinonimo di attività produttiva in generale, e quello concreto, relativo ai produttori di merci e ai lavoratori salariati, abbiamo dedicato i nostri primi libri pubblicati tra il 1986 e il 1993.
112. Una prospettiva che dà la sua impronta alla società in maniera radicale. Vedi la magistrale descrizione di questo stato di cose offerta da Benjamin Hunnicutt, nel suo Work without end, Temple University Press, Philadelphia, 1988
113. Il contrasto tra i conservatori e quella parte della sinistra che si contrappone alla tesi della “fine del lavoro” si incentra così su chi causerebbe quelle distorsioni. Com’è noto i primi sostengono che sarebbero gli stessi lavoratori occupati, con i loro presunti privilegi, ad inibire l’attività dei disoccupati. I secondi sostengono invece che sarebbero gli imprenditori e i percettori di rendite a non far tornare in circolo le risorse, il cui uso spontaneo garantirebbe quel lavoro aggiuntivo
114. Keynes provò dapprima a far leva su questa ovvietà del cambiamento necessario, sostenendo che “non ci fosse ragione per non sentirsi liberi di essere coraggiosi, aperti, capaci di sperimentare e di prendere iniziative, di indagare le possibilità date. Visto che ad ostacolare il nostro cammino ci sono soltanto dei vecchi abbottonatissimi gentiluomini , che vanno solo trattati come un’amichevole mancanza di rispetto e buttati giù come birilli” (1929). Ma poi dovette ricredersi riconoscendo che occorreva “porre in essere una battaglia per sottrarsi ai modi di pensare e ai concetti abituali… Che la difficoltà non riguardava le nuove idee, ma la capacità di sottrarsi alle vecchie”(1936).
115. Delegati dalla divisione del lavoro a fornire, tra l’altro, “spiegazioni” della disoccupazione
116. Gli ostacoli che scaturivano dallo stesso comportamento degli imprenditori, proprio perché non impliciti nelle loro intenzioni, venivano così attribuiti a soggetti altri. Un fenomeno ben conosciuto in psicologia sotto il concetto di esteriorizzazione
117. Pubblicata nel 1820
118. Sia chiaro che, in entrambi i casi, il “nuovo” è cresciuto in coesistenza con buona parte del “vecchio”. Ma non è quasi sempre così?
119. Karl Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica, La Nuova Italia, Firenze 1970, vol. II, pag. 10 e seg.
120. Sul nesso esistente tra la “scoperta” del lavoro produttivo e la nascita dell’economia politica si veda l’insuperabile trattazione di Claudio Napoleoni, in Smith, Ricardo, Marx, Boringhieri, Torino 1970
121. Il concetto di “lavoratore liberato” è incomprensibile all’interno di una sensibilità che concepisce solo il gioco a somma zero. Infatti, il lavoratore “liberato” è un soggetto che, grazie al progresso tecnico, potrebbe continuare a ricevere i mezzi del suo sostentamento senza doverli più produrre direttamente
122. Karl Marx, Lineamenti fondamentali …, vol. II, cit. pag. 10-11. (Corsivi nostri)
123. E che, per questo, si presenta come conquista di una libertà (che però viene ideologicamente concepita come la libertà)
124. Quello dei monopolisti, degli imbroglioni o … dei lavoratori poco flessibili
125. Va qui notato che, per Marx, “la concorrenza non è altro che la natura interna del capitale” (ibidem pag. 17), nel senso che la concentrazione oligopolistica rappresenta già la produzione di forze che si spingono oggettivamente al di là degli stessi rapporti capitalistici, nonostante siano prodotte da questi rapporti.
126. Una categoria concettuale, cara a parte della sinistra, ma fuorviante, che ha cominciato a dilagare dopo il suo uso da parte di Marco Revelli in AA. VV. Appuntamenti di fine secolo, Manifestolibri, Roma 1995
127. Per comprendere questo passaggio storico andrebbero letti i libri di Frederick Lewis Allen, scritti negli anni Quaranta. In particolare Appena ieri, pubblicato in Italia da Longanesi nel 1956. Si scoprirebbe che l’euforia degli anni Novanta non è stata molto dissimile da quella che, negli anni Venti, precedette la rovinosa crisi mondiale
128. I paesi nei quali non c’è alcuna spinta fordista, come la Gran Bretagna, precipitano in una situazione di ristagno ben prima degli altri. Tant’è vero che la crisi inglese prende corpo già nel corso degli anni Venti
129. Lo scritto di Einaudi, Il mio piano non è quello di Keynes, fornisce la chiave teorica essenziale dell’approccio conservatore alla crisi degli anni Trenta
130. Da noi diede ad esempio spazio ad una controversia Einaudi-Agnelli, con il primo schierato su posizioni ortodosse ed il secondo sulle posizione di chi non aveva una gran fiducia sul futuro del lavoro
131. John M. Keynes, Economic possibilities for our grandchildren, in The collected writings, Mac Millan, London 1972, vol. IX, pag. 325
132. Ibidem, pag. 329. Qui Keynes opera una distinzione essenziale tra bisogni primari e bisogni che esprimono una libertà nuova. Su questa distinzione torneremo più avanti. Egli, tuttavia, non introduce apertamente quella distinzione fondamentale che troviamo in Marx, quando sottolinea che il lavoro stesso è la mediazione attraverso la quale soltanto i salariati possono acquisire le condizioni della loro stessa esistenza.
133. John M. Keynes, The general theory of employment, interest and money, Mac Millan, London 1964. pag. 164. Testo tra parentesi aggiunto
134. Nel sistema teorico di Marx queste due diverse determinazioni del denaro, corrispondenti ai diversi rapporti che si esprimono attraverso la sua spesa, giocano un ruolo centrale
135. Il fondo che alimenta la creazione di lavoro
136. Karl Marx, Lineamenti fondamentali…, cit. vol. II, pag. 171
137. Scuola, casa, sanità, trasporti, ecc.
138. Op. cit. Pag. 69
139. OCSE, Employment outlook, Paris, 1993.
140. Vedi lo scritto di Lunghini in AA.VV., Disoccupazione e lavori socialmente utili, Manifestolibri, Roma 1995. Se l’affermazione in questione non viene considerata come una mera metafora, lo stato di cose in questione corrisponde all’anticipazione di Marx nei Grundrisse: “… nella misura in cui si sviluppa la grande industria, la creazione della ricchezza reale viene a dipendere meno dal tempo di lavoro e dalla quantità di lavoro impiegato che dalla potenza degli agenti che vengono messi in moto durante il tempo di lavoro…”. Karl Marx, Lineamenti fondamentali …, cit. vol. II, pag. 400. Un aspetto sul quale i critici della teoria “fine del lavoro” sorvolano tranquillamente
141. La forza di questa tesi all’epoca non va sottovalutata appunto perché essa non era solo accademica. Si veda il testo di Rifkin per un’attenta ricostruzione di come il Congresso USA approvò una riduzione della giornata lavorativa a trenta ore settimanali, e solo in un secondo momento il governo ripiegò su una parziale adesione ai suggerimenti keynesiani, con il New Deal
142. Che pochissimi anni prima si era attestato sulle otto ore giornaliere
143. Coloro che vogliono approfondire alcune delle implicazioni teoriche di questa distinzione concettuale possono far riferimento ai numerosi testi sulla necessità di ridistribuire il lavoro che abbiamo pubblicato in passato
144. Keynes non usa quasi mai apertamente il concetto di lavoro salariato. Ma in Prospettive economiche.., afferma che “coloro che si vendono in cambio dei mezzi di vita” non sapranno “godere dell’abbondanza quando verrà”. Ora è ampiamente noto che la definizione di lavoro salariato è appunto riferibile solo a coloro che “si vendono (perché costretti a farlo) in cambio dei mezzi di vita”.
145. Si noti la perfetta coincidenza con la tesi di Lunghini, che però, con la sua proposta dei lavori socialmente utili o concreti, non trae le stesse conclusioni del Keynes delle Prospettive economiche per i nostri nipoti
146. Vedi il nostro La fine dello Stato sociale?, in AA.VV. Ai confini dello Stato sociale, Manifestolibri, Roma 1995
147. Quando fanno qualche incidentale riferimento a date storiche chiamano inspiegabilmente in causa una “fase fordista”, che avrebbe avuto inizio nel 1960 (!) e si sarebbe conclusa nel 1973. Vedi Riccardo Bellofiore, Ma quale fine del lavoro!, cit. Pag. 26
148. Riccardo Bellofiore, Interne contraddizioni, in la rivista del manifesto, 26 marzo 2002. Ma nel 1995, in Lavori in corso per ‘Appuntamenti di fine secolo’, aveva già sostenuto che “la fase fordista, o come la si voglia definire, appare sempre più come una parentesi nella storia del capitalismo”. Politica e economia, n. 6, 1995. pagg. 78-87. Questa lettura, paradossalmente, converge ampiamente con quella di destra, la quale sostiene che “ci volle del tempo prima che si realizzasse” che “i trent’anni gloriosi era un’eccezione”. Vedi tra gli altri Daniel Cohen, The misfortune of prosperity, MIT Press, Cambridge Mass. 1995, pag. X.
149. Karl Marx, Il capitale, Libro Primo, vol. 1, Editori Riuniti, Roma 1972, pag. 187
150. Non procediamo qui ad una ricostruzione storica del modo in cui il rapporto di lavoro salariato è giunto alla sua forma matura. Invitiamo i lettori frettolosi a far riferimento al testo di Marx Lavoro salariato e capitale. Quelli che hanno più tempo e più voglia possono invece trovare ricchi spunti nel Capitale, nei Lineamenti fondamentali, oltre che in Miseria della filosofia
151. In merito si può convenire con la datazione di Polanyi, che fa risalire al 1833 il momento di svolta per l’Inghilterra
152. Il “trionfo” della borghesia è senz’altro da collocare nella seconda metà del secolo XIX. Vedi di Eric J. Hobsbawn, The age of capital 1848-1875, Weidenfeld and Nicolson, London 1975. (pubblicato in Italia da Laterza con il titolo di Il trionfo della borghesia, Bari 1976)
153. Per comprendere l’annotazione occorre saper logicamente distinguere un impiego della forza-lavoro che interviene come mezzo per l’accumulazione, e un suo impiego attuato come fine, cioè per la soddisfazione dei bisogni che garantisce. Ciò che corrispondere alla differenza tra una spesa di denaro come “capitale” e una spesa di denaro come “reddito”
154. Qui il concetto di “umanità” non ha una funzione valutativa, bensì meramente descrittiva
155. Seppure con significative differenze, anche Ernesto Screpanti si colloca su questo versante.
156. “Sono persuaso che del capitalismo esistano molte variati, e che dentro il capitalismo sia (stato) talora possibile con il conflitto conquistare modi più civili di consumo e convivenza (aumenti di salario, riduzione dell’orario di lavoro, beni e servizi forniti in natura dallo stato), e che questo non sempre e non necessariamente confligga con la forma capitalistica di produzione e di società”. Riccardo Bellofiore, Con Keynes e oltre Keynes, La Rivista del manifesto, n. 30, luglio-agosto 2002. Ma Marx, come abbiamo visto, procede sulla base di convinzioni profondamente diverse, sottolineando che se l’intervento pubblico è sistematicamente finalizzato a soddisfare grandi bisogni sociali e a creare le infrastrutture di base, modifica la base della produzione. Così come la riduzione generalizzata dell’orario di lavoro comporta l’imporsi “dell’economia della classe lavoratrice” contro quella del capitale. Si tratta cioè di cambiamenti che contraddicono la forma capitalistica di produzione e di società. Anche un bambino viene concepito “dentro” ad una madre. Ma questa sua collocazione confligge con gli svolgimenti successivi del suo essere che segue il parto, e se non sa corrispondere a questi è destinato a soccombere. Il lavoro salariato, nato nel “grembo” del capitale”, può cioè diventare soggetto produttivo solo se impara a fare quello che il capitale non sa fare.
157. Nel formulare questa valutazione il nostro autore si trova in buona compagnia, visto che anche Giafranco La Grassa, in uno dei suoi ultimi lavori ha sostenuto: “Se si afferra il concetto secondo cui i rapporti capitalistici sono principalmente (non esclusivamente, è ovvio) strutturati dal conflitto di strategie tra dominanti, portato fin dentro la sfera economico-produttiva, non vi è alcuna difficoltà nel comprendere come tale forma di società goda ancora di buona salute …”. Gianfranco La Grassa, Gli strateghi del capitale, Manifestolibri, Roma 2005, pag. 131
158. Fa testo un nostro scritto, Perché Keynes?, del 1975 pubblicato a cura dell’Istituto di Politica Economica diretto da Federico Caffè, ripreso e sviluppato nella maggior parte dei lavori successivi. Ci preme sottolineare che in questo non ci siamo scostati certamente dalla periodizzazione proposta all’epoca dallo stesso Caffè, che dissentiva con i nostri dubbi sulle prospettive future del keynesismo, ma non sul suo ruolo passato. Si veda la sua Introduzione a AA.VV. L’economia della piena occupazione, Rosenberg & Sellier, Torino 1979
159. Per noi la risposta è intervenuta “dal basso”, oltre che “dall’alto”. Vale a dire che il bisogno di cambiamento ha investito la società nel suo complesso
160. Riccardo Bellofiore, Keynes oltre Keynes, la rivista del manifesto, n. 2 gennaio 2000
161. Si veda l’introduzione del ’57
162. John M. Keynes, The general theory…., cit. pag. 106. (Corsivo nostro)
163. Secondo la quale qualsiasi produzione trova sempre i suoi acquirenti
164. Per i conoscitori di Marx, sarebbe una produzione di valori d’uso e non di valore. Vale a dire che la contraddizione che Marx pensa di rinvenire nella forma merce del prodotto non sussisterebbe
165. Tant’è vero che il valore d’uso del prodotto non è tale per il produttore, ma lo è solo per l’eventuale acquirente. La cui esistenza, fino all’affermarsi del keynesismo, è però lasciata al caso
166. Ad esempio scegliendo i settori nei quali procedere alla spesa, attraverso un “piano”, o consentendo un consumo possibile, anche se corrispondente solo alla piena utilizzazione della forza lavoro e della capacità produttiva
167. Certo nel flusso circolare che lo unisce agli altri. Da qui il bisogno di una “teoria generale” del sistema economico, che Keynes elaborò nel 1936
168. Non a caso nel 1925 Keynes pubblica un bellissimo saggio intitolato: La fine del laissez faire per dimostrare la necessità di questa evoluzione
169. Anche se con il credito al consumo il capitale cerca di affrontare il problema, senza riuscirvi in modo risolutivo. Come dimostrano i crescenti contributi statali alla rottamazione di questo o di quel bene di consumo
170. Cioè di quei rapporti sociali di produzione
171. John M. Keynes, The economic consequences of the peace, in The collected writings, vol. II, pagg. 11/13, MacMillan, London 1972
172. Ivi, pag. 373
173. Leggi “dovuto solo a se stessi”, cioè autonomo
174. Riccardo Bellofiore, Marx rivisitato…, cit. Pag. 64
175. Ibidem
176. Daniel Cohen, op. cit. pag. 75. (Corsivi nostri)
177. Il lettore è pregato di tener presente che l’indice dei prezzi tra il 1920 e il 1960 rimane sostanzialmente compreso tra il 200% e il 250%, partendo da un valore 100 del 1840, cosicché il grafico esprime approssimativamente, per quel quarantennio, l’andamento reale del salario orario
178. Va notato che, per il capitale, il consumo dei propri lavoratori è per sua stessa natura improduttivo ed appare solo come un costo, da contenere al minimo
179. Riccardo Bellofiore, Marx rivisitato: capitale, lavoro e sfruttamento, Trimestre 1-2, 1996, pag. 64.
180. Basta andarsi a leggere, nel volume XXIX delle opere complete, il capitolo introduttivo che Keynes aveva previsto nella prima stesura della Teoria generale, per rendersi conto di ciò
181. Da qui il concetto non analitico, ma efficace, di Rifkin, relativo al consumo come “vizio”
182. Jean B. Say sostiene, a inizio Ottocento, che “l’offerta crea sempre la propria domanda” formulando quello che Keynes considera come il fallace paradigma sottostante all’economia ortodossa, che prevale per tre quarti di secolo contro Marx
183. Che il capitale nutra talvolta dubbi su se stesso – cioè sulla propria capacità di continuare sulla vecchia strada – è dimostrato, ad esempio, dalla convinzione di Agnelli nonno che, per far fronte alla Grande crisi si dovesse procedere ad una drastica riduzione dell’orario di lavoro. Ma anche dalla convinzione del nipote Avvocato, espressa in una lunga intervista a la Repubblica nel 1985, nella quale sosteneva che non ci potesse essere altra via d’uscita ai problemi occupazionali, determinati dallo sviluppo tecnologico, che quella dei pensionamenti anticipati di massa a carico del sistema previdenziale pubblico
184. Anche con i governi laburisti, che si rifiutarono di imboccare la via indicata da Keynes
185. Non a caso la reazione neoliberista, a partire dagli anni Ottanta del XX secolo, è sfociata nel recupero di un insostenibile concetto di “disoccupazione naturale”!
186. Si leggano gli splendidi articoli di Keynes sulla “Povertà nell’abbondanza”, in Esortazioni e profezie
187. Bellofiore coglie questo aspetto, quando sostiene che “quel miracolo capitalistico nacque sulla base di determinate condizioni istituzionali, costruite dalla politica” (vedi Keynes oltre Keynes, cit.) ma non riconosce che proprio Keynes sottolineava la contraddittorietà di questo modo di procedere. (Si veda John M. Keynes, Il dilemma del socialismo moderno, in L’assurdità dei sacrifici, Manifestolibri, Roma 1995.)
188. Una delle migliori descrizioni di questo passaggio – purtroppo non intrecciata alla tematica economica – la dobbiamo a Norberto Bobbio, in L’età dei diritti, Einaudi Torino 1990
189. R. Delorme e C. André, L’Etat et l’economie, Editions du Seuil, Paris 1983
190. Daniel Cohen, op. cit., pag. 70.
191. Si noti che qui Keynes non parla affatto di aumento degli investimenti, in piena coerenza con la nostra lettura del suo pensiero
192. Nel concetto di “maggior reddito” il ruolo del consumo risulta essenziale, appunto perché, a differenza dell’accumulazione del capitale, che può garantire una soddisfazione dei bisogni solo subordinatamente alla crescita del valore, si riferisce ad una soddisfazione immediata dei bisogni
193. John M. Keynes, The general theory…., Mac Millan, Cambridge, 1964, pag. 326
194. C’è forse qualcuno che ricorda in che modo la sinistra italiana assumeva involontariamente una posizione antikeynesiana insistendo, negli anni Settanta ed Ottanta, sul fatto che il problema principale fosse quello di espandere la base produttiva, accettando sacrifici crescenti?
195. Paul Samuelson, Economics, MacGraw & Hill, New York 1964, pag. 216
196. Che per tutto il ventennio postbellico è stato definito come new economy!
197. Una tesi esplicitamente avanzata da molta parte della sinistra, la quale ha sempre considerato “l’intervento statuale solo come complementare all’economia privata”
198. I conoscitori dei testi di Marx potranno far riferimento a quella parte delle Forme economiche precapitalistiche (nei Lineamenti fondamentali vol. II) nella quale viene delineato il processo di trasformazione su una base data ed il processo di trasformazione della stessa base, che il susseguirsi dei cambiamenti determina
199. Vedi ad esempio Riccardo Bellofiore, Keynes oltre Keynes, la rivista del manifesto, n. 2, gennaio 2000
200. I dati relativi agli altri paesi sono ovviamente diversi, dato il diverso grado di sviluppo, ma esprimono tutti una tendenza analoga – in direzione, se non in misura – nei rapporti distributivi tra le classi sociali
201. Il salario appariva agli imprenditori come una variabile “indipendente” perché non dipendeva più dalle loro decisioni
202. Guido Carli, Intervista sul capitalismo italiano, (a cura di Eugenio Scalfari) Laterza, Bari 1977, pag. 57.
203. Vedi in merito Tiziano Cavalieri, Pierangelo Garegnani, Meri Lucii, Anatomia di una sconfitta, la rivista del manifesto, marzo 2004, pagg. 44 e seg.
204. Vale forse la pena di richiamare i diversi momenti storici con le parole di un osservatore attento dei nostri giorni. Scrive infatti in un suo editoriale Eugenio Scalari: “Cinquant’anni fa chi avesse voluto dare un’immagine geometrica della società dal punto di vista della curva dei redditi e della distribuzione della ricchezza, avrebbe disegnato una piramide: al vertice i ricchi, nella sezione mediana i più agiati e più si discendeva più reddito e ricchezza diminuivano in proporzione all’aumento del numero delle persone. Infine, alla base, la moltitudine dei poveri. Trent’anni dopo la figura geometrica era notevolmente cambiata: non più la piramide ma piuttosto una trottola. Il vertice e la base, cioè i ricchi e i poveri, relativamente pochi di numero; in mezzo la pancia della trottola, il grosso della società, la moltitudine del ceto medio addensata intorno ad un reddito e ad una ricchezza media. … le uscite verso il basso sono diventate più numerose di quelle verso l’alto. In altre parole si può dire che la trottola si sta afflosciando.” Tutte le fratture che lacerano il mondo, la Repubblica 12 dicembre 2005
205. Desumibile dalle rilevazioni della Banca d’Italia, sulla distribuzione personale del reddito. Nella vastissima letteratura sulla distribuzione del reddito a livello europeo troviamo sia conferme della posizione che qui abbiamo esposto (vedi ad es. A.B. Atkinson, The economics of inequality, Clarendon Press, Oxford 1975, pag. 52, ed anche D.G. Champernowne, The distribution of incombe between persons, Cambridge University Press, 1973, pagg. 45/49), sia rilievi opposti (vedi ad es. T. Stark, The distribution of personal incombe in the UK 1949-1973)
206. Con un marcato ritardo da parte degli USA, come sottolineato da Gabriel Kolko in Ricchezza e potere in America, Einaudi, 1970
207. Roberto Convenevole, Processo inflazionistico e redistribuzione del reddito, Einaudi Torino 1977, pag. 268
208. Si noti che la formulazione è quanto mai ambigua. Come vedremo più avanti, si deve infatti distinguere una prima fase del keynesismo, nella quale le entrate da imposte crescevano senza che aumentassero le aliquote fiscali, da una fase successiva, nella quale questa crescita delle entrate ad aliquota data si blocca, e si pretende di porre rimedio a questa “crisi fiscale” con un aumento delle aliquote, negando però in tal modo la teoria keynesiana, che attribuiva all’aumento delle aliquote un ruolo recessivo. Se lo stato preleva dai redditi per finanziare la spesa, incide negativamente sulla domanda privata e, al massimo, con gli esborsi può riequilibrare questo effetto negativo. Se si crede che questo prelievo abbia comunque contribuito alla crescita si rafforza la nostra ricostruzione teorica, lasciando intendere che i mancati investimenti avrebbero dovuto essere sostituiti, piuttosto che integrati, dalla spesa pubblica
209. Che ignoravano il problema sociale delle mediazioni sociali che, di volta in volta, rendono possibile la produzione
210. Con gli istituti di credito che, a loro volta, restringevano i finanziamenti
211. Più avanti, nel capitolo XIX, spenderemo qualche parola per spiegare più semplicemente il senso di questa essenziale conquista keynesiana, che era già stata anticipata da Marx
212. La controversia relativa alla natura del denaro, sulla quale ci soffermeremo nella parte conclusiva, si riferisce proprio a questo problema
213. Vedi John M. Keynes, L’assurdità dei sacrifici, Manifestolibri, Roma 1996
214. Il problema teorico sottostante a questa asserzione verrà analizzato più avanti, quando si parlerà della crisi dello Stato sociale
215. John M. Keynes, Democracy and efficiency, in The Collected writings, Macmillan, London 1974, vol. XXI, pag. 499
216. Si osservi come l’autore sopra citato glissi, astutamente, sulla differenza che passa tra la prima fase del keynesismo, nella quale l’aumento delle entrate da imposte fu determinato da un aumento del reddito, dalla seconda fase, nella quale, sopraggiunta la crisi, si cercò ingenuamente di porvi rimedio con un aumento delle aliquote. Per avere una chiara idea della critica keynesiana occorre riandare a National Selfsufficiency, uno scritto di Keynes del 1933, tradotto in Italia all’epoca con il titolo di Autarchia economica. (Vedi, John M. Keynes, La fine del laissez faire, a cura di Giorgio Lunghini, Bollati Boringhieri, Torino 1991, pagg. 87 e segg.)
217. Qui è possibile qualificare e quantificare il sostegno che il consumo ha dato allo sviluppo
218. Non a caso, nella Costituzione italiana, troviamo sia lo zampino del trionfante keynesismo con l’art. 4, che quello dei suoi avversari, con l’art. 81, chiaramente ispirato dagli einaudiani
219. Bellofiore aveva dunque radicalmente torto nel momento in cui riteneva, venti anni or sono, che le spese keynesiane sarebbero state giustificate solo se in grado di “autofinanziarsi”, cioè di spuntare il proprio equivalente. Vedi R. Bellofiore, L’ombra del futuro, in Quaderni Piacentini, n. 15 1984, pag. 68.
220. Non a caso Keynes distingue i campi dell’attività produttiva pubblica e di quella privata, esplicitando il bisogno di una programmazione da articolare individuando una gerarchia dei bisogni
221. Un fenomeno che consentì, all’epoca, come vedremo più avanti, di parlare di una “crisi fiscale dello stato”.
222. Com’è noto, dalla metà degli anni Ottanta, per rappresentare la società è cominciata a dilagare l’orrenda locuzione “azienda Italia”. Si voleva in tal modo esprimere un tentativo ideologico di superamento del keynesismo che veniva ignorantemente accostato alle pratiche esistenti nella fase dell’assistenzialismo bismarckiano
223. In qualche caso c’è un po’ di confusione sull’intersecarsi dei vari periodi come in Andrea Fumagalli, Lavoro, vecchio e nuovo sfruttamento, Tascabili Punto Rosso, Milano 2006, pagg. 25-27. Anche Alan Minc, nel suo recente libro Diavolo di un Keynes, UTET, Torino 2008, avanza esplicitamente questa tesi (pag. 230)
224. Com’è noto il Welfare moderno si fa risalire al Piano Beveridge, elaborato a partire dal 1942
225. L’egemonia dello Stato sociale europeo si mostra anche attraverso questa mediazione che trova un’eco chiarissima nel progetto di “Grande società” prospettato da Johnson
226. Una ripetizione in chiave completamente diversa di quella emulazione, negli anni Ottanta, si ebbe con l’introduzione del Just on time giapponese
227. Daniel Cohen, The misfortune of prosperity, cit. Pag. 70
228. Ma a nostro avviso più quelle di Bismarck
229. Si trattò in verità di un’imitazione molto timida del sistema inglese, visto che trent’anni dopo l’intera questione dell’assistenza sanitaria di base era del tutto aperta e lo stesso Clinton fallì nel realizzare ulteriori passi avanti
230. AA.VV., Keynes: updated or outdated?, Edited by M. Marshall, Lexington, Mass. 1970 pag. 112
231. Henry Brandon, Intervista a John F. Kennedy, The Sunday Times, 3 luglio 1960. Per la versione italiana vedi, Il Venerdì di Repubblica, n. 546 pag. 106
232. Su questo problema dovremo necessariamente tornare più avanti quando affronteremo la questione dei limiti del lavoro salariato
233. Work in America, MIT Press, Cambridge, Massachusetts. Ottava Edizione 1980. pag. 156
234. Ester Fano, Crisi e ripresa economica nel bilancio del New Deal, in AA.VV., Crisi e piano, Le alternative degli anni Trenta, De Donato, Bari 1979
235. Piers Brendon, Gli anni trenta, Il decennio che sconvolse il mondo, Carocci, Roma 2002
236. Ibidem pag. 226
237. Per chi voglia avere un’idea meno oscura del New Deal si consiglia la lettura, seppur faticosa, di Michael E. Parrish, L’età dell’ansia, il Mulino, Bologna 1995 e di Amity Shlaes, L’uomo dimenticato, Feltrinelli, Milano 2010

